Che ne è dell’Iraq
A due anni dal ritiro degli americani e a dieci dalla caduta di Saddam Hussein, l'Iraq è tornato di fatto un paese in guerra: chi sta combattendo, e perché?
di Elena Zacchetti – @elenazacchetti

Da mesi la stampa italiana e internazionale si occupa dell’Iraq praticamente tutti i giorni, con notizie e trafiletti che si assomigliano: bomba a Baghdad, autobomba in una lontana provincia irachena, attentato a Falluja, e conta dei morti. Notizie del genere si ripetono ormai quotidianamente, ma prese singolarmente mostrano soltanto un piccolissimo pezzo della storia. Nell’ottobre del 2013, per esempio, in Iraq sono state uccise quasi 1000 persone, e molte altre sono rimaste ferite per l’esplosione di autobombe e scontri settari tra sciiti e sunniti. Numeri simili sono stati registrati sia prima che dopo. Più che di singoli attentati e bombe, infatti, in Iraq è ancora il caso di parlare di guerra – per quanto almeno sulla carta la guerra dovrebbe essere finita da un pezzo. I soldati statunitensi, gli ultimi rimasti in territorio iracheno, se ne sono andati nel dicembre 2011; la caduta di Saddam Hussein, il motivo per cui la guerra era iniziata nell’aprile 2003, risale addirittura a 8 anni prima.
Dal 2007-2008 l’Iraq sembrava un problema risolto anche per gli Stati Uniti: l’amministrazione Bush aveva mandato in Iraq uno dei suoi generali più importanti e competenti, David Petraeus, che era riuscito con una strategia innovativa a ridurre le violenze e riconsegnare agli iracheni un paese più stabile e sicuro di quello uscito dalla guerra. Oggi tutto è cambiato – o meglio, è tornato com’era prima del 2007, forse peggio: al Qaida è tornata a controllare parti importanti del territorio iracheno, il governo è diventato sempre più autoritario, le violenze settarie si sono fatte più brutali e la grave situazione in Siria ha complicato il tutto. Oggi l’Iraq è tornato, di fatto, a essere un paese in guerra.
Cose da tenere a mente quando si parla di Iraq
Qualche data e qualche nozione di base, ché la storia recente dell’Iraq è molto complicata.
Primo: l’Iraq è un paese a maggioranza sciita (lo sciismo è uno dei due principali rami dell’Islam, l’altro è il sunnismo, che è anche il ramo maggioritario), ma per tutti i 24 anni di potere di Saddam Hussein gli sciiti sono stati oppressi brutalmente dalla minoranza sunnita al potere, di cui lo stesso Hussein faceva parte. A grandi linee, i tre principali gruppi etnico-religiosi del paese sono: i musulmani sunniti, concentrati nell’Iraq occidentale confinante con Siria, Giordania e Arabia Saudita; i musulmani sciiti, che sono maggioranza nella regione sud-orientale al confine con l’Iran; i curdi, che abitano prevalentemente al nord al confine con Turchia e Iran settentrionale.
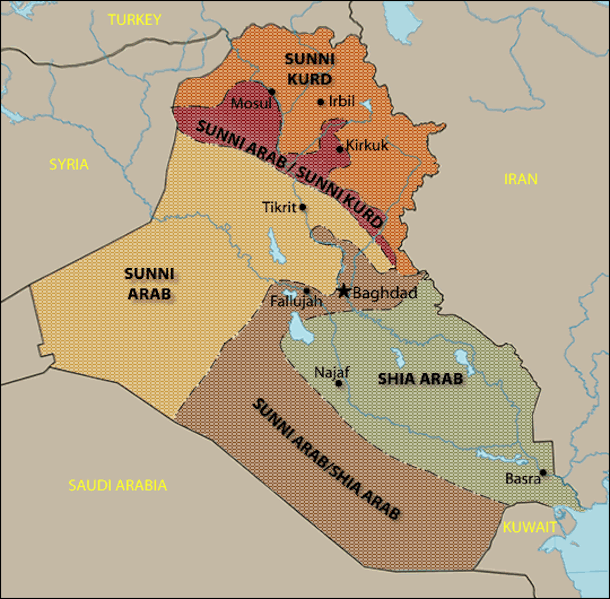
Fonte: National public radio (Npr)
Secondo: la distribuzione del potere tra sunniti e sciiti è cambiata a partire dal 2003, cioè dopo l’invasione dell’Iraq da parte di una “coalizione di volenterosi”, come la definì l’allora presidente statunitense George W. Bush, formata soprattutto da Stati Uniti e Regno Unito. Saddam Hussein era accusato di nascondere e sostenere militanti di al Qaida e di possedere armi di distruzione di massa. Era considerato una minaccia per l’umanità e per destituirlo era stata inaugurata la dottrina della “guerra preventiva”, che consentiva di attaccare l’avversario non solo dopo un’aggressione ma anche in presenza di una minaccia considerata credibile. La guerra intesa con l’obiettivo dichiarato all’inizio dell’invasione, cioè la destituzione di Saddam Hussein, durò solo pochi mesi: il 13 dicembre 2003 le truppe della coalizione catturarono Hussein in un bunker sotto terra vicino a Tikrit, 140 chilometri a nord-ovest di Baghdad, e già nei mesi precedenti i centri del potere dell’Iraq erano finiti nelle mani degli occidentali.
Terzo: dopo la cattura di Hussein in Iraq iniziò un’altra guerra, di fronte alla quale gli Stati Uniti si mostrarono completamente impreparati. L’obiettivo dei soldati americani rimasti in territorio iracheno non era più sconfiggere un regime nemico, ma controllare il territorio e metterlo in sicurezza. Era iniziato un conflitto non convenzionale, difficile da definire e difficile da vincere senza un cambio netto di strategia: i sunniti, parte sconfitta della guerra, avevano iniziato a ribellarsi al nuovo potere in mano alla maggioranza sciita, e a complicare ulteriormente le cose ci si era messo anche il ramo iracheno di al Qaida (anch’esso sunnita, ma il più delle volte in contrasto con i sunniti più moderati) guidato da Abu Musab al-Zarqawi, terrorista giordano di origine palestinese ucciso nel giugno 2006.
Quarto: capire la situazione di quel triennio (2004-2006) è molto importante, perché diverse cose dell’Iraq di allora sono simili alla situazione dell’Iraq di oggi, per forze in campo, instabilità generale, frequenza degli attentati e numero di morti. Le cose diverse invece sono tre: rispetto ad allora l’Iraq ha potuto sperimentare il successo, seppur temporaneo, della strategia della controinsurrezione attuata dal generale Petraeus nel 2007, che prevedeva una maggiore vicinanza e solidarietà delle truppe con la popolazione e che contribuì a ridurre le violenze settarie e il ruolo di al Qaida per almeno due anni; Nuri al-Maliki, primo ministro sciita in carica dalla fine del 2005, ha fatto vedere i suoi lati più autoritari ed è stato accusato da molti di aver fomentato le divisioni settarie per consolidare il suo potere; e poi è iniziata la guerra in Siria, che si è trasformata dopo i primi mesi in un conflitto regionale, che coinvolge in maniera diretta e indiretta praticamente tutti i paesi del Medio Oriente.
Nuri al-Maliki è un altro dittatore?
Con il ritiro dei soldati statunitensi dall’Iraq, il compito di garantire la sicurezza dello stato e l’integrità delle ancora deboli istituzioni democratiche irachene passò alle forze di sicurezza irachene (circa 700mila uomini). Prima di andarsene i militari statunitensi erano riusciti ad addestrarle piuttosto adeguatamente, specialmente grazie all’apertura di accademie militari e alla fornitura di equipaggiamenti di vari tipi. Far funzionare la democrazia però era tutt’altra cosa. Tra il 2011 e il 2012 la stampa internazionale cominciò a scrivere con una certa frequenza delle storture del governo sciita in carica, che avrebbe dominato la politica irachena dopo il ritiro dei soldati americani. Diversi giornalisti ed esperti di Iraq iniziarono a raccontare il progressivo accentramento dei poteri di al-Maliki e la parallela emarginazione dei sunniti dai centri di potere nazionali. Quello che si chiedevano un po’ tutti – CNN, al Monitor, Reuters, National Interest, New York Times, tra gli altri – era: al-Maliki è un altro dittatore?
Al-Maliki aveva già mostrato in diverse occasioni di prediligere un modo autoritario e poco inclusivo di fare politica. Alla fine del dicembre 2011 ordinò l’arresto del vicepresidente del suo governo, il sunnita Tareq al-Hashemi, considerato un politico molto rispettato anche all’estero. Al-Hashemi si dovette rifugiare all’estero – ora vive ad Ankara, in Turchia – e fu condannato in contumacia alla pena di morte con l’accusa di terrorismo. Al-Maliki rafforzò il suo controllo anche sulle forze di sicurezza irachene: scelse personalmente molti dei comandanti dell’esercito, tanto che le forze speciali iniziarono a essere considerate come una “guardia pretoriana”, dal nome del reparto militare dell’Impero romano che svolgeva compiti di guardia del corpo dell’imperatore. Alla fine del 2011 Ramzy Mardini, analista del Institute for the Study of War a Washington, riassumeva così la figura di al-Maliki: «Ci sono due narrazioni dominanti a Washington su al-Maliki. Alcuni dicono che è un nazionalista, altri che è un burattino nelle mani dell’Iran». Sono entrambe semplificazioni, aggiungeva Mardini: «Maliki è un “malikiano”. La sua religione è la chiesa della sopravvivenza».
Il 26 agosto 2013 la Corte Suprema dell’Iraq ha annunciato di aver annullato una legge precedente approvata dal parlamento iracheno, che limitava a due il numero di mandati per il portavoce del Parlamento, il presidente e il primo ministro. Secondo questa legge al-Maliki non avrebbe potuto ripresentarsi per la carica di primo ministro – il suo secondo mandato è iniziato nel 2010 e scadrà nel 2014, anno delle prossime elezioni parlamentari. Al-Maliki ha già annunciato di avere intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato.
Cosa c’entra l’Iran con al-Maliki e il governo iracheno?
C’entra perché al-Maliki iniziò presto ad essere un problema – specialmente per gli americani – anche per il suo rapporto di subordinazione al governo iraniano. Sulla base della dottrina della “guerra preventiva” e dell'”esportazione della democrazia” invocate dall’amministrazione Bush, gli Stati Uniti erano intervenuti in Iraq per destituire un governo sunnita, consegnando così il potere alla maggioranza sciita. Dal 1979 però, dall’anno della rivoluzione islamica in Iran, il Medio Oriente per gli americani era diviso, per semplificare, tra paesi a maggioranza sunnita suoi alleati (Arabia Saudita ed Egitto su tutti), e paesi a maggioranza o governati da sciiti suoi nemici (Iran e Siria). Intervenendo in Iraq, gli Stati Uniti avevano dato in mano agli sciiti uno degli stati più importanti della regione: nonostante il governo iracheno sia rimasto negli anni formalmente alleato degli americani, ha di fatto sviluppato una forte collaborazione con l’Iran in diversi ambiti: in quello economico ad esempio, affidando numerosi appalti legati alla ricostruzione post-bellica alle aziende iraniane, e in quello militare, permettendo lo sfruttamento da parte dell’Iran di un corridoio nel suo spazio aereo da usare per trasferire armi alla Siria di Bashar al Assad.
L’influenza iraniana in Iraq, comunque, non è arrivata da un giorno con l’altro: all’inizio del 2008 Qassem Suleimani – capo delle forze al Quds iraniane, un corpo speciale delle Guardie Rivoluzionarie, incaricate di “esportare la rivoluzione” fuori dai confini iraniani – scrisse un messaggio di testo al generale statunitense David Petraeus, che allora era comandante delle forze americane in Iraq. Il messaggio diceva: «Generale Petraeus, dovrebbe sapere che io, Qassem Suleimani, controllo la politica dell’Iran per quanto riguarda l’Iraq, il Libano, Gaza e l’Afghanistan. Inoltre, l’ambasciatore a Baghdad è un membro delle forze Quds. Colui che lo va a sostituire è, anche lui, un membro delle forze Quds». Dopo la formazione del governo sciita in Iraq, il ruolo dell’Iran è aumentato ancora di più: questo è rilevante perché ha provocato un aumento dell’instabilità interna irachena e un inasprimento delle divisioni settarie tra sunniti e sciiti.
Quello che ne è stato dell’influenza americana e iraniana in Iraq dopo il ritiro dei soldati americani lo ha spiegato efficacemente il fotografo George Packer sul New Yorker in occasione dell’anniversario dei 10 anni dall’inizio della guerra. Packer, che durante il conflitto ha realizzato diversi reportage sull’Iraq, ha scritto:
«Quando gli ultimi soldati americani partirono dall’Iraq poco più di un anno fa, non c’era nessun sentimento di trionfo o soddisfazione, ma solo tristezza e sollievo. L’Iraq è rimasto un paese molto violento. Le sue politiche sono orientate verso l’Iran e verso un più ampio fronte sciita appartenente a un’incombente guerra regionale. Dopo due miliardi di dollari, migliaia di vite americane, e oltre centinaia di migliaia di vite irachene, l’America ha un’influenza in Iraq così limitata che non riesce nemmeno a convincere il governo di Baghdad a impedire il passaggio di armi iraniane attraverso il territorio iracheno dirette ai soldati siriani di Bashar al Assad. L’Iraq ha rigettato il trapianto di organi e va per la sua strada. Immagino che ci siano molte meno tracce lasciate dagli americani a Baghdad rispetto a quante vennero lasciate a Saigon nel 1975»
La guerra in Siria e il ruolo di al Qaida
La guerra civile in Siria iniziò nel marzo 2011. Qualcuno allora la chiamò “primavera araba” e la inserì nell’ampio gruppo di rivolte popolari che avevano portato nei mesi precedenti alla caduta di regimi autoritari decennali in Nord Africa e Medio Oriente, come quello di Ben Ali in Tunisia e Mubarak in Egitto. Gli scontri in Siria, tuttavia, si trasformarono in poco tempo in una vera e propria guerra civile: dopo pochi mesi Bashar al Assad iniziò ad accusare al Qaida di essere responsabile di alcuni attentati che avevano ucciso decine di persone a Damasco. All’inizio in pochi gli diedero retta, poi anche l’Occidente riconobbe che la guerra in Siria si era trasformata da guerra civile tra siriani in qualcosa d’altro, che coinvolgeva milizie straniere sunnite e militanti di al Qaida. Parte di questi estremisti, che combattevano a fianco dei ribelli siriani, proveniva dall’Iraq. Le province irachene di Ninawa e Anbar iniziarono ad essere usate come punto di partenza di incursioni ribelli in territorio siriano.
Le prime fasi della guerra in Siria si sovrapposero alla preparazione del ritiro dei soldati americani dall’Iraq. Dopo che il ritiro fu completato, le province più lontane da Baghdad, come Ninawa e Anbar, rimasero fuori dal controllo del governo centrale sciita di al-Maliki e iniziarono ad essere pian piano riusate come base operativa da gruppi legati ad al Qaida (erano sede di militanti qaedisti anche prima della strategia di controinsurrezione di Petraeus). Qui c’è da fare una precisazione: il ramo iracheno di al Qaida si può considerare “in rotta” con il leader di al Qaida e successore di Osama bin Laden, il medico egiziano Ayman al-Zawahiri. In pratica agisce con una certa autonomia: uno dei gruppi ribelli oggi più forti militarmente in Siria si chiama Stato islamico dell’Iraq e del Levante (ISIS), e fa capo al ramo iracheno di al Qaida: il suo obiettivo principale non è la caduta di Bashar al Assad, ma la creazione di un califfato islamico nella regione, basato sulla sharìa.
Oggi l’ISIS è una forza completamente destabilizzante: negli ultimi mesi in Siria si è messa contro gli altri gruppi ribelli, sia quelli più moderati come l’Esercito Liberto Siriano, sia quelli più estremisti, come le forze appartenenti al Fronte Islamico. In Iraq l’ISIS si oppone sia al governo centrale sciita che ai leader locali sunniti delle province occidentali. A detta di molti esperti è oggi uno dei motivi più importanti dell’instabilità del fragile sistema democratico iracheno.
Cosa sta succedendo oggi nella provincia di Anbar
Tutti i problemi che l’Iraq ha dovuto affrontare negli ultimi due anni si possono vedere oggi in quello che sta succedendo nella provincia occidentale di Anbar. Dall’inizio di gennaio 2014 i militanti dell’ISIS hanno preso il controllo delle città di Falluja e Ramadi, estromettendo di fatto dal potere locale sia il governo iracheno che le milizie sunnite locali. La provincia di Anbar era già stato il cuore della resistenza sunnita nel triennio successivo all’invasione statunitense del 2003: a Falluja, per esempio, nel novembre 2004 si combatté una battaglia di 46 giorni, una delle più tremende dall’inizio del conflitto.
Ad Anbar, durante gli anni della strategia della controinsurrezione di Petraeus, gli Stati Uniti aumentarono la loro presenza militare e cominciarono a collaborare con i leader locali sunniti per combattere congiuntamente al Qaida. La strategia americana, che ebbe risultati positivi nel breve periodo, è stata replicata recentemente dal governo centrale sciita per ottenere gli stessi risultati di allora: l’indebolimento di al Qaida. Al comando centrale nella provincia occidentale di Anbar, hanno raccontato recentemente due inviati del New York Times in Iraq, gli ufficiali dell’esercito iracheno hanno iniziato a consegnare armi e soldi ai leader locali.
Ad Anbar arrivano anche le armi leggere e le munizioni mandate dagli Stati Uniti. L’obiettivo è comune, almeno sul fronte interno iracheno: sconfiggere le milizie qaediste che hanno preso diverse parti della provincia e riportarle sotto il controllo del governo – o in alternativa, se non ci si riesce, delle comunità sunnite locali. Nello specifico, l’amministrazione americana sta inviando missili Hellfire e droni per la sorveglianza di supporto alle forze irachene e ha inoltre messo pressione al Senato affinché approvi la vendita degli elicotteri Apache. Convincere il Congresso però non è semplice: l’ostacolo più grande è legato ai rapporti che il governo iracheno continua a tenere con quello iraniano. Per esempio, il Congresso chiede che l’Iraq adotti le misure necessarie per impedire all’Iran di utilizzare lo spazio aereo iracheno per mandare rifornimenti e assistenza militare al regime siriano di Bashar al Assad.
Per ora la strategia del governo iracheno è finalizzata a contenere la crisi nella provincia di Anbar, ma i più ottimisti credono che si possa estendere a tutto il territorio iracheno per favorire una riconciliazione tra il governo sciita e la minoranza sunnita. La situazione, un po’ da lontano, assomiglia a quello che sta succedendo in alcune parti della Siria: gruppi diversi tra loro avversari, alleanze fluide che cambiano a seconda dell’opportunità di quel momento, e pezzi di territorio in mano a gruppi che per diverse ragioni non sono in grado di assumere dimensioni e poteri nazionali. Intanto gli scontri continuano a frequenza giornaliera, i militanti vicini ad al Qaida mantengono il controllo di Falluja e parti di Ramadi e gli aiuti militari statunitensi, dicono i leader locali, non sono sufficienti per sconfiggere i qaedisti, che sono armati di fucili da cecchino e mitragliatrici montate sui pick-up. Un gran guaio, in poche parole.




