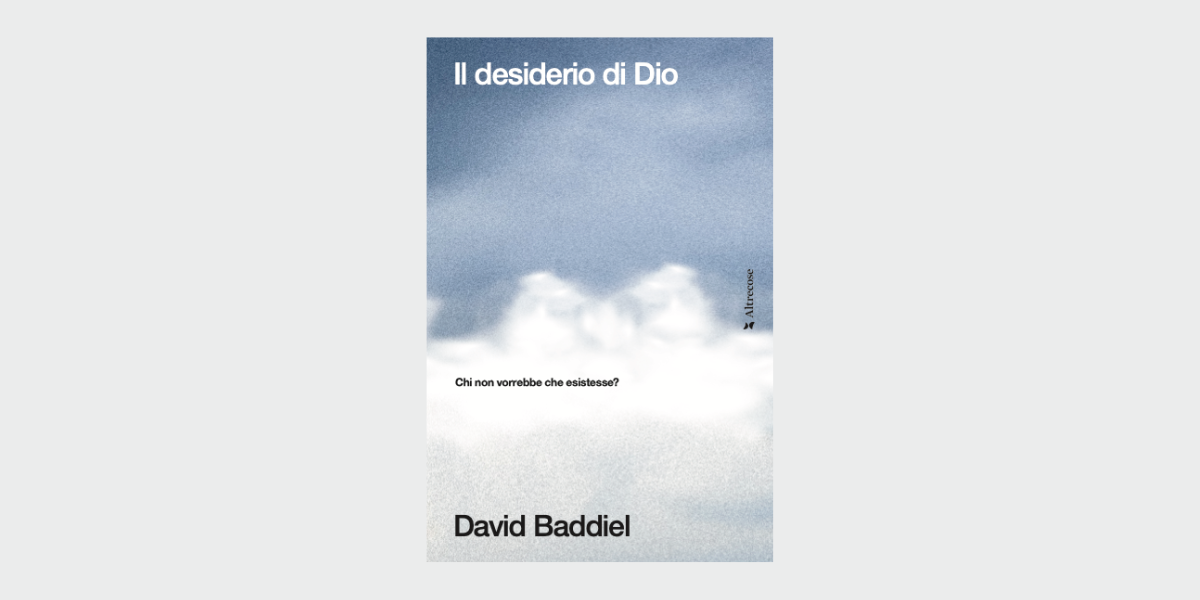Una parola che non si scrive con leggerezza
Le case editrici italiane stanno riflettendo su come usare (e come no) il termine razzista con cui venivano descritte le persone nere
di Ludovica Lugli

«Tradurre un libro americano del 1976 che parla degli anni Trenta del Novecento nel Mississippi, uno stato del Sud dedito alla raccolta del cotone, in cui la schiavitù è storia recente, vuol dire fare scelte che possono anche suonare strane a un lettore del nostro tempo da questa parte del mondo». Inizia così la nota della traduttrice Beatrice Masini che apre l’edizione italiana di Il mio grido è come un tuono, romanzo per ragazzi della scrittrice americana Mildred D. Taylor appena ripescato da Mondadori. Masini continua spiegando alcune delle sue scelte, compresa quella che riguarda un termine molto offensivo, comune negli insulti razzisti:
Poi c’è la questione della parola “negro”. Noi la consideriamo sprezzante, da non utilizzare perché suona come un insulto, ma a quel tempo era di uso quotidiano. Un nero veniva chiamato “negro”, qualche volta “di colore”. Nel tradurre questo romanzo ho rispettato l’originale proprio per far sentire, come vuole l’autrice, tutto il peso di queste parole. “Dopotutto io sono quello che sono e tu sei quello che sei” dice Cassie [la protagonista del romanzo], nera, a Lillian Jean, bianca: la sta prendendo in giro, noi lo sappiamo, ma è proprio quello che Lillian Jean, superba e prepotente, vuole sentirsi dire, e quello che i bianchi (non tutti, ma molti, e la gran maggioranza in questo romanzo) pensano dei neri all’epoca.
Il mio grido è come un tuono non è il primo libro pubblicato in Italia che contenga una nota di spiegazione simile. Negli ultimi anni una maggiore attenzione ai modi in cui la lingua contribuisce a perpetuare stereotipi e pregiudizi, anche razzisti, ha suscitato varie riflessioni anche nel mondo dell’editoria: alcune riguardano questa parola, che fino agli anni Ottanta nei libri era usata per descrivere le persone con la pelle nera, come aggettivo o sostantivo, anche con un’accezione neutra. Compare così, ad esempio, in Atlante occidentale di Daniele Del Giudice, romanzo del 1985.
In un secondo bar, con gli sgabelli alti e una fila di bicchieri appesi capovolti al di sopra del bancone, come campanelle, ascoltarono un negro anziano che cantava seduto con un cappello chiaro, accompagnandosi solo alla chitarra elettrica; cantava senza alcuna concessione al pubblico, quasi con severità, sebbene la faccia fosse come quella di uno che ha preso parte alla storia universale, e ne è uscito con felicità.
A partire dagli anni Novanta tuttavia il significato non offensivo è scomparso dall’uso della maggior parte dei parlanti, per lasciare solo quello connotato come razzista, come peraltro rilevato da una sentenza della Corte di Cassazione del 2006.
Questo cambiamento lessicale è avvenuto sotto l’influenza della cultura e dei dibattiti americani. Negli Stati Uniti si condannava da decenni (e lo si fa tuttora) l’uso di una parola ancora più connotata in modo razzista: “nigger”. Nata in un periodo in cui le persone di origine africana erano schiavizzate e dunque trattate come oggetti, è fortemente legata a questa concezione (presente anche in espressioni italiane come “lavorare come un n.”) ed era considerata offensiva già nell’Ottocento. Oggi viene usata – oltre che dalle persone razziste – da parte degli afroamericani in un’ottica di riappropriazione, ma è molto malvisto che venga scritta o pronunciata dalle persone bianche: per questo nel parlato viene indicata con l’eufemismo “N-word”, “parola che comincia con la N”, e nello scritto può essere censurata usando degli asterischi. Non è più usata nemmeno “negro” (pronuncia “nigro”), a lungo adottata da attivisti per i diritti civili come W.E.B. Du Bois e Martin Luther King in senso neutro, prima di essere sostituita da “black”, “nero”.
Se fino agli anni Ottanta il corrispettivo italiano della “N-word” era usato in libri e giornali con un significato neutro che non risultava stridente a redattori e giornalisti, ed era scelto anche per tradurre molti “black” nei romanzi americani, oggi il suo uso all’interno di testi pubblicati contemporanei è quasi sempre legato all’accezione offensiva. Ad esempio, può essere citata in articoli di cronaca che danno conto di insulti razzisti ricevuti da qualcuno.
Secondo molte persone, in particolare di origine africana, in questi contesti la parola dovrebbe essere censurata con gli asterischi per ridurne l’impatto emotivo: lo scorso ottobre sui social network era stato duramente criticato Maledetta sfortuna, un saggio sulla violenza di genere scritto dalla content creator Carlotta Vagnoli e pubblicato dalla casa editrice Fabbri, perché nel citare due messaggi di insulti rivolti alla comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete, e pesantemente offensivi nei riguardi dei migranti da lei aiutati, non lo faceva.
Federica Magro, direttrice editoriale di Bur e Fabbri, spiega così la scelta che era stata fatta: «Ovviamente non volevamo offendere nessuno, ma ci è sembrato giusto ed editorialmente corretto – in accordo con l’autrice – citare nella sua crudezza quell’espressione per “fotografare” il clima che si era creato attorno alla vittima di quegli insulti, anziché ricostruirlo con un nostro commento». Vagnoli aveva poi risposto alle critiche scusandosi e annunciando che nella successiva ristampa del suo libro le citazioni sarebbero state censurate, come poi è avvenuto.
«Ritengo che nell’uso giornalistico e saggistico sia meglio censurarlo perché riportare il termine per intero non è funzionale a dare un’accezione satirica o anche provocatoria», spiega Nadeesha Uyangoda, l’autrice del libro autobiografico L’unica persona nera nella stanza e una delle voci di Sulla razza, podcast sulla «questione razziale in Italia» e sulle parole da usare (e non usare) per parlarne: «Quando si riporta un virgolettato, l’uso non censurato non aggiunge nulla alla notizia e anche con la censura è chiaro che si tratta di un insulto razzista. Se semplicemente sostituiamo alla G un asterisco, scrivendo “ne*ro”, la violenza della parola è comunque percepita, si capisce a cosa ci stiamo riferendo. Col tempo penso che chi legge imparerà a identificare quel segno grafico e quelle lettere con la parola offensiva, anche se decidiamo collettivamente di non usarla».
L’uso degli asterischi attenua la forza della parola per chi legge e ne è disturbato; allo stesso tempo segnala che chi scrive è consapevole del suo peso e dei significati che si porta dietro, dal razzismo di oggi a quello del passato, che in Italia è legato alle violenze del periodo coloniale spesso dimenticate: rievoca una lunga storia di soprusi che non è ancora finita.
Per Uyangoda tuttavia si possono fare considerazioni diverse in alcuni contesti: «Farei una distinzione tra saggistica pura e romanzi. E anche all’interno della saggistica valuterei comunque l’uso che si fa del termine e il contesto: se è una ricerca accademica, se è un saggio divulgativo, se l’autore o l’autrice è nero o nera».
Nei contesti anglosassoni è socialmente accettato che le persone nere possano usare la “N-word” sia nello scritto che oralmente, che si tratti di riappropriarsi del termine, come hanno fatto moltissimi rapper, o di citarlo per descrivere comportamenti razzisti o criticarli in modo enfatico. Finora ha prevalso quest’uso nei libri di autori italiani neri. È il caso ad esempio del romanzo Negretta. Baci razzisti di Marilena Delli Umuhoza (Red Star Press, 2020), ma anche del saggio Negro. La verità è che non potete fare a meno di noi di Francesco Ohazuruike (Piemme, 2018), che usando dati e statistiche smonta alcune false credenze sugli immigrati di origine africana. «Il titolo è molto provocatorio», dice Ohazuruike, «volevo enfatizzare l’idea che le persone chiamate “negri” sono persone di cui la società ha bisogno. In ogni capitolo del libro parto da una discriminazione che ho subìto, da pregiudizi come quelli secondo cui i negri “rubano il lavoro”, “sono terroristi” o “portano malattie”, per spiegare come stanno le cose in realtà». Ohazuruike usa volutamente espressioni molto dure perché «certe cose non vanno addolcite».
Piemme gli aveva chiesto un titolo forte per il suo saggio e quando lui lo ha proposto nessuno ha fatto obiezioni. Qualcuno però lo ha criticato: un amico senegalese che non ha letto il libro, ma non condivide la scelta fatta per il titolo. Anche Delli Umuhoza è stata criticata per il titolo del suo romanzo da una persona afrodiscendente durante una presentazione: per alcune persone l’intento di denunciare atti di razzismo non giustifica l’uso di una parola che viene percepita in modo doloroso. Anche negli Stati Uniti c’è chi la pensa così, e infatti lo studioso afroamericano Randall Kennedy, professore di diritto dell’Università di Harvard, era stato contestato per aver intitolato un suo saggio del 2002 dedicato alla storia della “N-word” proprio Nigger.
Il caso di Kennedy è emblematico dato che il tema del suo libro era proprio la parola in questione. In Italia si è molto interrogato sull’opportunità o meno di censurarla in un contesto simile il sociolinguista Federico Faloppa, docente dell’Università di Reading del Regno Unito e studioso degli stereotipi etnici e dei cosiddetti discorsi d’odio – nonché uomo bianco. In una nota che apre il suo libro #Odio. Manuale di resistenza alla violenza delle parole (Utet, 2020), Faloppa dice:
Dopo averci pensato a lungo, ho deciso di riportare – nel testo – insulti, ingiurie ed espressioni offensive nella loro interezza e grafia originale, senza censure. È in corso da anni, anche in Italia, un dibattito importante sulla necessità o meno di riprodurre questi termini e questo linguaggio, anche solo a fine documentario, anche solo tra virgolette e in forma di citazione. Questo dibattito, in particolare, riguarda la cosiddetta N-word, per la storia di razzismo, violenza, discriminazione che la parola porta con sé. È una parola che infatti io non pronuncio mai, neppure quando devo riferirmi a essa per criticarne l’uso, per raccontarne – come ho fatto spesso, in questi anni, da linguista – le vicende. Ho imparato infatti che pronunciarla, anche con intenti antirazzisti come durante una lezione o una conferenza in cui ne critico l’uso, può ferire chi mi ascolta. E che malgrado le mie migliori intenzioni può replicare tutta la carica di dileggio e di offesa che essa da secoli veicola. Ciò che in un contesto può apparire “militante” a me, può apparire offensivo ad altre persone. In questo libro tuttavia l’oggetto è la violenza stessa delle parole, e la consapevolezza che ognuno e ognuna di noi dovrebbe avere dell’hate speech, delle sue forme, delle sue conseguenze. Ho scelto quindi, non senza perplessità e fastidio, di riportare nella loro interezza e senza censure esempi e citazioni, proprio per esporre il lettore a tutta la crudezza di certo linguaggio, e per non confonderlo sul fatto che certi termini possano essere stati edulcorati già alla fonte (cosa che non è). So che si tratta di una scelta problematica. E chiedo scusa alle persone che la troveranno inopportuna, se non offensiva. Mi auguro tuttavia che essa non offuschi lo scopo ultimo del libro. E l’onestà intellettuale di chi l’ha scritto.
La questione se usare o meno la “N-word” italiana – che forse si potrebbe chiamare “parola con la G” dato che anche “nero” comincia per N – si è posta negli stessi termini anche per questo articolo, nel quale convivono esigenze molto diverse tra loro: di chiarezza nei confronti dei lettori, di fedeltà nei confronti delle persone intervistate e dei testi citati; di sensibilità rispetto a un termine così connotato e per molti violento. Ho deciso perciò di riprodurla solo all’interno di citazioni di altri testi in cui era stata riportata per intero e nei virgolettati di chi, intervistato, ha scelto di usarla. Ho invece deciso di scrivere esplicitamente per intero, una volta, la “N-word” inglese presumendo un minore coinvolgimento emotivo da parte della maggioranza dei lettori e delle lettrici che leggono e parlano italiano, tenendo conto al contempo che se citata solo parzialmente potrebbe non essere riconosciuta da chi ha meno familiarità con l’inglese. È un compromesso, uno dei molti possibili, e sicuramente ogni persona potrebbe individuarne uno diverso e per lei migliore: anzi, data la rapidità con cui si sta evolvendo il dibattito su questioni come questa, la stessa persona avrebbe forse suggerito compromessi diversi tre anni fa o ne suggerirebbe altri fra tre anni. Ma questi cambiamenti sono proprio la ragione per cui è interessante capire quali diversi orientamenti stanno adottando le case editrici, e cosa ne pensano autori e autrici.
Talvolta alcuni autori ed editori di saggi scelgono di essere espliciti perché i libri di cui si occupano parlano proprio del modo in cui per molti secoli le persone nere e i loro corpi sono stati trattati come merci. È la scelta deliberata fatta dal filosofo camerunense Achille Mbembe in Critica della ragione negra, pubblicato in italiano nel 2019 da Ibis Edizioni con una traduzione fedele all’originale in francese – e pubblicato invece in inglese come Critique of Black Reason.
Un altro caso è quello di Il bianco e il negro. Indagine storica sull’ordine razzista della storica francese Aurélia Michel, pubblicato da Einaudi l’anno scorso, per cui non si può raccontare una storia del razzismo europeo senza passare per le parole usate per trasmetterlo – tra cui la stessa “razza”. La casa editrice ha comunque scelto di censurare il titolo nei post su Facebook che gli ha dedicato.
Un altro titolo che fa caso a sé è quello di un libro pubblicato ormai più di dieci anni fa dalla casa editrice Iperborea, El negro e io dello scrittore Frank Westerman. Riprende fedelmente l’originale olandese che cita un’espressione spagnola: “El Negro” era infatti il soprannome dato al corpo di un uomo africano morto intorno al 1830 che fino al 1997 rimase esposto in un piccolo museo della provincia spagnola, impagliato. Il libro racconta di come Westerman lo vide per la prima volta quando studiava all’università e dell’indagine che fece anni dopo per ricostruirne la storia e al tempo stesso riflettere sui disequilibri di potere storici che resero possibile l’esposizione di un corpo nero in un museo di bianchi.
Emilia Lodigiani, fondatrice di Iperborea che ai tempi si occupò della pubblicazione di El Negro e io, racconta: «In italiano la parola non ha chiaramente lo stesso valore, ma dato che il tema del libro era il rapporto tra neri e bianchi a partire da questa figura, non mi posi il problema di usarla nel titolo – dove peraltro compare come spagnolo, lingua in cui “nero” si dice “negro”. Il titolo presenta in maniera lucida il tema del libro, che è antirazzista ed è pieno di quell’ironia critica che dimostra l’assurdità di certe scelte ideologiche». Lodigiani poi aggiunge: «Io appartengo alla generazione di chi ha letto i libri in cui la parola “negro” non aveva alcun connotato negativo e in passato quello del suo uso mi sembrava un falso problema da noi. Poi ovviamente ci si abitua ai nuovi significati e ora resto scioccata quando è usata».
Nel campo della narrativa, cioè dei romanzi e dei racconti, i criteri generalmente sono diversi e anche Uyangoda ritiene che sia un ambito in cui evitare censure: «C’è lo spazio dell’espressione artistica, lo stesso in cui vengono usate bestemmie o altri termini offensivi. Recentemente ho letto Rattatata di Alfredo Speranza, un romanzo in cui compare più volte la parola “negro” usata da un personaggio razzista nei confronti di persone africane: in quel contesto capisco che sia utilizzata, perché anche nella realtà è utilizzata così, e per quanto all’inizio mi abbia dato fastidio, capisco il senso dell’uso del termine da parte dell’autore».
Per quanto riguarda invece i romanzi stranieri, secondo Uyangoda l’editoria italiana dovrebbe dedicare maggiori riflessioni a come trasmettere alcune parole: «È sintomatico che fino agli anni Novanta “black”, “nigger” e “Negro” fossero tutti tradotti allo stesso modo. Oggi traduciamo “black” con “nero”, ma non abbiamo una traduzione più precisa per “brown” [letteralmente “marrone”, parola usata per indicare il colore della pelle delle persone di origine indiana, bengalese e cingalese, ad esempio] o per altri termini che afferiscono all’alterità».
Un esempio notevole di vecchia traduzione di “black” che oggi probabilmente sarebbe fatta diversamente è quella che riguarda Ragazzo negro, celeberrimo memoir dello scrittore afroamericano Richard Wright uscito nel 1945: il titolo originale è Black Boy, ma anche l’ultima edizione italiana, risalente al 2014 e pubblicata da Einaudi, conserva il titolo con cui il libro è stato sempre conosciuto in Italia. All’epoca la casa editrice decise di fare una nuova edizione senza rinnovare la traduzione, e non volendo emendare quella dello scrittore Bruno Fonzi (1914-1976) risalente al 1947, lasciò il titolo originale. In caso di future riedizioni, dicono in Einaudi, l’editore prenderà in considerazione l’opportunità di commissionare una nuova traduzione.
Oggi i traduttori e le traduttrici dedicano profonde riflessioni a queste questioni, e sempre più spesso le condividono con i lettori. Lo ha fatto ad esempio Anna Mioni, traduttrice di Romantica Marsiglia, un romanzo dello scrittore giamaicano Claude McKay che pur avendo più di 90 anni è stato pubblicato solo da poco perché considerato osceno in passato.
Tra le parole desuete che usa l’autore troviamo Mulatto, Yaller e Negroid, che ora sarebbero ritenute politicamente scorrette, e che invece lui adopera a volte con la maiuscola iniziale. Per le prime due ho scelto il traducente mulatto, che nell’italiano dell’epoca e di quasi tutto il Novecento non aveva intenti dispregiativi. Parlando poi invece delle tonalità della pelle, McKay usa anche ebony, o blackbird. Qui ci si è adattati alla circostanza, non avendo ancora l’italiano una varietà lessicale di uso corrente per restituire tutte queste sfumature.
Mioni ha anche dovuto fare una scelta simile a quella di Masini:
Resta il problema di come rendere le quattro occorrenze più diffuse: Negro (spesso maiuscolo), black, colored e nigger. I personaggi del romanzo, e il narratore, le usano tutte liberamente, e solo l’ultima con sfumature dispregiative o razziste. (…) Essendo necessario in questo testo distinguere nettamente i quattro termini, spesso usati addirittura nella stessa frase, mi sono attenuta a un’equivalenza precisa: ho tradotto Negro con “negro”, maiuscolo o minuscolo a seconda dell’uso dell’autore: colored con “di colore” e black con “nero”. Nelle rare occorrenze di nigger, usato in senso dispregiativo, ho aggiunto a “nero” aggettivi denigratori, congruenti con la datazione storica della lingua (cioè non troppo contemporanei).
È stato problematico trovare un traducente per pink, che nel Black English americano sta per “bianco”. Ho optato per “viso pallido” che ha già occorrenze in italiano. Invece nel caso di ofay, che è dispregiativo, ho scelto “maledetti bianchi del diavolo”. L’Italia è una società multietnica solo da pochi anni quindi la lingua non possiede terminologia d’epoca adatta; usare termini troppo contemporanei sarebbe stato anacronistico.
In parte è lo stesso ragionamento che Masini ha fatto traducendo Il mio grido è come un tuono. «Quando ho consegnato la traduzione, con l’editore abbiamo ragionato sul tema dell’uso di questa parola», spiega Masini, «sarebbe stato antistorico non usarla. La stessa autrice si era espressa in merito, lo racconta in una introduzione al romanzo del 2001 che è stata inserita nell’edizione Mondadori, e ha fatto la scelta di conservare la “parola che comincia con la lettera N” nelle riedizioni». Si è comunque deciso di spiegare la scelta all’inizio del libro perché «per i lettori va incorniciata in qualche modo», soprattutto per gli insegnanti e in generale per gli adulti che possono vedere dei rischi nella presentazione di certe parole e storie ai ragazzi. «Credo che un ragazzino di oggi, pieno di possibilità di vedere altri mondi, ad esempio attraverso le serie tv, non può non essere in grado di capire. Correggere non è la soluzione, è spiegare».
– Leggi anche: I “trigger warning” funzionano?