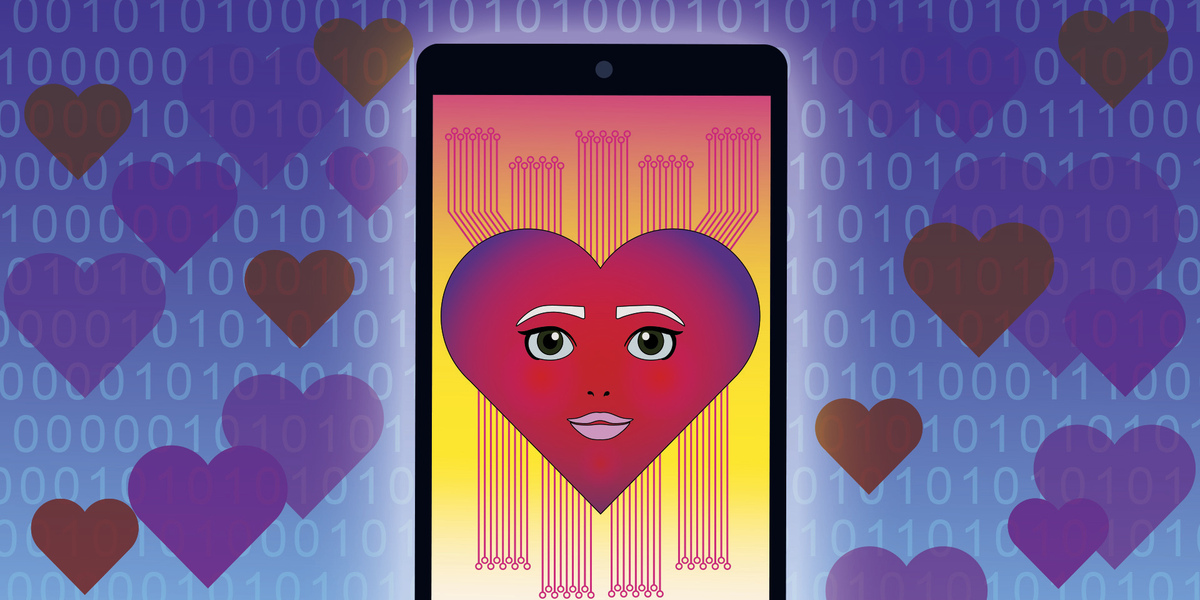“Tornare avanti”
Il documento dei "quarantenni" dalemiani del PD contro il veltronismo

La crisi del governo Berlusconi come crisi di sistema
Il 4 agosto 2010, con la spaccatura della maggioranza sulla mozione di sfiducia al sottosegretario Caliendo, non si è aperta una crisi di governo, ma una crisi di sistema. Una crisi che sta alla politica italiana come la crisi economico-finanziaria del 2008 sta all’economia mondiale: un evento che costringe a riconsiderare un’intera visione del mondo. Una vera e propria ideologia che negli ultimi venti anni si è progressivamente condensata in un vasto catechismo di formule precostituite, immutabili e indiscutibili, fino a cristallizzarsi in una nuova forma di saggezza convenzionale. La coincidenza tra crisi economica internazionale e crisi del sistema politico democratico non è casuale, e non si manifesta solo in Italia, ma in un panorama europeo segnato dal primato dell’economia sulla politica, dall’indebolimento degli strumenti nazionali di governo dell’economia e dallo smarrimento delle classi medie. In Italia tutto questo assume però caratteristiche particolarmente radicali.
La crisi del governo Berlusconi è un passaggio in cui si mescolano, come in un caleidoscopio, tutti gli elementi che hanno caratterizzato la stentata esistenza dei governi che si sono succeduti negli ultimi sedici anni: l’impatto delle iniziative giudiziarie e delle relative campagne di stampa, le oggettive difficoltà nel gestire una politica economica improntata al rigore di bilancio, le sempre più profonde divisioni interne alle coalizioni di maggioranza. Dalla crisi del primo centrodestra nel 1994 fino alla caduta dell’ultimo esecutivo Prodi nel 2007, nessun governo è uscito indenne da un simile percorso, indipendentemente dall’ampiezza della propria maggioranza parlamentare.
Per sedici anni, a ciascuna di queste crisi è stata data un’identica giustificazione: la congiura ordita da alleati infedeli e burocrati di partito desiderosi di “tornare indietro”, alla Prima Repubblica, al tempo dei governi “fatti e disfatti in Parlamento”. Dunque un identico movente: cancellare i frutti della “rivoluzione maggioritaria”, bipolarismo e governabilità, valori indiscutibili e non negoziabili della Seconda Repubblica. In nome del bipolarismo e della governabilità, non per nulla, per quasi venti anni si sono promossi referendum, leggi elettorali e riforme istituzionali, il cui esito concreto è stato però l’esatto contrario di quanto promesso: trasformismo e ingovernabilità.
A giustificare la costante paralisi dell’azione di governo, le ripetute scissioni e successive moltiplicazioni di partiti, correnti e movimenti, sono state additate negli anni, a destra e a sinistra, lunghe schiere di traditori, in funzione di capri espiatori. Ma simili interpretazioni di comodo non possono reggere oltre le costanti repliche della storia di questi sedici anni, tanto meno possono essere riproposte oggi come nuove, per la quinta, la sesta o la settima volta consecutiva.
Piuttosto, proprio coloro che all’indomani delle ultime elezioni politiche celebrarono il compimento della lunga transizione, con la nascita di un sistema politico “tendenzialmente bipartitico” incentrato su Pd e Pdl, dovrebbero ora riflettere sulle conseguenze da trarre dinanzi all’ennesima crisi di governo. Dovrebbero riflettere, partendo dalle loro stesse previsioni di due anni fa, sulle condizioni ideali in cui si trovava questa volta il governo Berlusconi: una legge elettorale violentemente maggioritaria, con parlamentari di fatto nominati dal leader, che gli aveva regalato una maggioranza schiacciante e priva di ogni autonomia; un presidente del Consiglio al tempo stesso capo e proprietario di un partito quanto altri mai leggero, senza alcuna forma di democrazia interna; un leader carismatico dotato di risorse extrapolitiche, economiche e mediatiche, inimmaginabili per qualunque altro segretario di partito; un parlamento completamente in suo controllo, un’opposizione debole e divisa, una legittimazione senza precedenti.
Se neanche tutto questo è sufficiente, se neanche tutto questo basta ad assicurare la tanto sospirata governabilità, cos’altro si potrà mai escogitare, lungo questa china, dopo avere azzerato l’autonomia del parlamento e colpito le stesse prerogative del Capo dello stato con la finzione dell’elezione diretta del premier (una finzione di cui la crisi attuale mostra ancora una volta tutte le pericolose conseguenze, anzitutto sul piano della divisione dei poteri), dopo avere messo al bando ogni forma di pluralismo dentro i partiti, dopo avere costruito le condizioni di una perfetta dittatura della maggioranza e di un governo sostanzialmente monocratico? Fin dove bisogna arrivare? Quand’è, insomma, che basta?
Noi pensiamo che basti, adesso.
Noi pensiamo che il momento di fermarsi sia esattamente questo. Non per “tornare indietro”, ma per cambiare strada.
Le basi politico-istituzionali del ventennio berlusconiano
In questo momento tutte le forze riformiste europee appaiono in deficit di futuro. Tutte devono fare i conti con lo svuotamento degli strumenti nazionali del riformismo. Ma questo compito si presenta particolarmente impegnativo in Italia, dove la crisi di sistema del berlusconismo colpisce, inevitabilmente, anche il Partito democratico. Per definire la sua identità, la sua collocazione e i suoi compiti, crediamo pertanto che il Partito democratico non possa più rinunciare a esprimere con chiarezza un proprio giudizio sull’ultimo ventennio di storia repubblicana. Un ventennio che ha conosciuto certamente fasi diverse. All’inizio degli anni novanta, ad esempio, il centrosinistra ha raggiunto obiettivi fondamentali come la riforma delle pensioni, una breve stagione di liberalizzazioni e soprattutto l’ingresso nell’euro (sebbene, quest’ultimo, pagato quasi esclusivamente dal lavoro dipendente). Ma a uno sguardo retrospettivo, e a dispetto delle apparenti discontinuità intervenute nel ’92-93, l’elemento predominante resta la continuità politica e culturale tra la cosiddetta Seconda Repubblica e l’ultima, meno esaltante fase del sistema politico precedente, quella degli anni ottanta. Un graduale declino economico, sociale e civile del paese, che ha messo a dura prova la tenuta dell’organismo nazionale unitario. Un declino riconducibile anzitutto alla debolezza della politica e all’inadeguatezza delle sue classi dirigenti. E’ infatti la fragilità della politica democratica ad aver prodotto quel singolare impasto di continuità con il passato e di permeabilità nei confronti del pensiero neoconservatore, culminato nel sostanziale svuotamento dell’assetto politico-istituzionale della Repubblica, con cui ci dobbiamo confrontare ancora oggi. Un intreccio di conservatorismo e sovversivismo che caratterizza da sempre, peraltro, le nostre classi dirigenti economiche, con il loro seguito abituale nel mondo della cultura, tra gli intellettuali in generale e tra i giornalisti in particolare.
La genesi della Seconda Repubblica affonda le sue radici in queste contraddizioni. Non per caso il suo atto di nascita risale all’inizio degli anni novanta: in quel momento decisivo, il problema più urgente del paese appariva l’esplosione del debito pubblico, conseguenza dell’insostenibilità del modello di sviluppo consolidatosi negli anni ottanta, che a sua volta minacciava di mettere in crisi la stessa unità nazionale. Alla radice stava un compromesso sociale che si basava, da un lato, su bassi salari, bassa produttività e uso distorto della spesa pubblica, in particolare pensionistica; dall’altro, su un sistema delle imprese che si vedeva compensato di tutti i limiti e le distorsioni che avevano caratterizzato lo sviluppo del paese da un’ampia possibilità di evasione fiscale, ma anche dalla politica di ripetute svalutazioni della lira, che andava a beneficio dell’industria esportatrice; tra questi due estremi, si espandeva nel frattempo un ceto medio che godeva tutti i benefici del “circolo vizioso della rendita”, con pesanti ricadute sullo stesso debito pubblico e sulle dinamiche dello sviluppo.
All’inizio degli anni novanta, pertanto, il livello raggiunto dal debito e la scelta di entrare nell’Unione monetaria europea rendevano necessaria una radicale riscrittura di questo compromesso. Ma proprio allora, quando cioè più che mai il paese avrebbe avuto bisogno di forze politiche in grado di scomporre le coalizioni di interessi attraverso il più spregiudicato gioco di alleanze politiche e sociali, per potere ripartire equamente i costi sociali e politici delle riforme, ecco che l’ubriacatura ideologica referendaria e maggioritaria porta al congelamento di tutte le maggiori forze politiche nei due poli di centrosinistra e centrodestra. I due poli si dividono tra loro – peraltro niente affatto equamente – la rappresentanza dei diversi blocchi d’interessi così come sono, rendendone praticamente impossibile la scomposizione (anzi, accrescendo in tal modo il loro peso relativo all’interno di ciascuna coalizione, e accrescendo di conseguenza il loro potere di veto). Di qui il paradosso di un sistema politico in cui le diverse forze proclamano all’unisono la necessità di riforme sempre più indistinte e indistinguibili le une dalle altre, ma al tempo stesso, prigioniere delle rispettive ipocrisie, non producono altro che un gioco statico di interdizione reciproca. L’Italia si tiene così buona parte degli squilibri ereditati dalla Prima Repubblica, trasformati ora in veri e propri totem dell’uno o dell’altro schieramento, caricati più che mai di valore ideologico, e perciò resi eterni. Una grande bonaccia in cui c’è sempre, tuttavia, chi ci guadagna e chi ci rimette: il lavoro dipendente vede messi in discussione non soltanto i suoi privilegi (le pensioni di anzianità), ma anche diritti fondamentali (da un salario dignitoso a una scuola decente, dal contratto nazionale di lavoro al recupero del fiscal drag), mentre le altre corporazioni bloccano quasi completamente i cambiamenti necessari a ricollocare l’Italia nella divisione internazionale del lavoro del XXI secolo. Dal 1993 al 2007, secondo uno studio della Banca d’Italia sui lavoratori in difficoltà per classe sociale, tale quota sale dal 22 al 33% per gli operai, sale anche per impiegati e dirigenti, mentre diminuisce di 13 punti percentuali per lavoratori autonomi e imprenditori.
Governabilità, decisionismo e “politica del fare”
Per uscire dal berlusconismo occorre dunque rivedere alla radice l’intera schematizzazione dei problemi del paese che si è affermata in questi anni: governabilità, decisionismo e “politica del fare” come risposta ai guasti prodotti da partitocrazia, consociativismo e statalismo. E’ infatti in questo perverso intreccio di liberismo e giustizialismo, che nello stato, nella politica e nei partiti vede solo il trionfo della corruzione e l’umiliazione del merito, il cuore di quell’ideologia antipolitica che ha progressivamente desertificato lo spazio pubblico, anche a sinistra, spianando la strada alle scorribande del Cavaliere e dei suoi alleati, nello spazio libero di una moderna società degli individui dove non esistono più interessi e legami sociali, ma solamente, bene che vada, un’astratta retorica di valori, regole e altri confortevoli oppiacei per le buone coscienze progressiste.
In un mondo popolato solo di individui completamente liberi, autodeterminati e autosufficienti nelle loro scelte di vita, e pertanto bisognosi solamente di essere liberati da tutti gli ostacoli che la società oppone al pieno appagamento dei loro desideri, la dottrina economica prevalente non può che fondarsi sulla certezza fideistica nel libero mercato e nelle scelte razionali dei suoi attori. In politica, questa impostazione si traduce inevitabilmente in una visione personalistica e leaderistica, che fa breccia anche a sinistra. Il superamento del Pci e della Dc, non per nulla, viene teorizzato e praticato all’interno di questo universo concettuale. Di qui l’abbandono dell’idea stessa di partito come organizzazione collettiva, luogo dell’elaborazione e della direzione politica condivisa, strumento per allargare le basi sociali del riformismo. Per il Pci la regressione è ancora più brutale e cinica: il partito viene considerato come una zavorra, se non addirittura un motivo d’imbarazzo, per l’ascesa di leader caricati di aspettative messianiche, ma sempre più isolati.
Di fatto, il crollo repentino dei vecchi partiti ha come congelato la cultura politica e gli equilibri sociali emersi nel corso degli anni ottanta, estremizzandone i difetti e ostacolandone il cambiamento. Sul piano culturale, nel centrosinistra si è cementato così un impasto di nuovismo e conservatorismo che ne ha progressivamente allentato i legami con il paese. La subalternità verso l’interpretazione neoconservatrice della storia della Prima Repubblica e delle ragioni alla base della sua crisi (consociativismo, partitocrazia, statalismo, centralismo) si è intrecciata con l’incapacità di uscire dal proprio tradizionale insediamento sociale e territoriale. Ma anche i residui rapporti con questo insediamento si sono indeboliti, a causa della schizofrenia sempre più marcata tra un’ideologia elitaria, giacobina e subalterna all’avversario da un lato, e una “constituency” tradizionale dall’altro, consentendo alla destra di eroderne significativi settori. In particolare, mentre gli eredi della cultura cattolico-democratica privilegiavano sempre più la tutela corporativa della loro esperienza organizzata rispetto alla riproduzione e all’aggiornamento della loro cultura politica, il postcomunismo italiano assumeva le letture di moda sul terreno economico-sociale (la tardiva infatuazione per il mercato, la strumentale contrapposizione tra padri garantiti e figli abbandonati, l’attacco sistematico alle forze sindacali) nel vano tentativo di allontanare da leadership immutalibi gli spettri del passato, dimostrando così i limiti insuperabili della propria esperienza storica.
Così si è affermata, soprattutto a sinistra, una concezione leaderistica della politica che è insieme liberista e giustizialista, oligarchica e populista, aristocratica e plebea. Purissimo distillato di quel peculiare liberalismo antidemocratico che negli ultimi venti anni, in diverse forme, ha preso il sopravvento in tutto il mondo, ma in Italia più che altrove. Un’ideologia che nel nostro paese è capace di abbracciare tanto le eleganti dottrine liberiste dei maître à penser della Confindustria, o al limite dei loro discepoli più caritatevoli e più versati nell’arte di riuscir graditi ai salotti progressisti, quanto le ineleganti invettive di sempre nuovi tribuni televisivi.
Surrogati identitari e fragilità strutturali del centrosinistra
Alla destrutturazione dei partiti, all’accettazione di una concezione monocratica e privatistica della politica, alla conseguente messa al bando di qualsiasi possibilità di organizzazione del dissenso si è accompagnata in questi anni, inevitabilmente, la progressiva perdita di senso, principi e ispirazione della stessa attività politica. Di qui la costante ricerca di sempre nuovi contenitori in cui travasare leadership incapaci di misurarsi con una lettura autonoma dei problemi del paese; ma anche di sempre nuovi surrogati identitari. Di qui, a fasi alterne, il fanatismo anticlericale, ambientalista, pacifista.
L’idea che in questa disarticolazione dei partiti stia la modernità, che rappresenti anch’essa una forma di secolarizzazione, inevitabile e forse persino auspicabile, è semplicemente falsa. E’ vero semmai il contrario: non è il crescente distacco dal popolo a spiegare il venir meno del ruolo assolto un tempo dai partiti. E’ il venir meno del loro ruolo, il fatto che sempre meno al loro interno si prendano le decisioni fondamentali che riguardano la vita di tutti, che spiega il loro abbandono, da parte del popolo, e anche la loro involuzione democratica. Tutti questi elementi, combinandosi con l’ideologia antipolitica della Seconda Repubblica, spiegano quindi la condizione di rachitismo organizzativo, incertezza identitaria e ingovernabilità politica del Pd. Un partito nato all’insegna della subalternità al sistema dell’informazione, specchio a sua volta di quel capitalismo a suffragio ristretto che rappresenta una delle ragioni, e non l’ultima, dell’arretratezza economica, politica e civile del paese. Di qui la sua estrema esposizione a tutte le mode e le suggestioni indotte dal circuito della comunicazione. Di qui dirigenti che parlano sempre più spesso come divi di Hollywood in tour promozionale, capaci di ripetere soltanto quanto amino l’Italia, le sue bellezze artistiche e i suoi struggenti paesaggi.
Il mito dell’autosufficienza dall’Unione al Pd
L’idea di autosufficienza che ha guidato sia l’esperienza del secondo governo Prodi sia la prima fase del Pd è figlia di questa stessa filosofia. Una concezione che vede nelle alleanze possibili, nei compromessi ragionevoli e nel dialogo costruttivo tra i diversi partiti una forma di degenerazione della politica, anziché la sua fisiologia (almeno in una democrazia parlamentare). Ancora una volta, in questa impostazione si manifesta dunque un limite culturale del Partito democratico. Un limite che ha però una precisa traduzione, squisitamente tecnocratica, in termini di politica economica. Una concezione che nasce dalla suprema diffidenza verso un’idea della politica come attività sovraordinata.
La crisi del secondo governo Prodi ha segnato anche simbolicamente la chiusura del lungo ciclo cominciato con i governi Amato e Ciampi nel 92-93.
Il Partito democratico deve ripartire dunque da una riflessione complessiva sulla vicenda del centrosinistra. Cominciando magari con lo sfatare un altro mito, quello della “meglio classe dirigente”.
Fermi restando i meriti storici dei gruppi dirigenti del centrosinistra e delle forze sindacali che in quel momento hanno realmente salvato il paese, attraverso un patto con l’establishment ovviamente non privo di rischi e di prezzi da pagare, oggi bisogna riconoscere che di quello schema e di quella stessa formula di governo il centrosinistra è rimasto prigioniero, anche, e non da ultimo, nell’immaginario collettivo degli italiani. Invece di essere percepito come forza di trasformazione e di rovesciamento degli equilibri consolidati, ne è apparso come il massimo garante. Offrendo così alla destra berlusconiana la possibilità di presentarsi come l’unica opzione di rottura.
Il Partito democratico
A gran parte dei problemi che abbiamo delineato fin qui avrebbe dovuto rispondere il Partito democratico. Ma se le risposte non sono arrivate, la ragione sta proprio nel modo in cui il Partito democratico è nato: senza una propria analisi del mutamento nel rapporto tra politica ed economia, senza una propria idea dell’Italia, né una propria lettura della sua storia recente. Dopo una lunga e faticosa gestazione, culminata nel convegno di Orvieto, si è abbandonato e perfino rinnegato ogni tentativo di dare al nuovo partito un impianto politico-culturale autonomo, coerente con la storia dei partiti che avevano deciso di dargli vita. Si è preferito rimuovere il passato, cullandosi nella retorica del partito “completamente nuovo”, figlio di niente e di nessuno, contenitore post-identitario di tutto, supermercato elettorale di un molteplice nulla. Ci si è messi a favore di vento, rinunciando in partenza alle battaglie difficili. Le sole, però, in cui si cementano l’unità e l’identità di un partito. Di questo atteggiamento il discorso del Lingotto è stato il momento culminante, la summa teorica di un’eclettica visione dell’Italia, mutuata da tutte le narrazioni dominanti nel ristretto circuito delle nostre classi dirigenti.
Per aprire davvero una stagione di riforme, il Pd deve uscire dall’ipnosi indotta da questo circuito autoreferenziale. Se vuole recuperare una propria autonoma visione del paese e del mondo, deve individuare con chiarezza i propri riferimenti e i propri interlocutori sociali. A cominciare dalle nuove “classi subalterne”, comunque le si voglia chiamare, escluse o penalizzate dagli attuali equilibri e potenzialmente sensibili a una proposta di cambiamento. Solo così il Pd potrà sottrarsi all’egemonia di quel “ceto medio riflessivo” che minaccia di ridurlo sempre più a una grande ong per la difesa dell’ambiente, dei diritti civili e della pace nel mondo. E dovrà farlo a partire da una solenne petizione di principio: prima della responsabilità verso le generazioni future, viene la responsabilità verso le generazioni presenti. Il Partito democratico, pertanto, deve capire innanzi tutti quali sono, qui e ora, i soggetti sociali disponibili a voltare pagina. I suoi riferimenti economici e sociali dovrebbero quindi tagliare trasversalmente i blocchi tradizionali, che sono ormai in frantumi. Il confine tra forze di progresso e forze di conservazione attraversa il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, il lavoro professionale e l’impresa. I soggetti di riferimento per il Pd si possono intercettare solo attraverso un attento, paziente e finanche doloroso sforzo analitico e politico di scomposizione, selezione e ricomposizione degli interessi intorno a un progetto di modernizzazione del paese. E questo lo possono fare soltanto partiti organizzati e strutturati per aderire, come si diceva un tempo, a tutte le pieghe della società. Partiti, non comitati elettorali, inseriti in un sistema parlamentare che ne riconosca e ne valorizzi il ruolo essenziale. Il Partito democratico deve sapere che la domanda di riforme non è data, strutturata e maggioritaria. Non abbiamo perso solo per limiti di offerta programmatica, per limiti soggettivi (leader deboli o inibiti da conflitti interni al partito e alla coalizione) oppure oggettivi (il filtro dei media controllati o allineati a Berlusconi). In realtà, la domanda di riforme è solo in parte già espressa. In larga misura, è solo potenzialmente presente. Per evolvere in compiuta domanda politica ha bisogno di un intenso lavoro culturale, politico, organizzativo. Non bastano leadership forti e illuminate, con i loro staff e i loro esperti di comunicazione.
Ricchezza e potere
Negli ultimi venti anni, in tutti i paesi occidentali, si è assistito a un gigantesco spostamento di ricchezza dai salari ai profitti. In Italia, i redditi da lavoro sono cresciuti del 4 per cento, i redditi da capitale del 44. Questa è la verità essenziale, la radiografia della Seconda Repubblica. E la ragione del perché i suoi difensori sono tanti, e tanto agguerriti. Il loro principale punto di forza sta nell’essere riusciti a espellere progressivamente dall’area della legittimità non solo gli obiettivi, ma gli stessi strumenti di una politica alternativa: dall’intervento pubblico alla valorizzazione del lavoro, fino all’idea stessa di una politica industriale. Nulla è sfuggito alla campagna di demonizzazione di questi vent’anni, che ci ha raccontato un paese pullulante di energie imprenditoriali che aspettavano solo di essere liberate dai vincoli soffocanti dello stato e della politica, e prima ancora da sindacati, contratti e diritti dei lavoratori.
Gli stessi leader della sinistra, ad esempio, hanno continuato a parlare di produttività del lavoratore, non di produttività come risultante di produttività del lavoro, produttività del capitale e produttività totale dei fattori. L’onere della produttività viene così scaricato sui soli lavoratori, dimenticando la rilevanza, enormemente maggiore, della qualità e della quantità degli investimenti dell’impresa e dei fattori di contesto (dalle infrastrutture alla regolazione dei mercati, all’efficienza dei servizi pubblici e privati all’impresa). E’ una dimenticanza non casuale. Le vere cause del deficit di produttività sono molto più difficili da affrontare sia in termini economici e aziendali, sia in termini politici. Da questo versante, occorrerebbero infatti interventi strutturali, che toccherebbero rendite di posizione consolidate ed elettoralmente rilevanti. Appare molto più semplice imboccare la scorciatoia del ridimensionamento dei costi e dei diritti dei lavoratori, parzialmente compensato attraverso la fiscalità generale. Ma è una scorciatoia illusoria, insostenibile nel medio periodo, sia sul piano economico, sia sul piano democratico.
Analoga subalternità ha caratterizzato in questi anni l’approccio della sinistra al mercato del lavoro. La precarietà del lavoro per i giovani è stata scaricata sulle spalle dei padri operai, colpevoli di avere salari reali da fame, ma stabilità del lavoro. Per combattere la precarietà, innalzare il tasso di attività femminile e giovanile, far salire le retribuzioni, è decisiva la crescita economica. Per crescere, però, l’Italia deve intervenire sulla produttività totale dei fattori e sulla produttività del capitale. Per crescere deve disegnare cioè una coerente politica industriale. Nel mercato del lavoro, per sconfiggere la precarietà la variabile decisiva è la convenienza economica, non la convenienza giuridica dei contratti precari, ossia l’assenza di vincoli alla conclusione del rapporto di lavoro.
Uscire dalla crisi significa trovare un nuovo equilibrio. Tornare indietro è impossibile. Senza un deciso intervento della politica, però, l’Italia, come il resto d’Europa, rimarrà prigioniera di una lunga stagnazione. Di fatto, siamo già entrati in una “prospettiva giapponese”, caratterizzata da crescita anemica e da un elevato livello di disoccupazione, in particolare giovanile.
Questa è la partita che si sta giocando oggi in Italia e in Europa. Stiamo parlando di ricchezza e potere, perché è di questo, innanzi tutto, che deve occuparsi la politica. E prima di ogni altro, non foss’altro per il nome che porta, il Partito democratico, respingendo al mittente la retorica sulla necessità di una sinistra che torni a parlare di valori, possibilmente in versi, e si accontenti di tutelare i diritti civili, l’ambiente, le donne e i bambini. Una sinistra che dica tante bellissime e giustissime cose, purché non disturbi i principali beneficiari dell’assetto economico e sociale esistente. Che tenga buoni i lavoratori più forti, attraverso i servizi degli enti bilaterali, mentre smantella il welfare universale. Che offra agli esagitati, ai disperati e ai poveracci il surrogato di mille nobilissime battaglie per altrettante giustissime cause, per tutte le buone cause del mondo, meno che per la loro. Che si rivolga al popolo con il linguaggio della più estrema radicalità o del più soave lirismo, purché non gli metta in testa idee di mobilità sociale, redistribuzione della ricchezza e men che mai di una distribuzione del potere.
Libertà e partecipazione
Una coerente revisione del patrimonio culturale della sinistra deve dunque ripartire dalla negazione dell’assunto thatcheriano, troppo a lungo accettato anche da noi, secondo cui “la società non esiste”, perché “esistono solo gli individui”. Feticci completamente disincarnati dalle persone concrete e dai loro problemi reali, materiali e morali, che sono sempre, invece, problemi collettivi. Il Partito democratico dovrebbe avere la forza di affermare l’esatto contrario, e cioè che l’individuo non esiste, senza la società. Perché l’astrazione è l’individuo. E’ l’idea di un soggetto completamente autodeterminato e autosufficiente che non esiste, che non si incontra da nessuna parte, che non si può né vedere né toccare. Al di fuori delle sue relazioni con gli altri, della sua famiglia e dei suoi amici, del suo lavoro, del suo mondo, l’individuo si riduce al puro dato biologico. Non potrebbe nemmeno parlare, perché lo stesso linguaggio sarebbe impossibile, dunque non sarebbe nemmeno in grado di dire io. Non potrebbe nemmeno pensarlo. Dal punto di vista politico, il dato primario è la società. Il concetto cristiano di persona come nodo di relazioni, pertanto, si dimostra assai più fecondo del concetto liberale di individuo. Persone, dunque, con i loro legami, le loro concrete condizioni di vita e i loro complessi rapporti reciproci. Qui sta la risposta democratica alla sfida della destra, anche nel campo dell’immaginario, che si gioca tutta sul valore e sul significato della libertà. Solo uscendo dal terreno che le è stato imposto dall’avversario, rifiutando cioè il concetto stesso di una società degli individui, la sinistra potrà ritrovare la sua missione, con la forza del suo messaggio e di una sua autonoma proposta di emancipazione, che non può non nascere da un diverso equilibrio tra libertà della persona e partecipazione democratica alla vita politica ed economica, culturale e civile della nazione.
Tornare avanti
E’ giunto dunque il momento di liberare il Partito democratico dall’ipoteca della crisi della Prima Repubblica, dal leaderismo egocentrico, dal vacuo nuovismo e dal politicismo sterile che ne sono il prodotto. Costruire il Pd come grande forza progressista europea significa ripartire da una concezione della politica meno elitaria, perché popolare e democratica. Significa ripartire da un’idea di riformismo radicato tra le persone e gli interessi, che non è solo un problema organizzativo, ma richiede anzitutto autonomia di pensiero e cultura della rappresentanza.
Nella concreta situazione politica dell’Italia di oggi, costruire un’alternativa significa anche chiudere una fase e aprirne un’altra. Per questo credibilità, proposta politica per la transizione e preparazione di un’alternativa incentrata sul Pd non sono elementi in contraddizione, ma parti della stessa strategia.
Con la crisi di sistema del berlusconismo, si apre in Italia una fase di ridefinizione dell’assetto politico e istituzionale. Si ridisegna l’ordine economico e sociale del paese, in un quadro europeo e internazionale attraversato da seri rischi di regressione politica e civile. Il governo Berlusconi si spezza all’urto di un iceberg la cui parte emersa consiste nella questione della legalità. Ma sotto la superficie dell’acqua c’è, imponente, la questione economica e sociale, ossia l’insostenibilità della regolazione populista e corporativa del ripiegamento economico e sociale delle classi medie, in atto in Italia in misura più intensa che negli altri paesi occidentali. Non è un caso che la rottura avvenga dopo l’approvazione dell’ennesima manovra di correzione dei conti pubblici profondamente iniqua e senza prospettive di crescita per il paese. La ricetta della destra berlusconiana non poteva funzionare. La profonda crisi economica e sociale esplosa all’inizio del 2008 ha fatto da detonatore. La ricollocazione al ribasso dell’Italia nella competizione internazionale determina una società sempre più polarizzata, bloccata, castale in termini di distribuzione del reddito e di opportunità, e sempre meno democratica in termini di diritti civili e politici. È una ricollocazione impossibile, perché esclude larga parte delle classi medie e penalizza la parte più dinamica e innovativa del lavoro e dell’impresa.
La svalutazione del lavoro è stata la prima causa della crisi. In questo quadro, almeno nel medio periodo, il risanamento dei conti pubblici è certo inevitabile. Ma è tanto più impressionante la disinvoltura con cui si ripropone e si attua, come via d’uscita dalla crisi, un’ulteriore svalutazione del lavoro. Indifferenti alla lezione del grande crack del 2008, si insiste sui tagli alla spesa, ossia sullo smantellamento del welfare delle classi medie, data la dimensione delle correzioni previste, pur sapendo che il welfare non porta responsabilità alcuna dell’esplosione dei debiti pubblici, che è invece conseguenza della crisi e dei salvataggi bancari. Ma tutto questo non conta. Gli immensi patrimoni accumulati da lor signori a spese dei lavoratori, per cifre che la nostra lingua non ha ancora imparato a nominare, non si possono toccare. Così crolla la domanda interna. Ma non importa. Si confida piuttosto sulle esportazioni ai cinesi per trainare la crescita. È la ricetta del presidente della Bce, in un dibattito che pure ha visto tanti economisti di impostazione liberale riconoscere la strutturale carenza di domanda globale quale vincolo insormontabile alla ripresa dell’occupazione. Pazienza. Superato il primo shock seguito all’esplosione della crisi, l’ortodossia deve essere immediatamente ripristinata. Di qui le manovre dei governi conservatori europei e il tentativo della destra italiana di ridisegnare un nuovo equilibrio economico e giuridico, in forme estreme e classiste, a tutto danno dei lavoratori, con l’inspiegabile aiuto di una parte delle forze sindacali. Alla controffensiva della destra economica e politica, si intrecciano le esigenze “oggettive” del management al servizio del grande capitale finanziario. A noi italiani, nelle ultime settimane, le ha ricordate con il suo stile brutale Sergio Marchionne, prima a Pomigliano e poi a Mirafiori. Il capitale finanziario può fare shopping globale per acquistare forza lavoro dov’è più conveniente. I sindacati e le forze politiche riformiste sono rinchiuse nei confini nazionali, piegate dalla propria subalternità culturale o arroccate su posizioni residuali e di pure testimonianza. Ma l’ordine economico e sociale che si sta tentando di ricostruire, e se possibile di inasprire, non regge. E’ troppo squilibrato. La crescita rimane anemica, e non produce occupazione. Le classi medie rimangono senza prospettive. Le democrazie liberali scivolano così verso derive populiste e autoritarie. È compito dei riformisti riorganizzarsi su basi sovranazionali per evitare le sciagure del passato.
Il Partito democratico non può affrontare questa fase decisiva, per l’Italia e per l’Europa, prigioniero di una discussione politicista e autoreferenziale. Dividersi tra i fautori dell’alleanza a sinistra e quelli dell’alleanza al centro, tra autocandidature alla premiership vuote di ogni reale significato politico. Per svolgere adeguatamente il suo compito al servizio del paese, il Pd deve affrontare questo passaggio storico dicendo chiaramente cosa pensa, quale idea di Italia intende portare avanti, e cioè quale Italia in quale Europa, con quali soggetti economici e sociali. Deve essere il Pd a mettere sul tavolo la propria proposta. Le altre forze politiche diranno se ci stanno o no.
Noi vogliamo contribuire a questa sfida, per dare più forza alla linea e alla leadership del Partito democratico, sancite dal congresso e dalle primarie di appena un anno fa.
Per questo ci ritroveremo a Orvieto il 25 settembre, nel luogo dove fu pensato il Partito Democratico. Per alzare lo sguardo e la voce, uscendo finalmente dal triste crepuscolo di questa immutabile Seconda Repubblica.
Non per “tornare indietro”, ma per cambiare strada.
Da sedici anni, incapaci di uscire dal berlusconismo, non facciamo altro che andare indietro.
Crediamo sia venuto il momento di tornare avanti.