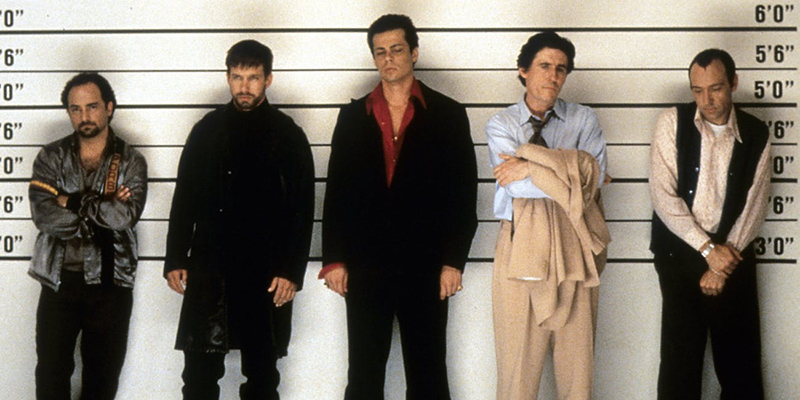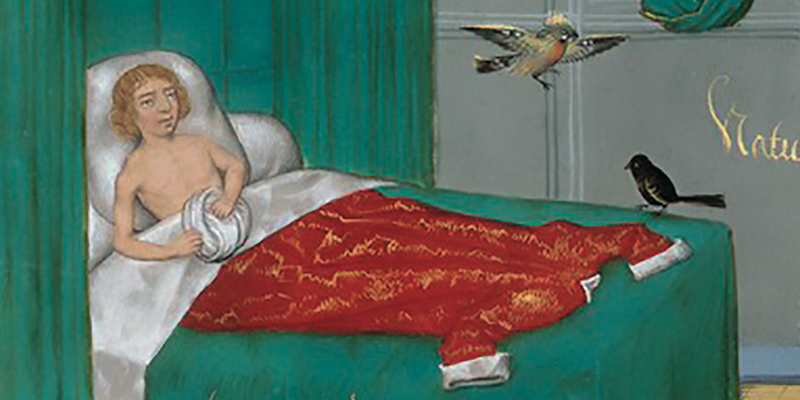La notte del Gran Consiglio
Tra il 24 e il 25 luglio di 70 anni fa venne firmato l'ordine del giorno che portò alla fine del regime fascista e all'arresto di Mussolini
di Davide Maria De Luca – @DM_Deluca

Nella notte tra il 24 e il 25 luglio del 1943 si tenne l’ultima riunione del Gran Consiglio del Fascismo, l’organo supremo del regime, presieduto da Benito Mussolini. Durante la riunione venne votato il famoso “Ordine del giorno Grandi”, il documento che portò alla fine del regime fascista e che mise in moto il meccanismo che avrebbe portato all’uscita dell’Italia dalla Seconda guerra mondiale e all’inizio della guerra civile.
La riunione del 24 luglio era la prima dal 1939, quando il Gran Consiglio del Fascismo fu convocato per votare la decisione di mantenere l’Italia neutrale nella guerra appena scoppiata – una decisione non vincolante, come tutte quelle prese dal Gran Consiglio che, per legge, era un organo soltanto consultivo.
Dopo il 1939 Mussolini prese tutte le più importanti decisioni senza consultare il Gran Consiglio, probabilmente per il timore di scontrarsi con i suoi stessi gerarchi. All’interno del Gran Consiglio erano presenti tutte le numerose correnti del fascismo: dai più intransigenti, i rivoluzionari che avrebbero voluto l’abolizione della monarchia, fino ai più moderati, contrari all’alleanza con la Germania.
A metà luglio quegli stessi gerarchi avevano chiesto a Mussolini di convocare nuovamente il Gran Consiglio per discutere l’andamento della guerra, ma anche l’organizzazione del partito e del regime. Più o meno apertamente alcuni gerarchi chiesero a Mussolini di restituire al re parte dei suoi poteri, in particolare il comando supremo delle forze armate. La mossa, almeno apparentemente, voleva far condividere alla monarchia la responsabilità dell’andamento del conflitto – che andava sempre peggio.
Il 10 luglio gli alleati erano sbarcati in Sicilia e l’esercito italiano si era dimostrato incapace di difendere l’isola. Soltanto pochi reparti italiani e le truppe tedesche stavano riuscendo a rallentare l’avanzata degli americani, dei canadesi e degli inglesi. Il 19 luglio gli aerei americani avevano bombardato Roma per la prima volta. Lo stesso giorno Mussolini aveva incontrato a Feltre Adolf Hitler. Nell’incontro Mussolini avrebbe dovuto persuadere Hitler a fornire all’esercito italiano armi e mezzi sufficienti a proseguire la guerra, ma Hitler non gli permise di parlare e Mussolini non riuscì a imporre le sue richieste.
La riunione cominciò alle 17 del 24 luglio nella Sala del Pappagallo a Palazzo Venezia. Nella stanza erano stati disposti 28 scranni, senza nessuna decorazione. Quello di Mussolini era posizionato su una pedana, per tenerlo appena più alto degli altri. Non c’erano stendardi alle pareti e nemmeno la guardia d’onore, formata di solito da 12 moschettieri di Mussolini. Il palazzo, però, era pieno di agenti di polizia in borghese e nel cortile erano schierati diversi soldati delle Camicie Nere.
Tutti i 28 membri del Gran Consiglio erano presenti: i Quadrumviri – i veterani della marcia su Roma – i principali ministri del governo, il presidente del Tribunale Speciale, quello dell’Accademia d’Italia, il comandante della Milizia Volontaria, le Camicie Nere, i presidenti del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni – che aveva sostituito la Camera dei deputati – il segretario del Partito Fascista e altri membri, scelti per meriti speciali che facevano parte del Consiglio con un mandato di tre anni.
Mussolini entrò nella Sala del Pappagallo per ultimo, alle 17 e 14, e chiese a un commesso di fare l’appello dei presenti. «L’ingresso del Duce nella sala del Gran Consiglio», scrisse l’economista Alberto De Stefani, membro del Gran Consiglio per meriti speciali, «è stato silenzioso; un’accoglienza di attesa; pareva non vedesse nessuno; rifletteva e dava l’impressione di chi si appresta ad ascoltare; la sua espressione era passiva, senza sintomi di reazione come quella di chi deve accettare un avvenimento e non vuole sottrarvisi». Altri scrissero che nel volto e nei modi di Mussolini si potevano vedere: «I segni di una volontà oramai rassegnata alla gran resa dei conti».
Non esistono resoconti stenografici della riunione ma molti dei testimoni, tra cui lo stesso Mussolini, lasciarono dei racconti – non sempre concordanti – su cosa venne detto quella sera. Di sicuro la riunione cominciò con un lungo discorso di Mussolini. Secondo alcuni testimoni parlò per due ore in una specie di lunga autodifesa. Riassunse gli ultimi anni di guerra e spiegò che non era stata sua intenzione prendere il comando supremo delle forze armate – una prerogativa che sarebbe stata del re – e che aveva lasciato sempre mano libera di decidere ai generali e allo stato maggiore dell’esercito.
Cercò di prevenire le critiche e disse che era pronto a rivoluzionare la struttura di governo e quella del partito. Disse che era pronto a «cambiare gli uomini» e a «dare un giro alla vite». Alla fine del discorso disse che in fondo anche nella Prima guerra mondiale alcune province erano state perse, ma che nonostante questo la guerra era stata vinta comunque. Il discorso non lasciò soddisfatti i gerarchi presenti. Il ministro delle Finanze, Giacomo Acerbo, descrisse quella relazione come «fiacca, disordinata, contraddittoria».
Dopo Mussolini presero la parola altri due gerarchi, che parlarono per un altro paio d’ore. Erano le 21 quando fu il turno del presidente della Camera Dino Grandi. Era arrivato a Palazzo Venezia con due bombe a mano infilate nella valigetta e, scrisse poi, si era molto preoccupato vedendo il gran numero di Camicie Nere che attendevano nel cortile del Palazzo. Grandi parlò per circa un’ora e, dopo aver premesso la sua fedeltà al re, espose e chiese di mettere ai voti il suo ordine del giorno: Mussolini doveva rimettere i suoi poteri al re, doveva rinunciare al comando supremo delle forze armate e doveva ripristinare la Costituzione, ossia lo Statuto Albertino.
Mussolini non reagì in modo particolare e diede la parola al gerarca successivo, scrissero i testimoni. In effetti conosceva da tre giorni il contenuto di quel documento, perché lo stesso Grandi glielo aveva fatto esaminare il 22 luglio. Grandi era un moderato, era contrario all’alleanza con la Germania e sperava che Mussolini sfruttasse il suo ordine del giorno come via d’uscita per abbandonare il potere e permettere all’Italia di uscire dalla guerra.
Anche alcuni dei gerarchi più intransigenti, come Roberto Farinacci e Carlo Scorza, segretario del Partito Fascista, volevano un passo indietro di Mussolini, almeno da alcune delle sue funzioni, ma chiedevano anche di continuare a combattere accanto alla Germania. E infatti, poco dopo l’intervento di Grandi, venne presentato da Farinacci un secondo ordine del giorno per continuare la guerra accanto alla Germania e riconsegnare al re il comando dell’esercito.
Alle 23 la riunione era ancora in corso e venne decisa una pausa di mezz’ora. I gerarchi uscirono in un’anticamera dove, si racconta, mangiarono alcuni panini preparati in fretta, visto che nessuno aveva previsto che la riunione sarebbe durata così a lungo. La pausa durò 45 minuti. Grandi fece girare il suo ordine del giorno, che era già stato firmato da alcuni dei gerarchi più importanti, e riuscì a ottenere 20 firme su 28.
Al ritorno nella sala la riunione proseguì con diversi interventi. Il più importante fu quello del capo delle Camicie Nere che, secondo i presenti, pronunciò un discorso in cui sembrava voler minacciare chi si opponeva a Mussolini. Mussolini replicò a sua volta e quindi parlò il presidente del Partito Fascista, Scorza, che propose un terzo ordine del giorno in cui, invece che l’abbandono del potere, si chiedeva a Mussolini soltanto un rimpasto degli uomini al governo e di proseguire la guerra accanto alla Germania.
In passato le riunioni del Gran Consiglio si erano concluse quasi sempre in questo modo: dopo aver permesso ai vari membri di esporre i loro ordini del giorno, Mussolini ne preparava un altro, che sintetizzava i principali punti discussi e quindi lo metteva ai voti. Questo ordine del giorno di solito otteneva l’unanimità.
Quella sera molti si aspettavano che Mussolini facesse qualcosa di simile: riassumere in unico documento l’ordine del giorno di Grandi, che era molto critico, e quello più moderato di Scorza. In questo modo, probabilmente, Mussolini avrebbe ottenuto l’approvazione di un documento in cui gli veniva chiesto soltanto di fare qualche cambiamento nella classe dirigente del partito e all’interno del governo.
Alle 2 e 30, con grande sorpresa di quasi tutti quelli che lasciarono resoconti della riunione, Mussolini disse che era arrivata l’ora di concludere e stabilì che il primo documento che doveva essere votato era proprio quello di Grandi. Ci fu un solo astenuto, otto contrari e 19 voti a favore. Tra i firmatari del documento c’era anche Galeazzo Ciano, genero di Mussolini. Mussolini chiese chi avrebbe portato il documento al re e poi aggiunse: «Signori, con questo documento voi avete aperto la crisi del regime». Quando il segretario del partito Scorza gridò: «Saluto al Duce!», Mussolini rispose: «Ve ne dispenso».
Il colpo di stato
Il Gran Consiglio era un organo consultivo e non esprimeva pareri vincolanti. La mattina del 25 non venne nemmeno data la notizia della riunione. Secondo la gran parte delle testimonianze di quei giorni, tra cui quella dello stesso Mussolini e del suo segretario, il Duce non appariva troppo preoccupato per il voto della notte precedente. Uno dei firmatari dell’ordine del giorno gli aveva già comunicato la sua decisione di ritrattare il voto della sera prima e Mussolini, a quanto pare, pensava che gli altri avrebbero presto fatto lo stesso. Inoltre riteneva di poter rabbonire Grandi offrendogli il ministero degli Esteri. La mattina Mussolini chiese un’udienza al re, per riferirgli sull’esito della riunione.
Non sapeva che la notte precedente Grandi era andato direttamente da alcuni membri della corte per comunicargli che il Gran Consiglio lo aveva sfiduciato e che quel voto era ciò che il re stava aspettando. Mussolini si presentò nel pomeriggio del 25 a Villa Savoia. Parlò con il re per venti minuti ma di quel colloquio non sono rimaste trascrizioni o registrazioni. Stando a quanto raccontò lo stesso Mussolini, Vittorio Emanuele III gli comunicò che era sollevato dall’incarico di capo del governo e sostituito dal maresciallo Pietro Badoglio.
All’uscita dalla Villa lo aspettavano 50 carabinieri. Mussolini fu caricato su un’ambulanza e portato in una caserma di Roma. Secondo il racconto di Mussolini, l’ufficiale che lo arrestò gli disse che lo stavano portando in un luogo sicuro per proteggerlo da un complotto. All’una di notte Mussolini ricevette una lettera di Badoglio che gli assicurava che quelle misure di sicurezza erano solo per proteggerlo e che in realtà poteva andare dove preferiva.
In realtà Mussolini era prigioniero e il nuovo governo Badoglio, in pochi giorni, cancellò il regime e sciolse il Partito Fascista. Mussolini venne continuamente spostato in vari luoghi, fino a che non fu sistemato in un albergo a Campo Imperatore, sul Gran Sasso. L’8 settembre Badoglio annunciò che l’Italia aveva firmato l’armistizio con gli alleati. Il 12 settembre Mussolini fu liberato da un commando di paracadutisti tedeschi. Sei giorni dopo nacque la Repubblica di Salò.
La congiura del 24 luglio
Storici, politici ed avvocati hanno discusso a lungo per stabilire se quello che accadde il 24 luglio sia stato un colpo di stato, una congiura e se sia stato un gesto legale. Sulla legalità dell’Ordine del giorno Grandi, persino alcuni di coloro che lo firmarono scrissero che si era trattato di un documento incostituzionale. Altri, tra cui lo stesso Dino Grandi, sostennero invece che tutto ciò che era avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 luglio era legale ed entro i limiti della Costituzione.
La questione del colpo di stato è legata a quella della legalità. Quasi tutti i firmatari dell’Ordine del giorno Grandi respinsero l’accusa di aver messo in atto un colpo di stato. Respinsero l’accusa anche coloro che dubitavano della legalità dell’ordine stesso. Mussolini, scrissero, conosceva i contenuti dell’Ordine del giorno sin dal 22 luglio e, mettendolo ai voti, gli aveva implicitamente dato un avallo legale.
I congiurati
Nei giorni successivi al voto del Gran Consiglio del fascismo, gran parte dei firmatari dell’Ordine del giorno Grandi si nascose o fuggì da Roma. Alcuni si rifugiarono nelle ambasciate dei paesi neutrali, altri si nascosero in monasteri in mezzo alle montagne mentre altri ancora lasciarono l’Italia. In realtà per un mese intero nessuno dette loro la caccia. Le Camicie Nere reagirono praticamente senza violenza all’arresto di Mussolini e allo scioglimento del Partito Fascista.
Soltanto quando a settembre Badoglio annunciò l’armistizio e venne creata la Repubblica di Salò, con l’aiuto delle truppe tedesche già presenti in Italia, i firmatari dell’Ordine del giorno Grandi cominciarono a essere perseguitati. Molti però erano già fuggiti e soltanto sei di loro vennero arrestati. Tranne Tullio Cianetti, che aveva ritrattato il suo voto la mattina del 25 luglio, furono tutti condannati a morte nel corso del “processo di Verona”. La sentenza fu eseguita tramite fucilazione l’11 gennaio del 1944. Tra chi fu ucciso c’era anche Galeazzo Ciano, marito di Edda, la figlia primogenita di Mussolini.
Foto: una riunione del Gran Consiglio del Fascismo a Palazzo Venezia (AP Photo)