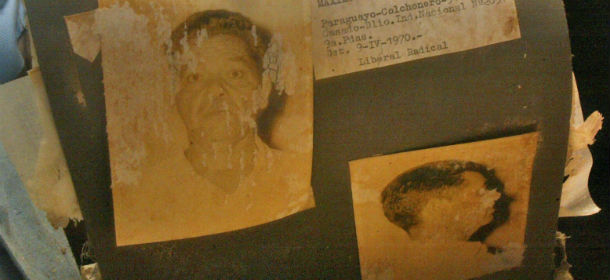L’incoscienza dei liberal
Fassina, Ichino, il Partito Democratico e la sinistra dei nostri tempi
di Giuseppe Provenzano

La richiesta di dimissioni di Stefano Fassina è stata un’«incoscienza dei liberal» (Krugman sulla BCE e la politica economica europea dice ben peggio: fosse stato responsabile economico, che figura…). Eppure, bisognerà provare a discutere per bene del “caso”, di questa polemica tra destra-sinistra all’interno del PD, variamente declinata fino alla più seria, reale e simbolica – ma molto approssimativamente raccontata – contrapposizione con Ichino.
Liquidare Fassina come un “ferrovecchio ideologizzato” o “fuori dal mondo” è altrettanto inaccettabile che tacciare Ichino come di “destra” o “traditore del popolo”. Sono due riflessi condizionati speculari, e sorvolare sul primo definendo il secondo come “stalinista” è scorretto. L’accusa di stalinismo, poi, è sempre un po’ sparata grossa e prima o poi ricade addosso: “liberal-stalinisti”, già li chiamano in rete. Vi sarà sfuggita, ma in questi mesi è andata avanti una surreale polemica sul “togliattismo” di certa gioventù democratica – una mimica di dubbia o malriuscita autoironia, ché verrebbe in mente quella poesia di Saba, “a un giovane comunista” (in cui, manco a dirlo, si parteggia per il canarino e i poeti matti più che per Togliatti). Ma lasciamo stare la poesia, in questo tempo totus oeconomicus, specialmente. Il linguaggio si fa spiccio, e a volte rozzo. Renzi, altro riferimento nell’accusa di destrismo (e berlusconismo, stavolta), che ha ricevuto la sprezzante critica di Fassina, dopo aver dato in outsourcing a Zingales la politica economica del PD, aveva parlato del responsabile economico come di «un burocrate chiuso in una stanza del Nazareno», ignorandone il curriculum ma soprattutto il fatto che in questi anni drammatici ha girato quasi tutte le nostre fabbriche in crisi.
Correre ai ripari
Il tema della base politico-culturale del PD – roba grossa, che dovrebbe avere a che fare con il giudizio sul secolo passato, sulla crisi di oggi, e su quale futuro si immagina di (ri)costruire – andrebbe affrontato con serietà e senza riflessi condizionati. Ci s’accorge che il mondo s’è guastato solo quando ti entra in casa, sbattendo i cancelli delle fabbriche – e già si formano accampamenti davanti agli impianti e file alle mense dei poveri. La cultura economica – non solo nella “riserva indiana” dell’eterodossia, anche nel mainstream spiazzato dalla “peggiore crisi eccetera” – si chiede come “rimettere nei cardini” il mondo, o almeno il capitalismo. Persino le librerie della nostra provincia si sono riempite di riflessioni divulgative sulla necessità di un rinnovato ruolo della “cosa pubblica” nell’economia, a partire dal problema delle disuguaglianze vecchie e nuove. Si sono lette le riflessioni sul ripensamento della scienza economica contenute in Bancarotta di J.E. Stiglitz o il recente Dani Rodrik sul “paradosso della globalizzazione“.
“Quali sono i vostri libri? Dove sono le vostre ricerche? Avete studiato?”, si chiese un tempo.
Lasciamo in pace quei tempi, e questi libri. I libri poi non bastano per definizione, e i professori sono tutti al Governo, oramai. Il fatto è che i “pragmatici”, anche tra i liberali, un po’ come fece Keynes a suo tempo, e anche tra i liberisti, si pongono oggi il problema della redistribuzione – è il caso del Financial Times citato e letto da Fassina, ma persino del FMI specie dopo il ruolo decisivo del per altro pessimo Strauss-Kahn. Forse non stanno “cambiando paradigma”, ma è questo ciò di cui si parla nel mondo. Niente e nessuno ne è “fuori”, ma alcune cose vi invecchiano in fretta. Gli anni non passano invano, e nemmeno le ore bruciate dallo spread (“what’s your spread?”, si chiede in giro). L’impianto politico-ideologico che a sinistra ha trovato la sua massima espressione nel new labour è stato con ogni evidenza del tutto insufficiente a evitare che il mondo si guastasse.
E anche alcuni fondamenti del tanto evocato “spirito originario” del PD si sono drammaticamente rivelati falsi: su tutti, la coincidenza di interessi tra capitale e lavoro (tra Calearo e Boccuzzi, per intenderci), uniti in nome dell’innovazione: un’illusione colpevole di fronte alla degenerazione speculativa dei mercati finanziari, a cui molti manager (non solo alla FIAT) prestano ben più attenzione che alle produzioni. Questo significa riaprire un aspro conflitto sociale? No, il conflitto non si è mai chiuso, tanto più nell’Italia di Termini Imerese o di Barletta. Bisogna governarlo con scelte chiare, che spostino la convenienza a investire nell’innovazione dei prodotti e nel miglioramento della qualità del lavoro, piuttosto che sulla rendita finanziaria o sulla speculazione, e difendere ed estendere un sistema di tutele sociali che, garantendo maggiore equità, facciano bene alla crescita. Ci si interroga su come redistribuire e crescere, per riattivare una domanda aggregata che è crollata, che già determina stagnazione e, nei paesi che dovranno attuare politiche di tagli alla spesa, rischio di nuova e stavolta esiziale recessione. È questo il tema da porre all’Europa ridotta a banche e debiti, alla crisi di alcuni stati che è una parte – non così rilevante, ormai – di una peggiore malattia. La cultura economica, non solo quel famoso Nobel, lo fa, rivolge assai preziose critiche all’incompleto – e prima che iniquo, insostenibile – impianto mercatista e intergovernativo dell’Unione, incapace di dare risposte tempestive ed efficaci alla crisi finanziaria dei debiti sovrani che diventa economica ora, e che diventerà infine – alla fine – dell’Unione monetaria e politica.
Un esempio significativo è arrivato dall’Italia con la lettera di molti importanti economisti (che certo non leggiamo con frequenza sulle prime pagine dei nostri conformisti principali quotidiani). Sono critiche attuali, non del “secolo passato”, dettate dall’esigenza di correre ai ripari in questa buriana finanziaria: non è dunque così “fuori dal tempo” chi, come Fassina, nel PD si rifà a questi ripensamenti (per chi, a sinistra, fu protagonista negli anni Novanta) o pensamenti (per chi negli anni Novanta imparava a leggere e scrivere). Ma l’Europa in blu scuro non risponde – e noi, che finalmente ci scopriamo tutti meridionali, dobbiamo provare a fare la nostra parte e un po’ di penitenza. La preoccupazione però rimane – il rigore senza crescita diventa rigor mortis, il risanamento del debito una pia intenzione – per una certa “incoscienza dei liberal”, dei rigoristi, e così via.
Lo scontro nel PD
Nella pressoché totale e miope mancanza di politiche sovranazionali di crescita e di equità (combinate come volete i due termini, devono essere combinati), i principali temi della nostra difficile corrispondenza con le istituzioni europee, che agitano il confronto interno nel PD, diventano le liberalizzazioni, la previdenza, la flessibilità del lavoro – a quest’ultimo s’aggiunge, come altro corno della speciale polemica con Ichino, la questione delle relazioni industriali.
Il “liberismo di sinistra”, di fronte a una crisi e una mancata ripresa dovuta largamente al crollo della domanda interna, del “monte salari” per la vasta disoccupazione e inoccupazione, appare inefficace o insufficiente. Non sfugge a nessuno, ovviamente, la necessità di attuare alcune delle riforme “liberali” che l’Italia non ha mai conosciuto: a partire dalla liberalizzazione di alcuni mondi, come quello delle professioni, marcati da anacronistiche incrostazioni corporative che riducono le opportunità dei giovani. E però, non bisogna farsi illusioni: liberalizziamo pure professioni e notai (questi ultimi sono evocativi, messi in mezzo sembra ogni volta si faccia la rivoluzione), ma non è così che otterremo crescita di prodotto e occupazione; dismettiamo pure patrimoni e partecipazioni, ma la lezione delle privatizzazioni all’italiana dovrebbe spingerci a un po’ di prudenza. E infine, ben al di là dell’esito referendario, e delle opzioni politiche che sono decisive, la questione l’efficienza nella gestione dei servizi locali non si presta a schematizzazioni ideologiche (privato è buono – pubblico è cattivo).
Ora, c’è sempre un problema di merito nelle ricette e un problema di messaggio. Sul messaggio lo scontro era già partito alla Leopolda, perché nel merito le “cento proposte” erano solo la riedizione – un po’ sciatta, per la verità – di mille e cento cose già dette e sentite in un dibattito di idee che a sinistra, ignorato dai giornali, c’è stato anche in questi anni. Vediamo nel merito, le varie questioni.
Lasciamo stare gli sgradevoli, scomposti, sciocchi e inopportuni entusiasmi per Marchionne (di cui ancora si attendono i piani industriali, mentre abbandona l’Irisbus di Avellino e definitivamente, e spudoratamente, Termini Imerese). Sulle relazioni industriali e la riforma della contrattazione l’accordo del 28 giugno tra le parti sociali ha detto parole definitive sulla necessità di mantenere una cornice di contrattazione nazionale – utile alle imprese, forse più che ai lavoratori, nell’evitare continui ricorsi ai giudici del lavoro. L’art. 8 della manovra agostana [pdf] è l’ultimo velenoso lascito di Sacconi. “Quello che serviva ci è stato dato”, ha detto Marchionne: sarebbe un “grazie”, in chiaro stile manageriale. Le parti sociali promettono di non applicarlo, e dal PD sarebbe bene evitare parole di troppo.
“Fondata sul lavoro”
Fondata sul lavoro è un’aspra contesa, ma la tensione polemica francamente appare sopra le righe. Il disastrato mercato del lavoro offre direttrici di azione politica molto chiare, perciò è tanto più utile tener fuori soluzioni e verità assolute.
La lotta alla precarietà è il primo obiettivo: non solo ammazza futuro e destini personali delle nuove generazioni, modificandone i comportamenti sociali e ricavando nuove aree di marginalità: come se non bastasse, fa male al sistema economico nel suo complesso, in quanto deprime la produttività, scoraggiando i percorsi di formazione e innovazione. Ma è la sempre più strutturale carenza di opportunità di lavoro – soprattutto per giovani e donne, soprattutto nel Sud – il problema che nessuna regolamentazione potrà affrontare, se non riprende una dinamica di investimenti, pubblici e privati, che nel nostro Paese ristagnano da anni. Di certo, la flessibilità – che nell’arco di un decennio ha ridotto considerevolmente la protezione del lavoro – non è servita a creare occupazione durevole. Il crollo occupazionale nella crisi (in due anni, mezzo milione di posti di lavoro) si è giovato di certe regole, travolgendo altre, a partire dal “temibile” articolo 18 – che tutela nei confronti dei licenziamenti senza giusta causa (ripetere due volte, per cortesia). La verità è che si tratta di uno spauracchio ideologico, in ogni senso. Non solo perché riguarda una minoranza di medie e grandi imprese, ma perché se davvero fosse stato un ostacolo alla “facilità di assunzione”, queste avrebbero fatto ricorso a contratti precari. Questi ultimi, invece, si concentrano in misura pressoché totale nell’imprese in cui non si applica l’art. 18, e che non avrebbero difficoltà ad assumere a tempo indeterminato secondo un contratto già oggi non troppo dissimile da quello “unico” proposto da Ichino. Insomma, non è certo un’alta protezione del lavoro la causa della scarsa dinamica occupazionale. D’altra parte, non si spiegherebbe la diversità dei tassi di occupazione tra aree geografiche, come accade in Italia, a parità di regole (al Sud, peraltro, per le differenti dimensioni dell’apparato produttivo, l’art. 18 si applica meno).
La lotta al “dualismo” del mercato, poi, è un obiettivo condiviso. Ma la descrizione del problema nella forma di garantiti-non garantiti rischia di essere fuorviante, e bisogna davvero capire quello che è accaduto in questi anni. Sono state le tutele “forti” del lavoro dei padri a rendere deboli e precari i figli, o è stata la precarizzazione del lavoro dei figli a rendere deboli anche quelle che venivano ritenute tutele “forti” dei padri? Se il sistema economico non avesse precarizzato, marginalizzato e infine espulso il prezioso e qualificato capitale umano offerto dalle nuove generazioni, investendo nell’innovazione dei prodotti per migliorare la competitività, forse oggi sarebbero garantiti anche quei quaranta e cinquantenni che, con un contratto nazionale e l’art. 18, vivono da anni in cassa integrazione a zero ore. È stata la spirale di indebolimento generale della produzione e del lavoro a far saltare la distanza – che pure esisteva nelle regole – tra “garantiti” e non garantiti. E non è stata certo solo la miopia di alcune aziende ma una responsabilità generale delle istituzioni, coi mancati investimenti, con l’abbandono di qualsiasi politica industriale. Ecco perché non è una provocazione la richiesta di chiarimenti, avanzata da Fassina dopo il discorso di insediamento di Monti, su chi fossero i “troppo garantiti”. Ben oltre la giungla giuslavoristica, è sul fronte delle tutele sociali che i precari sono abbandonati, a se stessi e alle differenti fortune e disgrazie delle loro famiglie. E allora chi può non essere d’accordo con la flex-security, se aumenta le sicurezze sociali?
La proposta del PD, dopo il congresso del 2009, ratificata da nuovi organismi e assemblee, è di un “diritto unico del lavoro”. Non è il “contratto unico” di Ichino. Perché è troppo di “destra”? Vediamo. Il pregio della chiarezza e della comprensibilità della proposta di Ichino, non consente tuttavia di ridurla rozzamente a destra/sinistra: anzi, a voler cedere a queste fuorvianti semplificazioni, le obiezioni da “sinistra” sono forse meno pregnanti che quelle da “destra”. L’abolizione dell’art. 18 (per i contratti a venire: il “dualismo” pregresso dunque resta, e non toglie nulla ai padri), se ci fosse un serio (e costoso) sistema di protezione sociale, non sarebbe così grave per giovani che nello stato attuale delle cose non lo conoscerebbero comunque. Il problema della proposta è che aumenta enormemente la rigidità della disciplina, eliminando di fatto la flessibilità in entrata (con costi crescenti sull’impresa: e infatti le PMI si guardano bene dal sollecitarla) e generalizzandola in uscita: un po’ il contrario di quello che servirebbe in un periodo di crisi occupazionale.
Il problema fondamentale del dualismo, in realtà, è nel costo del lavoro. Per questo forse la proposta di Fassina e del PD, di un “diritto unico” del lavoro, meno immediata di quella “giacobina” di Ichino, mantenendo una certa articolazione della disciplina in entrata (e in uscita), estendendo le tutele (la previdenza, la formazione, eccetera) ai contratti “precari” da disboscare, forse può rispondere di più e meglio ai bisogni del sistema economico in affanno. Puntando magari, a regime, più sull’abbassamento del costo del lavoro “stabile” che sull’aumento di quello “meno stabile”. Inoltre, è solo dal fronte del costo del lavoro dipendente che, insieme ad una rinnovata etica pubblica, si può affrontare la questione decisiva delle “partite IVA” camuffate, o sofisticatamente sfruttate.
E allora siamo tutti per la flex-security, ci mancherebbe. Solo che in Italia si parte (si è già partiti a tutta spinta) sempre dalla flex e ci si scorda sempre della security. Non bisogna mai dimenticare il “messaggio” della flessibilità, perché prospettare a una generazione un futuro in cui dopo la laurea, si trova subito un lavoro, che sarà quello per tutta la vita, in attesa della pensione, non solo sarebbe un’illusione colpevole, sarebbe tra i peggiori dei futuri possibili – sicuramente migliore di un’intera vita di precarietà, ma comunque pessimo. Ma è la mancanza di una rete di protezione sociale a rendere fragile e immobile questa generazione, incerta e incapace di rischiare, di avere coraggio, di cercare il lavoro migliore o di inventarsene di nuovi. È la security la priorità, dunque, e bisogna sostenere con convinzione l’accelerazione della riforma previdenziale, a patto che i risparmi servano non a fare cassa ma a una riforma universalistica del welfare. Quella riforma di cui abbiamo ancora bisogno per non far confusione – parafrasando Federico Caffè – tra un “tramonto” (del welfare, della sinistra) e una “non raggiunta pienezza di un nuovo giorno”.
Sapendo che confini e strumenti dello Stato non bastano più.
Il governo Monti cambia le cose
Su tutti questi grovigli a sinistra, irrompe il governo Monti. Fossimo maliziosi commentatori, potremmo dire: c’era chi voleva rottamare il “neoliberismo” e chi voleva rottamare i “vecchi”, sono stati rottamati tutti loro. Ma siamo militanti – in particolare di un nuovo equilibrio tra capitale lavoro e ambiente e di un cambiamento di classe dirigente – e ci risparmiamo le battute. Compiremmo poi il torto di fare la caricatura di Monti, che non è la vecchia espressione del potere bancario, e basta leggere il suo rapporto sul rilancio del mercato interno dell’Unione europea per capire che, se si tratta di liberista rigorista, è senz’altro un “pragmatico”.
Delegittimare Fassina, in questo contesto, dicendo che è “fuori tempo” o nel migliore dei casi che “conta poco” (irridendolo quando chiede spiegazioni a Monti o alla BCE), non solo è a mio avviso un torto, ma non aiuta né il PD, né il ricambio, e nemmeno il cambiamento.
La crisi reale, avvitata in quella “irreale” degli spread e dei titoli, non può che mettere in discussione i convincimenti profondi, gli equilibri economici e istituzionali che abbiamo conosciuto fin qui, e spingerci ad azioni e riforme radicali. Trovare il modo di uscirne con più Europa, e più giustizia sociale, riallacciandoci a un movimento mondiale che ripropone con forza, su scala globale, le questioni insuperate della democrazia, della libertà e dell’uguaglianza, non sarà certo semplice. Non sarà semplice nemmeno fare i conti con le specificità italiane: l’insufficienza del modello di welfare, il suo riassetto parziale ed incompleto, l’iniquità del sistema fiscale e l’elevato grado di evasione e di elusione contributiva, concorrono a determinare, soprattutto nelle fasi di crisi, profondi squilibri nella distribuzione degli effetti delle crisi stesse. È così che aumentano i divari tra ricchi e poveri, tra Nord e Sud, e tra adulti e giovani. E dunque servono politiche di equità e di crescita , spostando il carico fiscale dal lavoro e dalla produzione alla rendita e alla speculazione, impiegando anche parte delle risorse recuperate dalla lotta all’evasione, per riavviare una dinamica di investimenti che rimetta in cammino il Paese, ai fini di un risanamento sostenibile.
Il governo Monti non è il governo che avevano in mente il PD e la sinistra. Ma è quello che ci ha consentito di uscire dall’incubo berlusconiano. “Non era possibile un’uscita a sinistra dal berlusconismo”, si dice: non so cosa voglia dire, forse nulla, ma è talmente una frase a effetto che la ripetiamo. È andata così, per fortuna, e ora bisogna andare avanti. Sbrigata la pratica tardiva con Berlusconi, persino con il parlamento dei “peggiori”, con l’occhiuta guardia dell’Europa, con il dramma che incombe, la politica potrebbe rifiorire. Non vedete come già il tono del discorso pubblico è cambiato? Dalle voci dei sotterranei di Arcore e delle ultime intercettazioni si passa al confronto e anche allo scontro su importanti questioni strategiche. Ora, bisogna confrontarsi davvero per trovare le soluzioni migliori per risanare (non solo sul piano finanziario) il Paese ammalato. Al di là delle singole scelte di merito che riterrà di adottare, l’alto profilo del governo e della sfida spingono a fare e chiedere di più. È l’effetto dei “bravi a scuola”, tecnici o politici che siano. Se non sarà il meglio già oggi, facciamo che sia buono per chi verrà domani, sperando non sia troppo tardi. Può essere persino entusiasmante, per i riformisti, tornare a discutere dell’Italia e del mondo, a guardarne il ventre. E tornare a studiare, anche. Come diceva quell’eretico di Napoleone Colajanni, “se non sai di che parli, che cosa vuoi riformare”?
foto: Fabio Ferrari – LaPresse