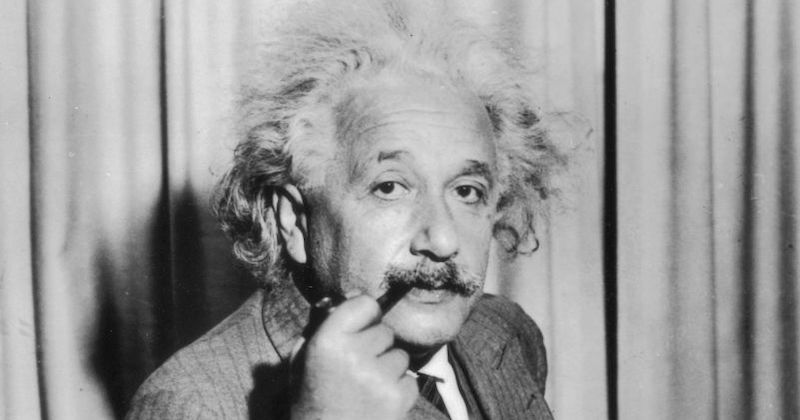Neanche i funerali sono più quelli di una volta
«Si dice che nei momenti dell’addio non si piange chi non c’è più, ma la propria stessa morte. Il lutto si è trasformato in un happening, in un’occasione di socialità»

Il 9 settembre 2021 nel cortile degli Invalides a Parigi si è tenuta la cerimonia in omaggio a Jean-Paul Belmondo. La bara posizionata al centro del cortile e ricoperta dalla bandiera riluceva in una giornata di sole insolita per la capitale francese. Attorno una folla composta da celebrità e gente comune. L’uscita di scena di uno dei più grandi attori del Novecento è stata una messa in scena sacra e patriottica che ha coinvolto le più alte istituzioni alla presenza del presidente Macron e di una folta folla di cittadini.
Le note di Chi mai – il tema musicale parte della colonna sonora composta da Ennio Morricone per il film Le professionnel del 1981 – suonate dalla banda della Guardia Repubblicana si sono riverberate fin oltre Rue de Grenelle mentre le telecamere indugiavano sui visi commossi delle star del cinema francese: da Jean Dujardin a Guillaume Canet, da Marion Cotillard a Gilles Lellouche. Eccola la nuova guardia del cinema transalpino richiamata da un lutto, ma anche da un ruolo che non si può certo rifiutare, quello del testimone.
Si ha sempre una visione distorta dei funerali di persone famose, si pensa ingenuamente che artisti e celebrità abbiano condiviso – già solo per il loro status – una vita insieme di amicizia e affetto, quando invece – come ovvio – si tratta per lo più di relazioni professionali spesso intense, ma brevi e sparse lungo tutta la vita o la propria carriera. Andare a un funerale come quello di Belmondo significa non solo testimoniare con la propria presenza la grandezza di un artista e della storia che ha rappresentato, ma anche interpretare il ruolo del testimone in quanto tale. Questo inevitabilmente trasforma una funzione funebre e la sua sacralità (anche laica) in uno spettacolo con una forma esemplare che, come tale, diviene a seconda dei casi tragicamente o comicamente imitabile.
Il giorno dopo la cerimonia pubblica per Belmondo nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés si sono tenuti i funerali veri e propri ed è qui, alla presenza di una folla decisamente più contenuta, che è apparso Alain Delon in quella che sarebbe stata la sua ultima uscita pubblica. Barcollante sulle gambe, sostenuto da una stampella e dal figlio Anthony, Delon non ha mancato all’ultimo incontro con l’amico che negli anni i rotocalchi avevano dipinto come un acerrimo rivale.
Per quella forma un po’ fatalista e un po’ spudorata di rassicurazione pubblica, tutti si sono detti: almeno lui resiste. Lui c’è ancora. Non tanto per una questione di affetto, anche se con gli anni tutto si perdona anche a figure contraddittorie come quella di Alain Delon, ma di conferma della propria stessa esistenza. La presenza dell’ultimo gigante del cinema francese confermava un legame sentimentale che univa più generazioni. Delon come molti della sua generazione era più grande del cinema attuale, ormai frammentato su infiniti canali.
Il nuovo millennio – soprattutto in Europa – si è contraddistinto per uno stillicidio continuo, ogni giorno, soprattutto ogni estate. Mese dopo mese, anno dopo anno ci si è ritrovati orfani di chi era stato in grado di portarci in massa al cinema, ai concerti, a comprare libri e riviste. È un rito collettivo che non si esaurisce nelle sale dei cinema ma prosegue nelle discussioni da bar e si moltiplica sui social, come sui poster e sulle foto appese nelle camerette degli adolescenti.
– Leggi anche: Muoiono più celebrità di prima?
Il mondo era complicato, ma si presentava come un blocco unico e levigato, facile da riconoscere nelle sue distinte facciate, tutto sommato. Chiunque sapeva chi erano Alain Delon e Jean-Paul Belmondo, per non parlare delle star americane. Il cinema era un sogno collettivo capace di sedurre e coinvolgere in modo più potente perfino dello sport, sempre aggregatore di masse e memoria comune.
I funerali divengono così l’atto finale e dovuto di una società occidentale invecchiata e malinconica, ma anche la dimostrazione più evidente di come quella coesione sociale resista al passare del tempo. Dopo anni di oblio e di vecchiaia non priva di inciampi e difficoltà ecco allora riapparire sulla scena per l’ultimo atto Jean-Paul Belmondo e con lui un pubblico sterminato. Nessuno lo aveva abbandonato e nessuno lo aveva dimenticato.
Nel secondo Novecento i funerali sono stati gli eventi pubblici a cui nessuno avrebbe mai dovuto o voluto mancare, a partire da quello del presidente John Fitzgerald Kennedy il 25 novembre 1963 con il corteo che a piedi – per volontà di Jacqueline Kennedy – attraversa Washington fino al saluto militare che il figlio treenne John-John porge alla bara del padre. E poi nel 1968 quello in movimento di Robert Kennedy, la cui bara a bordo di un treno attraversa gli Stati Uniti salutata da un’infinita folla di persone affastellate lungo i binari. Folla ritratta dal bellissimo reportage di Paul Fusco, RFK Funeral Train. E poi ancora quello fatto da un lunghissimo corteo di Cadillac bianche che nel 1977 accompagna per l’ultima volta Elvis Presley verso Graceland a bordo di una Fleetwood adattata a carro funebre. Anche allora svanivano per incanto gli ultimi disastrosi anni di Elvis trascorsi tra cattiva musica e cattiva alimentazione.
A segnare però un passaggio determinante fu, prima di ogni altro, il funerale di Humphrey Bogart. La sua morte fu una delle prime a diventare un evento collettivo, un dramma in cui sentirsi tutti emotivamente coinvolti. Raggiunto il successo relativamente tardi nella sua carriera, Bogart aveva – anche nella sua vita – totalmente sovrapposto il personaggio all’uomo. Era il prototipo di un modo di stare al mondo. Bogart divenne il suo trench e il suo cappello, cantano Claudio Lolli e Francesco Guccini in Keaton: «Se mi vedessi col mio trench stile Bogart». Uno stile che raggiunse i confini più estremi del globo divenendo sinonimo di un modo di essere, di un genere cinematografico e di un certo maschilismo gentile.
Al suo funerale – come si usa dire – vennero tutte le star del tempo: dal futuro presidente Ronald Reagan a David Niven, da Lana Turner a Lex Barker, da Gregory Peck a Cary Grant. E ovviamente venne l’amico di sempre, John Huston, che tenne un intenso e commovente elogio funebre. Vennero infine anche i grandi produttori con cui Bogart non aveva mai avuto vita facile.
Quel 18 gennaio del 1957 faceva freddo persino a Beverly Hills. Il mondo del cinema americano, nel pieno del suo fulgore, si trovava a celebrare un funerale che ben presto avrebbe riguardato l’intero sistema produttivo e annunciava la fine del circo. Humphrey DeForest Bogart, nato il giorno di Natale del 1899, quattro anni dopo la nascita del cinema, si separava per sempre dal suo personaggio cinematografico, che sarebbe arrivato a noi attraverso la televisione, i VHS e i DVD. Sarebbe diventato noto come persona al pubblico solo da morto, come avviene a tutte le star, ovvero attraverso biografie più o meno autorizzate e libri bellissimi come Caro Bogart di Jonathan Coe e documentari come quello di Kathryn Ferguson, Bogart: Life Comes in Flashes, che riprende anche parti dal suo diario privato.
Quel sogno e quella meraviglia, frutto di un controllo ossessivo sulla vita dei suoi artisti da parte delle major, dei produttori e degli agenti, che aveva impedito che ogni notizia equivoca e lato oscuro potesse venire a galla, veniva infranto così nel post mortem. La storia non poteva fermarsi e inevitabilmente avrebbe indagato e messo il naso anche là dove non si sarebbe voluto. Quelle rivelazioni avrebbero incrinato la fama ma anche reso umane quelle che fino ad allora erano state viste come divinità. Il «The end» del cinema scompariva dai titoli di coda per ricomparire nella realtà, punteggiando di mancanze, lutti e assenze improvvise le vite di ognuno di noi.
Forse per questo, dopo aver presenziato a praticamente tutti gli addii delle celebrità del mondo dello spettacolo francese, Alain Delon ha lasciato scritto di non volere alcuna cerimonia pubblica e tantomeno onori istituzionali all’indomani della sua scomparsa. Era giusto così. E anzi, finalmente! Tutto quel dolore per degli estranei era assurdo.
Si dice che ai funerali o nei momenti dell’addio non si pianga chi non c’è più, ma la propria stessa morte. È successo così, ripetutamente e per anni, per le star e celebrità fino a esaurire ogni possibilità di futuro. Il digitale ha reso perenne e contemporaneo il passato trasformandolo in un archivio aperto da alimentare e aggiornare continuamente, in una coazione a ripetere ossessiva e obnubilante. Un contenitore così efficace da rendere ogni passato enormemente più rilevante di ogni possibile presente.
Il lutto si è trasformato in un happening, in un’occasione per molti versi unica di socialità. Un funerale famoso al bar vale quanto una finale di Champions ed esattamente come nelle partite di calcio, ciò che si pensa vale più di ciò che realmente si sa. Al punto che non conta esserci stati davvero, ma farlo apparire con un post o con una story. Al funerale di Berlusconi piazza del Duomo era quasi vuota, ma poco è contato rispetto alla narrazione televisiva, alla possibilità di emozionare milioni di italiani connessi. Del resto nessuno è stato esperto di televisione e illusionista quanto Berlusconi: il suo funerale non è stato che il trionfo mediatico di un narratore per nulla privo di qualità.
Ma accade anche che i funerali, cambiando funzione, cambino di senso e di forma perdendo tutti i rituali e la sacralità che dovrebbero contraddistinguere un lutto. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha trovato naturale e conveniente farsi un selfie davanti alla bara di Pelé, come se fosse un vero e proprio omaggio al morto. La celebrità defunta trasferisce simbolicamente la propria notorietà al suo pubblico, compresi prèfiche, necrofori e becchini.
– Leggi anche: La piazza che non c’era
Dall’eterno attuale siamo piombati in un infinito passato, e chi aveva il ruolo di testimone ora diviene protagonista. Il funerale in forma di performance, come un’opera di Francesco Vezzoli, non stigmatizza più la morte, ma la celebra come unica possibilità, confermando che l’esistenza di tutti noi è percepibile solo nella sua fine. Ma esistere nella morte altrui assomiglia a una forma di cannibalismo che si nutre della vita privata del morto perlustrandola e commentandola, e ne smembra la celebrità trasformandola in lessico famigliare. È comprensibile che Delon, sia in morte che in vita, abbia preferito accontentarsi della compagnia dei suoi cani.