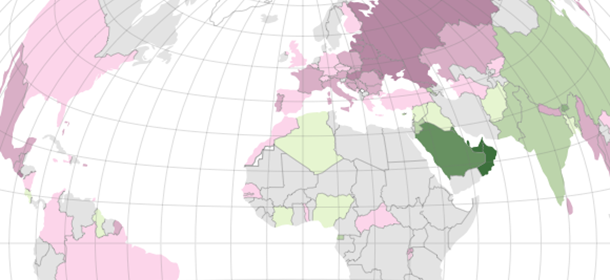La Corte Suprema degli Stati Uniti non ritiene le aziende informatiche responsabili dei post degli utenti
In due sentenze ha deciso che non possono essere perseguite legalmente per favoreggiamento del terrorismo

La Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata su due diversi casi dando ragione alle aziende informatiche come Google, Facebook e Twitter e stabilendo che non sono legalmente responsabili per i contenuti di propaganda a sostegno delle organizzazioni terroristiche pubblicati dai loro utenti. Le sentenze erano molto attese perché si pensava avrebbero riguardato la Sezione 230 del Communications Decency Act, una legge degli Stati Uniti approvata nel 1996 che garantisce alle aziende informatiche di non poter essere ritenute legalmente responsabili per i contenuti pubblicati dai loro utenti, come per esempio i post sui social network. Di fatto, però, la Corte ha evitato di pronunciarsi direttamente sulla Sezione 230.
Il primo caso, “Twitter v. Taamneh”, riguardava Nawras Alassaf, morto durante l’attentato in un locale di Istanbul compiuto il primo gennaio del 2017 da un memebro dell’ISIS: i parenti della vittima ritenevano che Twitter, Google e Facebook potessero essere considerate in parte responsabili dell’attacco perché i loro sforzi per rimuovere i contenuti del gruppo terroristico non erano stati abbastanza efficaci. Una corte d’Appello aveva stabilito che le società potessero essere perseguite in base alle leggi antiterrorismo che consente alle famiglie delle vittime di fare causa contro chi ha fornito assistenza materiale ai responsabili di attacchi terroristici.
Twitter si era rivolta alla Corte Suprema per ribaltare questa decisione e la Corte le ha dato ragione. Il giudice di orientamento conservatore Clarence Thomas, nel suo parere, ha scritto che «le accuse dei querelanti non sono sufficienti per stabilire che gli imputati abbiano aiutato e incoraggiato l’ISIS a portare a termine l’attacco in questione». Il giudice ha anche scritto che la mancata rimozione dei contenuti dell’ISIS da parte delle piattaforme «non è stata sufficiente per stabilire la loro responsabilità di favoreggiamento» che richiede accuse e prove di un’assistenza consapevole e sostanziale. Una decisione contraria a quella presa, ha aggiunto, avrebbe esposto le piattaforme alla potenziale responsabilità per «ogni singolo atto terroristico dell’ISIS commesso in qualsiasi parte del mondo».
La decisione della Corte su questo primo caso ha consentito ai giudici di evitare di pronunciarsi sull’ambito di applicazione della Sezione 230. Il secondo caso riguardava Nohemi Gonzalez, una studentessa statunitense di 23 anni uccisa a Parigi durante gli attentati terroristici avvenuti il 13 novembre del 2015. Il gruppo degli attentatori – il cui unico sopravvissuto, Salah Abdeslam, è stato condannato all’ergastolo – aveva rivendicato la propria appartenenza all’ISIS. I genitori di Gonzalez e alcune associazioni che avevano seguito il loro caso dal punto di vista legale sostenevano che gli attentatori si fossero radicalizzati e legati allo Stato Islamico anche guardando video pubblicati su YouTube. In sostanza, ritenevano che YouTube fosse parzialmente responsabile per la morte della loro figlia, e quindi avevano denunciato sia YouTube sia Google, la società che all’epoca lo possedeva (ora fanno entrambi parte di Alphabet).
Questo caso si è concluso con un parere non firmato di tre pagine in cui la Corte si limita a confermare la sentenza di un tribunale di grado inferiore che riteneva Google non perseguibile per favoreggiamento. Nel parere c’è anche scritto esplicitamente che la Corte, relativamente a questo caso, non avrebbe «affrontato l’applicazione della Sezione 230». L’ha dunque rinviato alla corte d’Appello «alla luce della decisione» “Twitter v. Taamneh”.
Le due sentenze della Corte Suprema erano molto attese perché si pensava potessero riguardare direttamente uno dei pezzi più importanti di internet per come lo conosciamo oggi: la Sezione 230 che è stata spesso oggetto di critiche e discussioni nei dibattiti sulla libertà di espressione online, soprattutto sui social network. Venne introdotta nel 1996, quando internet iniziava a diffondersi in tutto il mondo, e in particolare negli Stati Uniti: non esistevano i social network né gli smartphone, l’e-commerce era ancora agli inizi, le aziende che operavano esclusivamente online erano assai rare. Si pensava insomma che internet fosse una struttura “neutra”, una scatola vuota i cui contenuti erano creati e condivisi dagli utenti, e che quindi fossero loro a doverne rispondere da un punto di vista legale, eventualmente.
Anche i più diffusi social network, quasi tutti statunitensi, fino a pochi anni fa sostenevano di essere delle piattaforme sostanzialmente neutrali, con uno scarsissimo impatto sulla diffusione e la circolazione dei propri contenuti. Negli ultimi anni si è capito che le cose non stanno più così: diverse inchieste giornalistiche hanno dimostrato per esempio come l’algoritmo di YouTube che suggerisce all’utente quali video guardare proponga contenuti sempre più polarizzati e radicali, nella speranza di tenerlo sempre più agganciato allo schermo (e quindi ai contenuti pubblicitari con cui YouTube inframmezza i propri video).
QAnon, la teoria complottista di estrema destra più diffusa nella politica statunitense, ha guadagnato decine di migliaia di seguaci grazie alla diffusione dei suoi video su YouTube e Facebook, oltre alla proliferazione di propri contenuti su alcuni social network più prettamente testuali come Reddit e 4chan. Negli ultimi anni il rapido aumento di contenuti di propaganda terrorista, ma anche razzisti, misogini e ostili alla comunità LGBTQ+ ha reso necessario un controllo sempre più stretto da parte delle piattaforme, quindi la messa a punto dei meccanismi interni di moderazione.
Secondo alcuni osservatori tutte queste attività, sia il suggerimento di contenuti da fruire sia, più in secondo piano, un maggiore intervento sulla moderazione, rende di fatto le grandi piattaforme paragonabili agli editori, e quindi più distanti da ciò che prevedono la Sezione 230 negli Stati Uniti e leggi simili in altri paesi.
Facebook e le altre aziende informatiche respingono da sempre questa visione: sostengono di non potere essere equiparate agli editori, perché offrono comunque un servizio diverso ed estraneo alla produzione di contenuti propri e hanno accolto come una vittoria le sentenze della Corte Suprema.
– Leggi anche: Google sta riducendo i suoi famosi benefit per i dipendenti