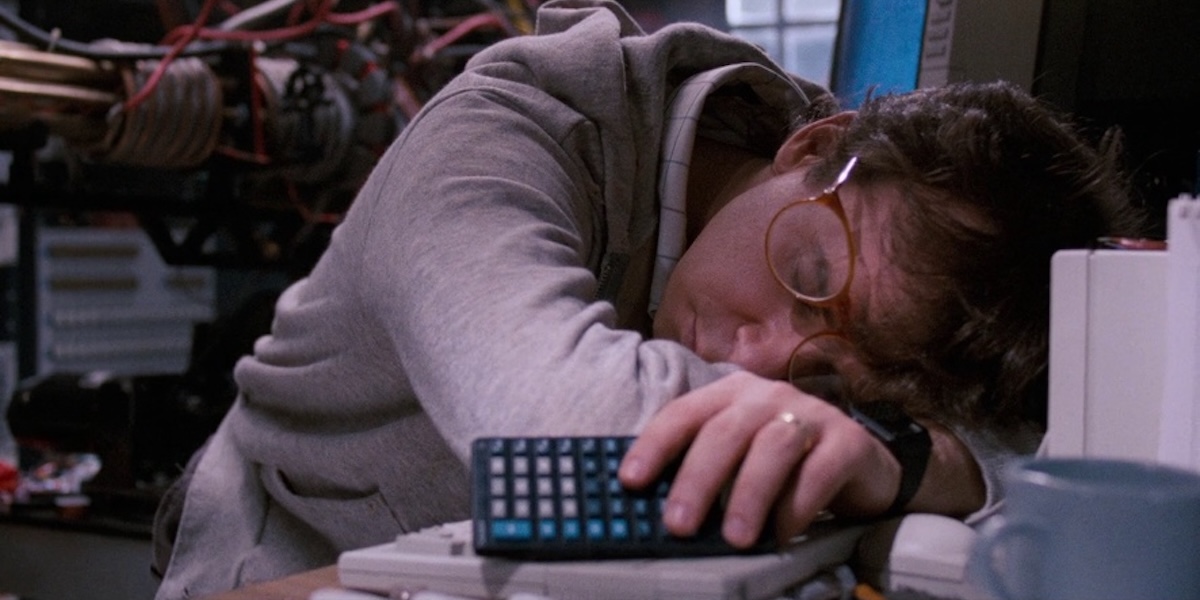La scienza non è “neutra”
L’idea sbagliata che sia sospinta dalla ricerca della verità assoluta indipendentemente dalla politica, dall'economia e dalla società è alla base di equivoci nel dibattito

Nell’ottobre del 2020, poche settimane prima delle elezioni presidenziali americane, l’autorevole rivista scientifica Nature pubblicò un articolo molto critico nei confronti dell’allora presidente Donald Trump. L’articolo, intitolato “Come Trump ha fatto danni alla scienza e perché potrebbero volerci decenni per rimediare”, circolò molto e riattivò – indipendentemente dalle critiche al presidente e prima ancora del successivo endorsement della rivista per il candidato democratico Joe Biden – un dibattito ricorrente e molto esteso sui rapporti tra la scienza e la politica.
Ad animare la discussione fu una parte di commentatori che ritenne l’articolo di Nature una sorta di sconfinamento della rivista in un ambito non di sua pertinenza, sostenendo l’idea che la scienza debba occuparsi soltanto dei «fatti» – uno stereotipo molto diffuso anche nell’informazione – e riguardare soltanto «studi con dati empirici», come riportato in vari commenti all’articolo sui canali social. Da una di quelle obiezioni – «attenetevi alla scienza» – Nature trasse in seguito il titolo per una serie di podcast in cui il redattore della rivista e conduttore Nick Howe, dialogando con colleghe e colleghi, e con altre persone attivamente impegnate nella ricerca scientifica, approfondì il tema del rapporto tra scienza e politica, e la convinzione diffusa che esista una separazione chiara e netta tra l’una e l’altra.
In diversi articoli, analisi e libri pubblicati da ricercatori, divulgatori e giornalisti scientifici, durante la pandemia e anche prima, l’idea che la scienza sia un’attività “neutra”, basata su dati “empirici” la cui composizione e raccolta non siano condizionate dal contesto politico, sociale e culturale in cui l’attività di ricerca è realizzata, è stata descritta come un equivoco molto diffuso e, nella peggiore delle ipotesi, come una fonte di possibili alterazioni dei normali processi democratici e delle istituzioni.
Appellarsi alla scienza e alle “verità inconfutabili” che sarebbe in grado di produrre, sostengono molti autori e autrici di quelle analisi, è uno strumento retorico comune e un comportamento trasversale a molte parti politiche contrapposte che sfruttano una convinzione popolare per tentare di legittimare le loro azioni. È però un comportamento che rafforza un’idea molto parziale di scienza, nella misura in cui non tiene conto di un suo tratto essenziale, ossia che le conoscenze scientifiche non sono vere in astratto ma verificabili a partire dall’esperienza da cui sono ottenute, e che la possibilità di confutarle è parte integrante della loro definizione. Soprattutto, trascura il fatto che la raccolta di dati empirici sia generalmente guidata da ipotesi e teorie a loro volta collegate ad attività di ricerca condizionate da altri fattori all’interno degli specifici contesti storici e sistemi di valori culturali in cui sono svolte.
– Leggi anche: Gli italiani che hanno vinto il premio Nobel
Taylor Dotson, professore associato di Scienze sociali al New Mexico Institute of Mining and Technology, ha descritto i tentativi recenti di slegare la scienza dalla politica nel dibattito pubblico, e gli effetti di queste pratiche, nel libro The Divide: How Fanatical Certitude Is Destroying Democracy, da poco pubblicato per MIT Press, la casa editrice universitaria del Massachusetts Institute of Technology. «Cosa succede alla politica quando i cittadini iniziano a credere che la scienza dovrebbe risolvere i disaccordi pubblici e quando gli appelli retorici ai “fatti” iniziano a dominare le giustificazioni delle persone per le loro visioni politiche del mondo e delle loro azioni?», si è chiesto Dotson.
Per comprendere e inquadrare le relazioni più immediate ed evidenti tra la scienza e la politica, secondo Dotson, alcuni storici della scienza hanno fatto spesso riferimento ai casi ampiamente documentati di interessi di gruppi – industriali o di altro tipo – favoriti da istituti e scienziati di alto livello e con solidi agganci politici. Le loro ricerche e pubblicazioni in merito a particolari risultati scientifici emergenti, più che essere guidate dalla volontà di migliorare le conoscenze, nascondevano in realtà un interesse a individuare e presentare dati fuorvianti e accrescere l’incertezza nel dibattito, al fine di rallentare o influenzare annunciati cambiamenti normativi scomodi per quei gruppi che li avevano sponsorizzati.
È il caso, per esempio, degli sforzi compiuti dalle multinazionali dei combustibili fossili o del tabacco per finanziare ricerche che alimentassero dubbi sull’esistenza del cambiamento climatico e degli effetti dannosi del fumo. In questi esempi le conoscenze scientifiche prodotte dalla ricerca finanziata dall’industria sono tuttavia spesso intese e descritte come il risultato perverso di processi “contaminati” da fattori esterni, che in circostanze normali sarebbero assenti. E non c’è dubbio, afferma Dotson, che gruppi di potere possano a volte produrre dati distorti per confondere intenzionalmente il dibattito pubblico.

Una manifestazione di sostegno alla ricerca scientifica, organizzata nell’ambito dell’evento “March for Science”, a Madrid, sabato 22 aprile 2017 (AP/Daniel Ochoa de Olza)
Ma l’idea che la scienza sia qualcosa di «puro» purché non sia contaminata da incentivi al profitto aziendale, secondo Dotson, si fonda su una concezione che trascura «gran parte dei dati sociologici e antropologici sulla produzione stessa dei fatti». «La scienza è sempre stata politica» e gli scienziati non sono «esploratori monastici della verità», afferma Dotson citando le ricerche di Daniel Sarewitz, docente di Scienze politiche e sociali all’Università statale dell’Arizona.
Secondo Sarewitz, uno tra gli studiosi contattati anche da Nature nel podcast “Stick to the science”, l’idea che la ricerca scientifica sia politicamente neutra, ossia guidata esclusivamente dalla curiosità e rivolta all’individuazione della verità assoluta, piuttosto che da necessità politiche o da determinati valori culturali, rientra nel «mito della ricerca libera». L’aumento dei finanziamenti alla ricerca in campo biomedico, per fare un esempio, non è dovuto al fatto che questo ambito sia improvvisamente diventato oggetto di maggiore curiosità ma piuttosto al desiderio di migliorare la salute pubblica e alle aspettative elevate riguardo a nuove cure brevettabili e pertanto redditizie.
Questo non significa che tutti i finanziamenti alla scienza abbiano soltanto questo tipo di motivazioni, secondo Sarewitz, ma riconoscere in generale che esistano delle influenze sulla ricerca vuol dire comprendere prima di tutto che i finanziamenti tendono a concentrarsi in determinati ambiti anziché altri in funzione di molti fattori diversi dalla semplice curiosità, che siano interessi economici o politici più o meno estesi, o attenzioni a valori ampiamente condivisi come la difesa militare, il miglioramento della competitività economica nazionale o la cura delle malattie più diffuse.
Quando poi la ricerca medica è sostenuta attraverso fondi privati, è frequente che a ricevere maggiori attenzioni siano le malattie che interessano la parte benestante della popolazione. «Si spende di più per la fibrosi cistica e la disfunzione erettile che per le malattie tropicali e l’anemia falciforme [una malattia genetica del sangue che interessa prevalentemente la popolazione afroamericana]», fa notare Dotson. E altri condizionamenti significativi in generale, prosegue con gli esempi, derivano dagli effetti prolungati dell’impostazione androcentrica e delle credenze sul genere nella ricerca medica e nella sperimentazione, che per decenni hanno determinato una sottorappresentazione della popolazione femminile e limitato la comprensione di problemi di salute specifici nelle donne.
– Leggi anche: Gli stereotipi di genere alterano la ricerca scientifica
L’insieme degli interessi politici e dei valori culturali presenti all’interno di una società modella la scienza in quasi ogni sua fase, dalla decisione di quali fenomeni studiare alla scelta di come studiarli e come parlarne, secondo Dotson. Ma il frequente ed erroneo inquadramento della scienza come «intrinsecamente apolitica», come attività neutra, «pura» e credibile fintanto che non subentrino interventi esterni di politicizzazione, impedisce un dibattito collettivo critico e più approfondito su quali influenze politiche siano semmai da ritenere appropriate e quali no. Per esempio: intraprendere azioni che incrementino le possibilità per le donne di diventare scienziate, sostiene Dotson, è «politica» in un senso molto diverso dall’oscuramento intenzionale degli effetti dannosi del fumo.
Una delle conseguenze della diffusa convinzione che la scienza e la politica siano attività perfettamente distinte, prosegue Dotson, è che molte persone hanno cominciato a vedere la scienza come qualcosa da isolare e tenere distante da qualsiasi possibile influenza politica, e la politica come qualcosa che possa e debba essere guidata completamente dall’evidenza scientifica. Questa visione «dogmatica» tende ad accrescere le aspettative e produrre inevitabili delusioni tra chi pensa che una sorta di «politica scientifica apolitica» possa risolvere questioni controverse nel dibattito pubblico, aggirando o ovviando alle differenze nei valori culturali e nelle visioni del mondo di cui sono portatori tutti coloro che partecipano a quel dibattito, incluse peraltro le stesse persone che lavorano nella scienza.

Una manifestazione contro l’introduzione del vaccino antinfluenzale obbligatorio nelle scuole del Massachusetts, a Boston, il 30 agosto 2020 (Scott Eisen/Getty Images)
La ricerca di prove scientifiche è peraltro un’attività difficile e «profondamente innaturale», scrisse nel 2017 il giornalista scientifico David Roberts in un articolo sul sito di notizie Vox, in occasione delle manifestazioni “March for Science” organizzate per mostrare sostegno alla ricerca scientifica. «Noi esseri umani non siamo stati modellati dall’evoluzione per identificare la verità. Perché dovremmo? L’appartenenza a una tribù ha molto più valore di sopravvivenza rispetto all’accuratezza oggettiva», premise Roberts, attribuendo piuttosto alle religioni la preoccupazione di cercare verità.
Per Steven Shapin, storico della scienza dell’Università di Harvard sentito da Nature per il podcast “Stick to the science”, l’idea che la scienza e le istituzioni scientifiche siano fondamentalmente separate dalla politica e dalle istituzioni politiche «deriva probabilmente dell’idea dell’isolamento dal mondo per motivi religiosi come un modo per produrre conoscenza autentica e preziosa». E non è un caso, afferma Shapin, che le prime università fossero istituzioni religiose, considerate il luogo più adatto alla ricerca di verità oggettive.
Secondo Roberts gli esseri umani sono invece piuttosto fatti per cercare connessioni sociali e identità, e nella loro ostinata ricerca di una comprensione del mondo e del loro posto in esso non sentono la necessità di ricavare delle verità, accontentandosi in genere di ottenerne una «buona versione». E quindi tendono istintivamente a completare le loro visioni imperfette del mondo con storie, miti, supposizioni ereditate e congetture. Ed è qui che interviene la scienza, che non è un insieme di certezze – territorio di altri discorsi umani, come la religione, appunto – bensì «un tipo di tecnologia sociale intesa a controbilanciare la nostra propensione individuale all’errore, attraverso un reciproco controllo dei fatti».
– Leggi anche: Perché vediamo cose che non ci sono
La scienza contiene quindi probabilità, margini di errore e gradi di attendibilità in una scala di continuità, ma non certezze, afferma Roberts. E non esistono prove empiriche sufficienti per dirimere molte questioni morali e discrezionali, competenza invece della politica e delle decisioni umane. La scienza «può aiutarci a capire quali politiche aiutano i malati e i più vulnerabili, ma non può dirci se, o quanto, dovremmo aiutarli». Può dirci quali effetti avranno le emissioni di anidride carbonica sulla salute pubblica ma non può dirci se dovremmo prevenire quella sofferenza, o come soppesarla rispetto ad altre considerazioni.
«Migliorare i processi decisionali della società è qualcosa in cui tutti sono sempre e già coinvolti, e non ha senso fingere che la scienza possa fare quel lavoro per noi», sostiene Roberts. Nella pratica la scienza stessa è un insieme di istituzioni e norme tra le altre, in un ecosistema sociale più ampio: «fa parte della politica, quindi è inevitabilmente politica». Né c’è ragione per cui la scienza dovrebbe rimanere isolata, come alcune persone preferirebbero che fosse: è del tutto normale che gli istituti di ricerca, i laboratori e le università che si occupano di scienza si preoccupino di come possa continuare a essere realizzata.

Una manifestazione organizzata nell’ambito dell’evento “March for Science”, a Los Angeles, il 22 aprile 2017 (AP/Reed Saxon)
La tendenza a cercare risposte dirimenti in una presunta scienza neutra, completamente avulsa dalla politica, è sembrata particolarmente condivisa e diffusa durante la pandemia. L’epidemiologia è diventata un «teatro di guerre culturali», ha scritto in un articolo sulla rivista statunitense The Nation Danielle Carr, una scrittrice che si occupa di storia della scienza e della medicina, dottoranda in neuroingegneria alla Columbia University.
Moltissime persone, sia il vicino di casa complottista sui vaccini che il «tecnocrate progressista» del quartiere, hanno mostrato secondo Carr un sostanziale accordo in merito all’importanza e alla necessità di un maggiore accesso della popolazione ai «fatti» che riguardano la scienza, specialmente nel caso di questioni relative alla salute. Ma in generale l’accordo si è esaurito in quella richiesta iniziale comune. Per il resto, afferma Carr, l’obiettivo del complottista era probabilmente quello di vedere un più diffuso scetticismo sui vaccini e sugli interessi delle aziende farmaceutiche («Big Pharma»), mentre quello del tecnocrate era di vedere una più estesa comprensione pubblica, per esempio, delle modalità di trasmissione virale.
Una difficoltà di chi nell’ultimo anno e mezzo ha sostenuto la necessità di fidarsi della scienza e delle opinioni degli scienziati sulla pandemia è stato il continuo progresso delle nostre conoscenze sul coronavirus e sulla sua trasmissione, che in certi casi è passato per la negazione di cose che prima si pensavano certe. Ancora settimane dopo la scoperta del virus in Italia, per esempio, le mascherine erano ufficialmente sconsigliate dalle autorità nella maggior parte dei casi, prima di rivelarsi uno dei più importanti strumenti di contenimento del contagio.
Se questo tipo di evoluzioni nel consenso scientifico è fisiologico e normale, è anche un promemoria di quanto siano in realtà relative e temporanee le nostre convinzioni scientifiche, quelle che talvolta siamo più o meno consapevolmente inclini a considerare verità assolute e inconfutabili. La velocità con cui si sono evolute le nostre conoscenze sul SARS-CoV-2 è stata senza precedenti nella storia – e ha comportato alcuni ripensamenti anche clamorosi, e non è da escludere che ce ne possano essere altri in futuro –, come testimoniato dalla rapidità dello sviluppo di vaccini efficaci e sicuri.
Quei vaccini sono arrivati così in fretta e così numerosi perché la ricerca scientifica che li ha resi possibili è stata finanziata come non era mai successo prima dai governi e dal settore privato, motivati dagli evidenti e urgenti interessi economici e politici affinché venissero sviluppati. Un esempio sicuramente eccezionale ma piuttosto illustrativo di come il contesto sociale, economico e politico possa influenzare la scienza.
Peraltro, le tecnologie a mRNA che sono state sperimentate per la prima volta su larga scala per la produzione di vaccini contro il coronavirus sono molto promettenti per lo sviluppo di vaccini contro altri virus, come l’HIV.
«In sostanza, il disaccordo riguarda la nozione stessa di cosa sia la scienza. La scienza è un processo unico e universale che si distingue dalle lotte per il potere e per le risorse, ossia la politica? O scienza è il nome di molteplici processi, intrapresi da diversi gruppi di persone per obiettivi diversi, tutti condotti proprio nelle trincee della lotta politica?», si chiede Carr. La risposta a questa domanda, prosegue, dipende da come la pensiamo sul tipo di «fatti» di cui riteniamo sia opportuno rendere conto quando istruiamo il pubblico sulla scienza.
– Leggi anche: Si fa presto a dire “no vax”
La divulgazione scientifica, da questo punto di vista, è spesso considerata un’attività fondamentale per colmare la distanza tra il pubblico e le persone che lavorano nei laboratori e nelle università. E in particolare, sostiene Carr, è la risposta a un problema che la scienza pone nelle democrazie: «se la scienza è necessaria per la sicurezza nazionale e per il progresso economico, come può essere governata democraticamente da cittadini non attrezzati per capire cosa succede in laboratorio?». Il rischio è che quelle conoscenze scientifiche, anziché essere governate dalla democrazia, possano costituire un pericolo per la democrazia stessa.
Carr cita un passaggio di un discorso pronunciato nel 1961 dal presidente dell’emittente radiotelevisiva CBS, Frank Stanton, in occasione del centenario del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
«L’estrema importanza della scienza e dell’ingegneria nel progresso della società moderna è abbondantemente chiara. Dovrebbe essere altrettanto chiaro che la competenza tecnica da sola non è sufficiente per far fronte alla più grande crisi che deve affrontare il mondo libero: la conservazione delle nostre istituzioni democratiche».
Il problema, chiaro a Stanton, di tenere la cittadinanza sufficientemente al passo con la ricerca scientifica è secondo Carr ancora più urgente per le democrazie tecnologicamente evolute. E i divulgatori scientifici possono in questo senso assolvere un duplice compito: persuadere la popolazione a preoccuparsi abbastanza della scienza da continuare a votare per finanziarla, e aiutare la popolazione a comprendere la scienza abbastanza bene da poter affrontare i dilemmi politici ed etici che pone.
Nel suo libro del 1995 Il mondo infestato dai demoni, pubblicato in Italia da Baldini&Castoldi e attualmente fuori produzione (è disponibile l’edizione inglese), il famoso astronomo e divulgatore scientifico Carl Sagan, morto nel 1996, scriveva che «la scienza è qualcosa di più di un corpus di conoscenze: è un modo di pensare». E affermava – dimostrando, secondo Carr, una piena ed esplicita comprensione della dimensione politica del suo lavoro e delle possibili conseguenze del fallimento – che compito del divulgatore sia quello di attrezzare il pubblico per guidare la scienza.
«Immagino a volte l’America del futuro, quando i miei figli o i miei nipoti saranno grandi; quando gli Stati Uniti saranno un’economia di servizi e d’informazione; quando quasi tutte le più importanti industrie manifatturiere saranno passate ad altri Paesi; quando incredibili poteri tecnologici saranno nelle mani di pochi, e nessun rappresentante dell’interesse pubblico sarà neppure in grado di comprendere i problemi; quando le persone avranno perso la capacità di stabilire i propri programmi e di rivolgere domande con cognizione di causa a chi detiene il potere; quando, nervosamente aggrappati alle nostre sfere di cristallo e ai nostri oroscopi, con le nostre facoltà critiche in declino, incapaci di distinguere tra ciò che ci sembra buono e ciò che ci sembra vero, quasi senza rendercene conto scivoleremo nella superstizione e nelle tenebre».
Carr sospetta che, rispetto ai decenni scorsi, alcuni professionisti della divulgazione scientifica sentano meno la necessità di esplicitare e chiarire le connessioni profonde tra la scienza e la politica. Nell’articolo fa riferimento più volte e criticamente al celebre libro A Planet of Viruses, scritto nel 1998 dal giornalista scientifico Carl Zimmer e recentemente aggiornato per includere un capitolo sul virus SARS-CoV-2 e sulla COVID-19. Zimmer, peraltro collaboratore del New York Times, è quasi unanimemente considerato uno tra i più rispettati divulgatori scientifici americani.
Per comprendere l’approccio di Zimmer alla divulgazione, Carr cita e trova significativo un passaggio di un discorso da lui tenuto alla Rockefeller University, prestigiosa università privata dell’Upper East Side, a New York, poco dopo l’elezione di Trump. In quell’occasione Zimmer parlò a una platea di aspiranti autrici e autori di articoli scientifici dei rischi di presentare «entrambi i lati della storia» quando si tratta di questioni su cui esista un consolidato consenso scientifico.
«Se state scrivendo di tettonica a zolle, non sentitevi in colpa per non aver riportato l’opinione di chi pretenda lo stesso spazio per il suo PDF online di 200 pagine sulla teoria che non esiste la deriva dei continenti perché la Terra è cava. Questo rende faziose le vostre presentazioni? Domanda assurda per un giornalista scientifico. “Salve, mi chiamo Carl Zimmer e sono a favore della tettonica a zolle”».
Carr interpreta questo passaggio come una prova dell’opinione di Zimmer sul rapporto tra scienza e politica, declinato in termini di sostanziale opposizione. Per Zimmer, non si può essere a favore o contro la tettonica a zolle, perché si sta semplicemente riportando dei fatti. Per lui il racconto della scoperta scientifica, del come e del perché siano prodotte le conoscenze – e anche del «perché le persone potrebbero diffidare» di quelle conoscenze – non dovrebbe far parte della storia di cui i giornalisti scientifici devono occuparsi.
Questo approccio, secondo Carr, trascura il racconto degli evidenti fattori politici a monte del lavoro quotidiano di chi fa scienza. Restano del tutto escluse domande essenziali come «Chi ha pagato per i laboratori e la ricerca? Chi detiene i diritti di proprietà intellettuale? Qual è lo scopo di quella ricerca? È per costruire armi, per progettare un Green New Deal o per fare un sacco di soldi? Quali sono le condizioni di lavoro in cui vengono condotte quelle ricerche scientifiche e al servizio di chi?».
– Leggi anche: Il Green Deal europeo, spiegato bene
Nel libro A Planet of Viruses, secondo Carr, sono magnificamente descritti i meccanismi attraverso cui il virus si lega alle cellule umane per replicarsi, ma è completamente assente la descrizione di un contesto che aiuti a «fissare questi fatti in uno sfondo storico o politico». È come se l’intero discorso, prosegue Carr, si reggesse sulla convinzione che gli elettori poco informati «sarebbero meno inclini alle teorie del complotto sulla COVID-19 se solo sapessero che i mitocondri sono la centrale elettrica della cellula». Ma queste informazioni, per quanto necessarie, non sono sufficienti a comprendere «la posta in gioco sociale e politica della ricerca scientifica».
Per esempio, nel capitolo in cui affronta l’HIV (il virus collegato all’AIDS), Zimmer racconta che i patologi scoprirono che proveniva da un virus dei primati. Non c’è alcun riferimento al fatto che l’amministrazione del presidente Ronald Reagan bloccò i finanziamenti federali per la ricerca sull’HIV, ricerca che avrebbe potuto arginare un’epidemia mortale di AIDS che fu però accettata, scrive Carr, «come una punizione divina inviata per affliggere l’orda di cattivi finocchi della nazione». Fu peraltro proprio l’immunologo Anthony Fauci – oggi noto consigliere del presidente per le questioni sanitarie – a fare pressione sul governo di Reagan, attraverso il responsabile del servizio sanitario pubblico Charles Everett Koop, perché riconoscesse l’emergenza e intervenisse per arginarla.

Anthony Fauci durante una conferenza del presidente Trump, a Washington, DC, il 10 aprile 2020 (Alex Wong/Getty Images)
Nel capitolo sul virus responsabile della cosiddetta influenza spagnola, che nel 1918 causò la morte di un numero di persone compreso tra 50 e 100 milioni in tutto il mondo, non sono presenti dettagli relativi al contesto in cui l’epidemia si diffuse. «Non sapresti mai che fu facilitata dai movimenti di truppe attraverso lo scenario europeo della Prima guerra mondiale, o che i suoi effetti negli Stati Uniti furono concentrati nelle comunità di immigrati venuti a lavorare nelle metropoli in via di industrializzazione del paese», aggiunge Carr.
Ugualmente, la descrizione del virus H5N1 responsabile dell’influenza aviaria che fece ammalare centinaia di persone nel sudest asiatico, tra la seconda metà degli anni Novanta e gli anni Duemila, non riporta alcun dato sull’insieme di condizioni sociali ed economiche che potrebbero aver favorito le varie epidemie. Come osservato, tra gli altri, dallo scrittore, storico e attivista statunitense Mike Davis nel libro The Monster at Our Door, la diffusione del virus fu favorita da una serie di shock ambientali indotti dagli esseri umani: un progressivo avvicinamento tra la fauna selvatica e gli insediamenti urbani, causato a sua volta dalla deforestazione delle zone umide.
L’analisi di Davis, secondo Carr, sottintende che le soluzioni reali al problema delle epidemie implichino valutazioni politiche nella misura in cui richiedono, tra le altre cose, il ripensamento delle catene di approvvigionamento alimentare mondiale e del modo in cui sono organizzati gli spazi urbani.
– Leggi anche: Il «sentimento liberatorio» di Anthony Fauci
Un racconto della scienza che non dia conto del contesto politico e sociale in cui lavorano le persone che si occupano di scienza, secondo Carr, rischia di descrivere implicitamente quelle persone come impegnate «in una ricerca di un bene universale all’interno di una bolla priva di qualsiasi cosa simile a interessi conflittuali». Ed evitando di discutere gli interessi divergenti e spesso conflittuali alla base della ricerca scientifica favorisce la diffusione della «fantasia che tutta l’umanità voglia la stessa cosa».
«La realtà è che impegnarsi nella ricerca scientifica è un’attività sociale e intrinsecamente politica», scrisse nel 2017 in un articolo su Scientific American Ubadah Sabbagh, neuroscienziato del McGovern Institute for Brain Research, un istituto di ricerca interno del MIT. A voler fondare un paese da zero, ipotizza Sabbagh, probabilmente ci sarebbero cose che saremmo costretti a fare per impostazione predefinita, come per esempio inventare leggi, ma tra queste cose non ci sarebbe il finanziamento alla ricerca.
«Il finanziamento della scienza non è una posizione predefinita quando si crea un paese, è una decisione che abbiamo preso una volta come società e continuiamo a riprendere ogni volta che stabiliamo nuove politiche e approviamo i budget di spesa», afferma Sabbagh. «La scienza è stata collegata alla politica della società fin da quando la prima persona ha immaginato che fosse una buona idea fare ricerca, e poi ha convinto i suoi vicini a metterci soldi per farla».
A quel punto è inevitabile che si instaurino dei rapporti di potere all’interno dei gruppi, secondo Shobita Parthasarathy, ricercatrice di Scienze politiche presso l’Università del Michigan, sentita da Nature per il podcast “Stick to the science”. Quando pensiamo al contesto dei processi decisionali della scienza, secondo Parthasarathy, «stiamo davvero parlando di persone che manovrano per ottenere potere o mantenerlo, a volte anche esercitarlo, rafforzarlo» e che «spesso lo fanno sulla base dei loro interessi particolari, che si tratti di interessi economici o politici, o a volte soltanto di differenze di valori».
Secondo Parthasarathy la scienza e la politica ottengono apparenti benefici dalla percezione che la scienza sia oggettiva e distinta dalla politica, «perché questo significa che i politici possono dire “la scienza mi dà ragione, questa prova oggettiva, questa conoscenza oggettiva è dalla mia parte”», ricavandone maggiori consensi e approvazioni. E per la stessa ragione anche la scienza «trae vantaggio dall’apparire oggettiva, perché questo la fa apparire autorevole», afferma Parthasarathy, sebbene la scienza sia vincolata a sua volta al bisogno di avvicinare gli interessi della ricerca alle priorità specifiche della collettività o dei gruppi privati che la sovvenzionano.
Come conclude Sabbagh nel passaggio dell’articolo su Scientific American in cui sostiene che la ricerca possa avvenire soltanto con l’approvazione definita da una volontà politica: «In una fiorente democrazia, la società modella la politica, la politica controlla la scienza e la scienza informa sia la società che la politica. Non è niente di nuovo, lo sappiamo tutti. Ma alcuni di noi si rifiutano di riconoscere l’intima interazione tra società, politica e scienza».