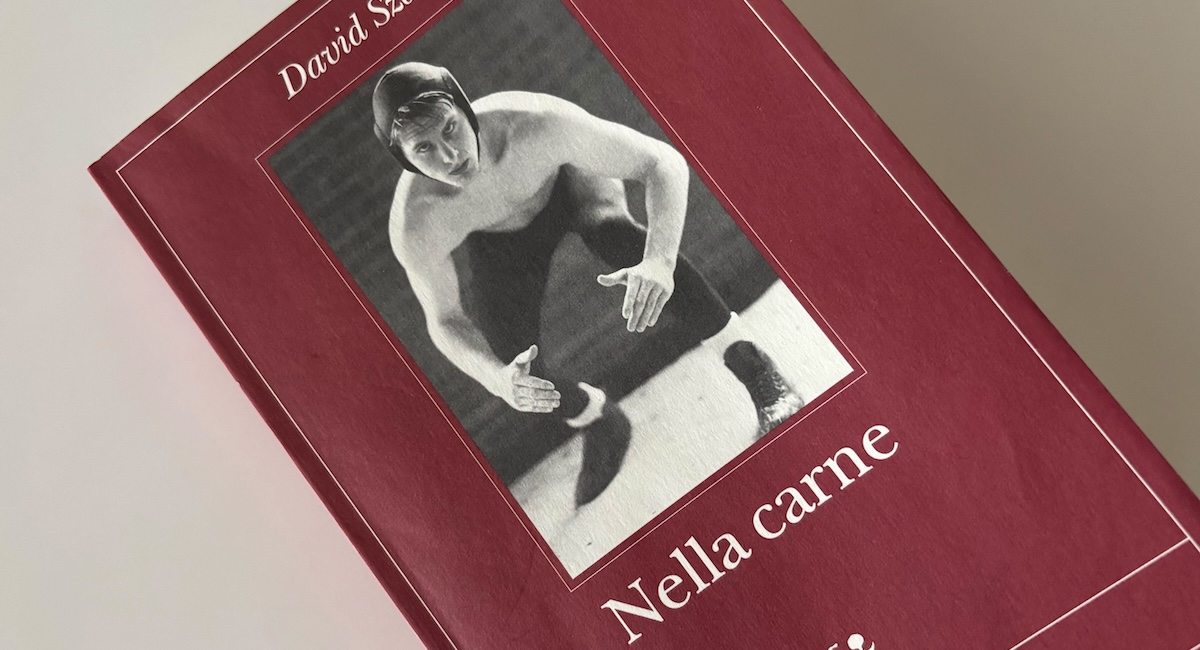Prendi una canzone triste e falla meglio (Beatles, #10-6)
Buongiorno a tutti, siamo al penultimo appuntamento – mi dispiace, purtroppo in otto anni quei Quattro pelandroni hanno inciso appena 250 canzoni, lo so, avrebbero potuto impegnarsi un po’ di più, litigare un po’ di meno, in ogni caso è andata così.
Fuori dall’ironia, vorrei ricordare che questa non è una classifica buttata fuori a caso da un critico scemo come pretesto per litigare, soprattutto coi fan di McCartney – no, no, questa è la media di ben sei classifiche buttate fuori da critici scemi come pretesto per litigare, soprattutto coi fan di McCartney a cui va la mia solidarietà, già Yesterday fuori dalla Top10 era molto discutibile, ma non è finita qui…
Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46), (#45-36), (#35-26), (#25-21). (#20-11).
10. She Loves You (Lennon-McCartney, singolo del 1963).
 Pensavi di aver perso il tuo amore? Al quarto singolo, i Beatles sono già una macchina da guerra. Non fanno prigionieri, non hanno pietà di nessuno. In particolare non hanno pietà delle ragazzine. I loro brani sono bombe in un senso non metaforico: si propagano attraverso onde sonore, e interagiscono col sistema endocrino delle adolescenti causando svenimenti, orgasmi, crisi nervose. Li coordina un ingegnere spietato, Mr George Martin: è lui il responsabile di alcuni accorgimenti decisivi, ad esempio l’idea sfacciata di cominciare col ritornello, di modo che ormai non c’è più nessun preavviso, i Beatles come le V2: un attimo prima la ragazzina sta cercando una frequenza sulla radio, un attimo dopo She Loves You Yeah Yeah Yeah è a terra in un pozzo di lacrime e altri liquidi. Ma i veri geni del male sono i due giovani membri dello staff creativo, John Lennon e Paul McCartney: immaginateli mentre incrociano le chitarre e riflettono sul loro prossimo diabolico piano. Magari si stanno chiedendo: cosa possiamo cantare ancora che stracci il cuore a un adolescente? Quali sono le parole che a quindici anni ti avrebbero reso il ragazzo / la ragazza più felice del mondo? Qual è la frase che ti avrebbe alzato tre metri da terra, che ti avrebbe fatto vedere miliardi di colori in un film in bianco e nero? Esiste una formula del genere? Pensiamoci bene.
Pensavi di aver perso il tuo amore? Al quarto singolo, i Beatles sono già una macchina da guerra. Non fanno prigionieri, non hanno pietà di nessuno. In particolare non hanno pietà delle ragazzine. I loro brani sono bombe in un senso non metaforico: si propagano attraverso onde sonore, e interagiscono col sistema endocrino delle adolescenti causando svenimenti, orgasmi, crisi nervose. Li coordina un ingegnere spietato, Mr George Martin: è lui il responsabile di alcuni accorgimenti decisivi, ad esempio l’idea sfacciata di cominciare col ritornello, di modo che ormai non c’è più nessun preavviso, i Beatles come le V2: un attimo prima la ragazzina sta cercando una frequenza sulla radio, un attimo dopo She Loves You Yeah Yeah Yeah è a terra in un pozzo di lacrime e altri liquidi. Ma i veri geni del male sono i due giovani membri dello staff creativo, John Lennon e Paul McCartney: immaginateli mentre incrociano le chitarre e riflettono sul loro prossimo diabolico piano. Magari si stanno chiedendo: cosa possiamo cantare ancora che stracci il cuore a un adolescente? Quali sono le parole che a quindici anni ti avrebbero reso il ragazzo / la ragazza più felice del mondo? Qual è la frase che ti avrebbe alzato tre metri da terra, che ti avrebbe fatto vedere miliardi di colori in un film in bianco e nero? Esiste una formula del genere? Pensiamoci bene.
“Ti amo”?
“No, è troppo impegnativa a quell’età”.
“Dici?”
“A sedici anni? Chi è che riesce a guardarti negli occhi mentre ti dice…”
“Aspetta. Cos’hai detto?”
“Che a quell’età nessuno ti dice Ti amo negli occhi. Al massimo…”
“Te lo mandano a dire”.
“Già, ti mandano un amico”
“O un’amica. Oddio”.
“Stai pensando anche tu?”
“Sì”.
“…quello che sto pensando io?”
“Sìììì”.
“Lei ti ama?”
“Sìììì”.
“Dillo di nuovo”.
“Sì”.
“Lei ti ama”.
“Sì. Sì. Sì”.
“Lei ti ama”.
“Sì. Sì. Sì, Sììììììììììì”.
She Loves You (Yeah, Yeah Yeah) è una bomba. Suona anche un po’ come una bomba, qualche manopola quel giorno ad Abbey Road non era girata nel verso giusto, i suoni sono smarmellati in un muro del suono accidentale ma comunque efficace, caldo: ti dà la sensazione di sentirla su una vecchia radio anche se stai ascoltando la versione rimasterizzata su un Hi-fi. Non ti dà il tempo di ragionare: è una ragazza che nel parcheggio della scuola sbuca dal nulla e ti avverte che la sua amica è ancora innamorata di te. Sì. Sì. Sì. Pensavi di averla persa, ma ieri l’ho vista e mi ha spiegato cosa devo dire, dunque, ha detto che ti ama, e questo non può essere un male; anzi, dovresti esserne felice, no? Lo sai che dipende da te, io trovo che sarebbe giusto. L’orgoglio può far male anche a te, dai, scusati con lei, perché lei… ti ama. Sì cazzo sì, mi ama. Nulla è perduto, tutto ancora possibile. Tra qualche anno saremo tutti un po’ più grandi, anche i Beatles non potranno evitarlo. Scusarsi diventerà sempre più difficile, e i rapporti un casino: bisognerà imparare a discutere, a vivere accanto, un inferno. Loro continueranno a fare il possibile per procurarti la tua dose di dopamina. Ti canteranno che tutto quello di cui hai bisogno e l’amore; di prendere una canzone triste e farne un inno alla gioia; ti ricorderanno che dopo la notte il sole risorge sempre. Ma la gioia pura, svergognata, di quel mattino che in un parcheggio ti hanno avvisato che Lei Ti Ama, Sì, Sì, Sì, quella tutti gli strumenti esotici al mondo e tutte le tonalità più bizzarre non l’avrebbero potuta replicare. Con un amore del genere, dovresti essere felice. Se non siete esplosi in quel momento, non c’è probabilmente nulla al mondo che possa farvi esplodere. Magari è persino un vantaggio: in tal caso buon per voi.
9. Norwegian Wood (This Bird Has Flown) (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965).
“Una volta ho avuto una ragazza, o forse dovrei dire che è lei che ha avuto me”. Norwegian Wood è una delle canzoni che hanno più diviso il fronte degli ermeneuti beatle. Il dibattito, per semplificare, verte su due punti che Lennon ha lasciato volutamente ambigui: il letto e il fuoco, l’adulterio e il crimine. Per una delle due scuole di pensiero, John viene attirato da una fan nel suo appartamento (i mobili in “legno norvegese” erano un classico degli appartamenti degli studenti), parlano fino alle due, poi lei decide di andare a letto. Lui protesta: non sono mica venuto qui per dormire nella vasca da bagno! Nella vasca o sul divano, in ogni caso quando si sveglia la ragazza è volata via come un’allodola, e allora per vendicarsi il protagonista dà fuoco all’appartamento. Il tutto raccontato con calma, con un sitar già ipnotico in sottofondo (è la sua prima apparizione in un brano beatle). Buono, eh, questo legno norvegese?
La seconda scuola di pensiero è meno drastica. John probabilmente riesce ad accedere al letto della ragazza; l’adulterio viene consumato; qualche ora più tardi si sveglia da solo (lei glielo aveva ben detto che lavorava al mattino), e si accende una sigaretta (o magari riattizza il fuoco in un camino). Buono questo legno norvegese. Ognuno è libero di scegliere la sua versione: l’ambiguità è programmatica. Il testo è costruito con un’astuzia che eleva improvvisamente John Lennon al rango di grande narratore e poeta: la frase allusiva che incornicia la storia (“isn’t it good, Norwegian wood“?), il dettaglio del protagonista che si guarda intorno e non trova una sedia, una piccola delusione che ci prepara alla delusione più grande, adombrata ma non esplicitata. Con buona pace di chi preferisce il suo materiale surrealista o lisergico, o le sue pose da profeta/rivoluzionario, Norwegian Wood rimane uno dei suoi testi meglio congegnati. Fa sorridere il pensiero che un autore tanto devoto alla sincerità abbia dato il meglio di sé quando cercava un trucco per raccontare una sveltina senza che la moglie se ne accorgesse (o sentisse la necessità di accorgersene).
Lennon vuole vantarsi di avere una vita sessuale avventurosa, ma vuole anche darci la possibilità di credere che si tratti di una storia tutta matta su un tizio che dà fuoco ai mobili compatibili. Forse quel che gli premeva dissimulare non era tanto l’adulterio, quanto la sua iniziativa. Non sono stato io a farmela, è stata lei che si è fatta me: mi ha attratto con l’inganno, ha lasciato che le ore passassero, poi ha detto che se ne andava a letto e a quel punto non c’era altra possibilità, neanche un divano! Non potevo mica dormire nella vasca da bagno, no? L’inversione dei ruoli nel rapporto amoroso era un suo pallino sin dagli esordi: vedi in It Won’t Be Long il fidanzato-casalingo che si strugge nell’attesa che l’amata faccia ritorno. Negli anni ruggenti della Beatlemania, passando da un letto d’albergo a un aeroplano a uno stadio a un altro letto d’albergo, il dubbio deve averli attraversati: sono io che mi sto facendo questa ragazza, sono io che sto approfittando della sua sconfinata ammirazione? O è lei che sta approfittando della mia ingenua golosità di giovane rockstar, è lei che sta prendendo appunti per la storia che racconterà alle amiche? Si sa che ogni storia è una storia a sé. Ma dopo Drive My Car in Norwegian Wood troviamo di nuovo una ragazza che prende l’iniziativa.
Il motivo per cui la seconda interpretazione risulta più credibile dipende soprattutto dalla musica, non drammatica ma evocativa, che suggerisce l’incanto di quegli incontri fortuiti che durano poche ore e ci lasciano un ricordo vivido per la vita. Certo, possiamo anche immaginare un Lennon completamente schizzato che aspira a pieni polmoni il profumo del legno mentre brucia, Norvegia, brucia! Ma la musica ce lo descrive più facilmente mentre fissa un soffitto di una cameretta sconosciuta, confuso tra i soprammobili e i trofei di una ragazza che in quel momento sta già pensando a qualcos’altro. Sono stato io ad averla, o è stata lei? E chi lo sa. Comunque niente male, questo legno norvegese.
8. While My Guitar Gently Weeps (George Harrison, The Beatles, 1968).
Con tutti gli errori che facciamo, di sicuro stiamo imparando tantissimo. Tutto il narcisismo e la competitività di cui erano capaci non avevano mai impedito a Paul McCartney e John Lennon di riconoscere una buona canzone del rivale, quando la sentivano. Era una questione di priorità: difendere la propria individualità creativa veniva molto dopo l’opportunità di incidere buone canzoni (e guadagnarci). Il più critico dei due, Lennon, non aveva nulla da eccepire al fatto che McCartney incidesse cose smaccatamente mccartneyane come Michelle o Hey Jude. Purché fossero buone canzoni. E allora com’è possibile che né John né Paul non si siano accorti subito di che bomba George Harrison stava per sganciare? Non ci sono scusanti: la versione incisa e Esher all’inizio dei lavori è già completa in sé: più svelta, ma molto più vicina al risultato finale di altri abbozzi proposti dai colleghi. Sembra già molto promettente. Ma una volta arrivati ad Abbey Road, George scoprì che gli altri due non la stavano prendendo seriamente. Non riusciva a coinvolgerli, non ci credevano. Cosa impediva di riconoscere in While My Guitar un pezzo forte dell’album in lavorazione? Cosa non riuscivano a sentire, che a noi invece risulta così evidente?
While My Guitar segna il ritorno di Harrison alla strumentazione occidentale, dopo un’avventura indiana che lo aveva coinvolto sempre più intensamente dalla fine del 1965 fino al soggiorno di Rikikesh, nel resort di Maharishi. Non è escluso che le cattive vibrazioni sperimentate in quell’occasione possano aver indotto Harrison a rivolgere di nuovo il volto a ovest, ma bisogna aggiungere che Harrison non smise mai di praticare la meditazione, né di collaborare con Ravi Shankar: tracce della sua esperienza indiana rimarranno iscritte indelebilmente nel suo stile chitarristico. Harrison smise di portare il sitar nei dischi dei Beatles perché ormai lo stava prendendo troppo sul serio, e tutta quella serietà non si adeguava all’universo giocoso dei Beatles. La decisione di rimettersi a scrivere pezzi rock per una rock’n’roll band avrebbe complicato un equilibrio sempre più fragile. John e Paul avevano sempre incoraggiato e appoggiato le sue sperimentazioni. Ai suoi raga e ai suoi mantra avevano ritagliato un ghetto dorato in Sgt Pepper. Un George che si rimetteva a scrivere pezzi rock invece suscitava diffidenze. Eppure George non faceva che rielaborare gli stessi stimoli che Paul e John avevano avuto durante il soggiorno indiano. Anche lui come loro si era trovato un po’ più spesso del solito con una chitarra in braccio e ne aveva approfittato per arricchire il suo stile di fingerpicking. La strofa di While My Guitar è un esempio di scuola di descending bassline, il trucco semplice e potente intorno al quale McCartney aveva scritto Michelle (una vaga traccia dello stesso trucco si trova nel bridge di un brano proposto da George Harrison ai colleghi addirittura nel 1964, You Know What To Do). Anche Lennon aveva portato un brano acustico costruito intorno a una linea di basso discendente, Cry Baby Cry. In italiano di solito traduciamo “cry” e “weep” con lo stesso verbo, ma “cry” si usa per i pianti molesti che ci svegliano nel cuore della notte, “weep” per i singhiozzi sommessi. “Gently cry” non avrebbe senso: “gently weep” fu un’espressione che George trovò aprendo una pagina di libro a caso, come fosse un I-Ching. Qualcun altro a quel punto si sarebbe calato in un personaggio che piange, ma George non amava fare spettacolo dei suoi sentimenti: a piangere dolcemente sarebbe stata la chitarra: un’ottima idea per una metacanzone (e anche una strategia per rimettere in primo piano il suo strumento).
La strofa di While My Guitar, nelle sue versioni acustiche, ricorda ancora irresistibilmente The House Of the Rising Sun: la discesa del basso, un tasto alla volta, è un’analogia musicale alla discesa del protagonista nel vizio e nella perdizione. È una suggestione a cui lo stesso Harrison non riesce a sottrarsi: in While My Guitar riaffiora la sua vena moralistica, pur disturbata da un gusto un po’ importuno per i giochi di parole “I looked on the floor and I note it needs s-weeping“. Così come John è il maestro della prima persona (nel senso che parla quasi sempre di sé) e Paul della terza (si inventa sempre personaggi), George della seconda (si sta sempre rivolgendo a qualcuno, molto spesso in tono polemico). È un atteggiamento che esplode nella strofa, che pure abbina a una melodia molto più conciliante una serie di sentenze senza appello: nessuno ti ha spiegato come distendere il tuo amore, sei stato pervertito, allontanato, invertito, venduto e comprato, non so il perché ma è andata così. La musica sembra molto più tollerante di quanto non ci autorizza a pensare il testo: lo stesso George non era sempre il moralista introverso che rischiava di rappresentare in pubblico. Una volta constatato il boicottaggio più o meno consapevole dei colleghi, avrebbe potuto chiudersi a riccio e cominciare a pensare a una carriera solista che appariva ormai inevitabile, o destinare While My Guitar a qualche altro artista della scuderia che stava allevando in seno alla Apple. Ebbe un’idea migliore: invitò Eric Clapton alle prove, gli cedette l’assolo di chitarra piangente che avrebbe dovuto essere il fulcro del brano. Bastò questo a scuotere dal torpore Lennon e soprattutto McCartney, che alla fine ebbe una buona idea per l’introduzione, quel tasto di pianoforte che suona come la campana del destino.
Un’altra impronta indelebile di Paul è il fraseggio del basso nella strofa, un prestito doo-wop quasi parodistico che lascia un senso di straniamento: altrettanto parodistica suona la sua breve scala ascendente tra strofa e ritornello, da addebitare alla sua fobia per il vuoto, l’ossessione per non lasciare mai nascosto nessun collegamento tra due accordi. A Harrison probabilmente non piaceva (la si sente molto meno in qualsiasi sua versione successiva). Eppure è uno degli elementi più beatlesiani del brano: ci aiuta a ricordarci che malgrado Clapton stia suonando uno dei suoi assoli migliori siamo ancora in un brano dei Beatles, in uno scherzo, in una festa. Non tutti si stanno divertendo: qualcuno in sottofondo sta singhiozzando… ma è ancora una festa.
7. Something (Harrison, Abbey Road, 1969).
Quando si parla di Something risulta inevitabile citare Frank Sinatra, che la incise due volte e la considerava “una delle migliori canzoni degli ultimi 50 anni”. Una volta, con inconsapevole malignità, la definì la migliore canzone di Lennon e McCartney, il che è buffo ma non del tutto falso: avrebbe mai potuto scrivere e incidere Something, George Harrison, senza l’esempio dei due colleghi e la sfida che gli ponevano?
In linea di massima tenderei a fidarmi del vecchio Frank, che da Cole Porter in poi ne ha cantate davvero tante. Neppure lui tuttavia è riuscito dove i più grandi interpreti hanno fallito, ovvero a imporre la sua Something su quella dei Beatles. Nessuno ce l’ha fatta – e ci hanno provato in tanti. Yesterday sta sul Guiness dei Primati come canzone più interpretata, e anche Something si difende molto bene. Ma le versioni più ascoltate restano quelle originali. Forse per qualche anno la With a Little Help di Joe Cocker è rimasta competitiva rispetto a quella cantata da Ringo. Ma sulla distanza i Beatles vincono sempre.
Se qualcuno avrebbe potuto farcela però era proprio Sinatra. Non solo era il cantante più famoso del mondo (scusa Elvis), ma aveva scelto un brano un po’ meno beatlesiano di altri: un brano che lo stesso Harrison per molto tempo non credeva adatto ai Quattro. A differenza di While My Guitar, che era già praticamente pronta all’inizio dei lavori del Disco Bianco, Something ebbe un’incubazione più lunga. Harrison cominciò a sentirsela in testa durante le sessioni del Disco Bianco, e per qualche tempo sperimentò l’angoscia provata da McCartney con Yesterday: la canzone era già troppo ben formata per non essere già stata composta e suonata da qualcuno. In ogni caso, non sarebbe stato facile proporla agli altri Tre: in un primo momento Harrison pensava piuttosto di scrivere un brano per il suo protetto, Jackie Lomax. In seguito la propose a Joe Cocker. Ma ancora nel gennaio del 1969, quando si rivede con gli altri tre nei Twickenham Studios, il brano non è finito. George rimane bloccato per mesi sul verso “attracts me like…” (Lennon a un certo punto gli suggerisce; “a cauliflower“: mi attira come un cavolfiore. Harrison ci ride sopra ma alla fine conserva la rima: “no other lover“).
Forse è un segno di quanto credesse nella canzone, di una certa ritrosia a lasciarla andare del tutto. Una volta incise le canzoni, non ci puoi più fare niente: se una parola non ti piace, non c’è più modo di cambiarla. George lo scoprì proprio quando in concerto tentò di cambiare le parole di Something: non si può più, la gente protesta. E anche le note, se non sono proprio quelle giuste, una volta incise non ci sarà niente da fare: la gente vorrà sentire quelle. A George dava noia il fraseggio del basso di Paul, la sua solita smania per occupare tutto lo spazio che si sarebbe potuto lasciare al silenzio. Troppo tardi, nella testa di ogni beatleomane Something è perfetta così, con quel basso ingombrante.
A chi insisteva a chiedergli se la canzone fosse dedicata alla moglie Pattie, Harrison rispondeva: stavo pensando a Ray Charles. Dopo il breve riff introduttivo che sembra voler mettere a fuoco un’immagine, la strofa di Something si muove intorno allo stesso gioco sperimentato con successo in While My Guitar, la linea di basso discendente; si ferma per un intervallo drammatico “I don’t want to leave her now, You know I believe and now” e poi cambia chiave, di nuovo con un basso discendente: “You’re asking me, will my love grow?” Qui c’è quel salto di tempo che Harrison aveva già chiaro nel demo, che testimonia la stessa insofferenza nei confronti della forma canzone occidentale espressa in Here Comes the Sun: George ha voglia di venire al dunque. La seconda strofa è dedicata al suo migliore assolo: se la chitarra di Clapton in While My Guitar gemeva, in Something la chitarra di Harrison si anima, discute, si domanda che senso ha innamorarsi e infine si abbandona al sentimento, un attimo prima di riassestarsi la cravatta e riprendere il riff con cui si era presentata all’inizio.
Harrison riprende a cantare e se volessimo cominciare ad annoiarci, questo è il momento: ormai abbiamo sentito strofa, bridge e assolo, si sa che per convenzione le canzoni devono andare avanti ancora almeno per un altro bridge, anche se ormai quello che si doveva sentire si è sentito. Non abbiamo fatto in tempo a formulare questo pensiero che abbiamo di nuovo il riff davanti: ci saluta e ci congeda, la canzone è finita.
George ci ha risparmiato il secondo bridge: un piccolo regalo per aver creduto in lui. Forse ci ha lasciato insoddisfatti, ma forse è il motivo per cui stiamo già per rimetterci ad ascoltare Something. Un brano che forse condivide con Yesterday l’archetipo di partenza (Georgia On My Mind), ma sembra lasciato volutamente incompleto, con fessure e irregolarità che la fanno sembrare più fragile di quanto non sia davvero. Il motivo per cui poi per cinquant’anni tutti hanno riprovato a inciderla, e nessuno è riuscito a fare di meglio del fragile George forse risiede in questo: subiscono tutti la tentazione di correggerla, di stabilizzarla, di trasformarla in uno standard. Il che ha perfettamente senso e forse era anche l’intenzione iniziale di George, quando pensava di farla incidere a qualcun altro. Ma ciò che rende unica Something è proprio “il modo in cui si muove”, quel tipo di bellezza che trae forza dalle sue imperfezioni. Come il sorriso di Pattie Boyd, con quella fessura tra i grandi incisivi centrali.
6. Hey Jude (Lennon-McCartney, singolo del 1968).
Ehi Jude, non prendertela a male. Dopo il divorzio Cynthia Powell Lennon visse ancora per un po’ nel villino a Weybridge con Julian, che nel 1967 aveva cinque anni: l’età di Please Please Me. Un giorno di giugno ricevettero una visita di Paul McCartney. “Io e Paul ogni tanto facevamo qualche giro assieme – più di quanto capitasse con papà. Eravamo molto amici e sembra che ci siano molte più foto di me e Paul che giochiamo assieme a quell’età, che foto di me e mio padre”. Paul porta in dono una canzone per Julian – dice che gli è venuta in mente in macchina. Possiamo almanaccare su cosa Paul potrebbe avere ascoltato, durante quel tragitto in macchina – probabilmente nulla, ci vuole silenzio per immaginare una canzone. Oppure potrebbe essersi sintonizzato per un attimo su una frequenza che trasmetteva musica classica e catturato i primi secondi del Te Deum di John Ireland (malgrado il nome, è un compositore inglese del Novecento). Per poi cambiare stazione all’improvviso e incappare in un vecchio classico dei Drifters, Save the Last Dance For Me. O in Elvis Presley che cantava It’s Now or Never, ovvero O Sole Mio. La canzone che Paul invece fa sentire a Cynthia e Julian sul pianoforte di casa si chiama Hey Jules ed è un invito a lasciarsi alle spalle un dolore. Probabilmente non contiene ancora il verso “the moment you let her under your skin“, non molto adeguato al dramma di un bambino che sta vivendo la separazione dei genitori; sappiamo comunque che Cynthia si commuove. Julien scoprirà solo vent’anni più tardi che Paul McCartney ha scritto Hey Jude per lui. Sempre che sia così vero…
Prendi una canzone triste e falla migliore. Da altre testimonianze sappiamo in effetti che in quel periodo Paul sta facendo ascoltare questa canzone a tutti quelli che incontra. Durante un viaggio di lavoro gli capita di suonarla nel pub di paese nel Bedfordshire. La suona ai Bonzo Dog Band mentre sta lavorando al loro singolo (I’m the Urban Spaceman); ai futuri Badfinger nel primo giorno di prove. Bonzo e Badfinger sono della scuderia Apple, per cui non c’è il rischio che gli rubino il pezzo; ma a Paul capita di suonarlo anche durante una sessione dei Barron Knights, vecchi amici ma comunque concorrenti. Forse Paul voleva assicurarsi, come ai tempi di Yesterday, che la canzone non fosse già in circolazione. Oltre ai Drifters e all’attacco del Te Deum, nel bridge Paul riprende una progressione che aveva avuto modo di ammirare in un grande successo di qualche mese prima, A Whiter Shade of Pale dei Procul Harum – una progressione ripresa dalla cosiddetta Aria sulla IV corda di Bach, già adombrata da Lennon in A Day In the Life. È un buon bridge – in generale Bach non è uno che ti lascia a piedi – ma Paul sente che manca ancora qualcosa e aggiunge una breve frase da cantare all’unisono con gli strumenti: “Da da da da da, da da da…” Per la coda invece ha in mente un giro di tre accordi, su cui cantare un’altra breve frase in coro. Parte in Fa, cade un tono indietro (Mi bemolle), raggiunge il Si bemolle, ritorna in Fa. Quando il coro ripete il Na Na Na sul Mi bemolle, introduce una lieve dissonanza che si risolve trionfalmente col ritorno al punto di partenza (“so let it out and let it in“): è un trucco che a un bambino viene voglia di ripetere all’infinito. Paul sta cantando a quel bambino, o forse vuole essere quel bambino (“don’t you know that it’s just you“?) È un buon segno. Hey Jude diventa l’ennesima metacanzone: Paul prende un motivo vagamente triste, e lo trasforma qualcosa di migliore (“better, better, better, yeah!“)
Fino a Hello Goodbye, Paul si era divertito a prendere canzoni semplici e aggiungere digressioni e abbellimenti, ottenendo oggetti pregiati ma che potevano risultare artefatti. Con Hey Jude il procedimento è capovolto: Paul parte da riferimenti colti, ma si dà da fare quanto possibile per occultarli, per semplificare il più possibile il quadro, rendendolo accessibile a tutti, praticabile da tutti. Tutti devono cantare Hey Jude, tutti devono sentire che la canzone parla di loro. A Whiter Shade of Pale comincia con un riff di organo che fa urlare “Bach” anche a chi non ha mai sentito un disco di musica classica. Con Hey Jude non ti succede: Paul non ha necessità di farsi bello coi riferimenti culturali, è passata la fase in cui ci teneva a mostrare che ascoltava Vivaldi. Di Bach non gli interessa la parrucca, ma quel senso di serenità che infonde la contemplazione degli ingranaggi musicali dell’universo, l’effetto che la musica barocca infonde all’ascoltatore. Hey Jude è la canzone della maturità: più che giusto che Paul si immagini di cantarla al figlio che non aveva avuto, ma John sì.
 |
| Un negozio distrutto durante la Notte dei cristalli, 10 novembre 1938 (OFF/AFP/Getty Images) |
Tu sei stato fatto per trovarla. Strada facendo “Hey Jules” era diventato “Hey Jude” che secondo Paul, “suonava meglio”. Ci si mette un po’ a capire perché – Jude non è un nome molto usato, ma proprio per questo è più difficile associarlo a qualcuno. Addirittura può riferirsi a un uomo, “Jude”, ma anche a una Judith. D’altro canto se un nome è poco usato un motivo c’è, e Paul senz’altro non rifletté abbastanza quando gli venne in mente di spennellare il nome del singolo in imminente uscita sulle vetrine della boutique Apple appena chiusa in Baker Street. La comunità ebraica protestò formalmente; qualcuno la infranse con una sassata, provvidenzialmente, prima che fossero scattate troppe foto. “Non avevo la minima idea che Jude volesse dire ebreo” spiegò poi Paul; eppure un po’ di tedesco doveva masticarlo (ai tempi di Amburgo avrebbe potuto persino vedere qualche traccia di vernice sui vecchi intonachi, se a noi capita di vedere ancora il nero Credere Obbedire Combattere sotto la ritinteggiatura di su qualche muro storico). Una delle caratteristiche che rendono simili i due grandi singoli mccartneyani del 1968-69 è il riaffiorare di un immaginario cattolico che Paul aveva sepolto sotto tonnellate di rock’n’roll. Magari è una coincidenza, ma in Let It Be c’è una Madre Maria, mentre Hey Jude porta il nome del discepolo che tradì Gesù Cristo. Come Gesù, Paul deve accettare il tradimento, “secondo quanto stabilito”, Luca 22,22. Bisogna anche dire che ci sono due Giuda tra i discepoli: uno tradisce, l’altro è di buon cuore, tanto che viene soprannominato Taddeo o Lebbeo. È il patrono dei casi disperati. Gli è attribuita una Lettera del Nuovo Testamento, un invito alla Chiesa a non smarrire l’unità, a non disperdersi in sette, a non mollare la band per inseguire il miraggio di un idillio famigliare, (quest’ultima cosa me la sono appena inventata ma probabilmente tutta la lettera è apocrifa).
 |
| Allora qui ci sono Brian Jones, Yoko Ono, John Lennon e il figlio Julian, Eric Clapton e Roger Daltrey agli Internel Studios di Stonebridge Park, Wembley nel 1968 (Hulton Archive/Getty Images) |
Ma non capisci che sei tu? A differenza di Martha, la cui canzone avrebbe potuto offendere qualche ragazza ignara di chiamarsi come il bobtail di Paul, o Julia, una canzone che indicava una persona precisa e unica al mondo (in realtà due persone), Jude deve essere chiunque. E in effetti, chiunque ci si è riconosciuto. Non solo Julian, ma persino il padre. Ancora nel 1980, John era convinto che Paul, “inconsciamente”, stesse cantando a lui, di lui, per lui: “l’hai trovata, ora va’ e prendila”. Il buffo è che quando aveva provato a dirglielo, “Ehi, questo sono io”, Paul aveva risposto: “no, sono io”. È un momento delicato: John ha divorziato e sta con Yoko, Paul è stato lasciato pubblicamente da Jane Asher, ma non sta ancora uscendo con Linda. In quel periodo passa molto tempo con Francie Schwartz, l’aspirante scrittrice che Jane gli aveva trovato nel letto arrivando in Cavendish Avenue nel momento sbagliato, e che gli diede una mano a spennellare “Hey Jude” sulle vetrine. Paul a volte se la prende con se agli studi di Abbey Road, proprio come John fa con Yoko. E per un breve periodo, dormono tutti e quattro in Cavendish Avenue. Paul ha rotto con Jane, John con Cynthia. Entrambi sono un po’ Giuda; nessuno dei due particolarmente Taddeo.
Perciò falla uscire e falla entrare. Paul è combattuto; vorrebbe andar d’accordo con tutti, andare a trovare Cynthia e Julian e ospitare John e Yoko, ma questa persona venuta dall’altra parte del mondo a portargli via il socio non può non spaventarlo. Secondo l’unica testimonianza di Francie Schwartz, un giorno Lennon trova un bigliettino di Paul che forse voleva essere divertente (“YOU AND YOUR JAP TART THINK YOU’RE HOT SHIT”) e invece lo manda nei matti: lui e Yoko faranno subito i bagagli. Lennon aveva la tendenza a ritenersi il centro dell’universo, ma bisogna ammettere che “you’re waiting for someone to perform with” è uno di quei mccartneyismi disarmanti e rivelatori: chi fino a quel momento in una canzone aveva mai pensato di definire un rapporto a due come una “performance“? d’altro canto John si era appena messa con una performing artist. Paul in Yoko aveva riconosciuto qualcosa di cui fino a quel momento non sapeva nemmeno di avere bisogno: una compagna di vita e di lavoro. John l’aveva conosciuta – e a quel punto i Beatles per lui avevano perso gran parte del senso. Paul no, e forse per il bene del gruppo sarebbe stato meglio non conoscerla mai. Eppure a questo punto Paul sospettava di averne bisogno. Si trattava soltanto d’incontrarla: nel frattempo la canzone era pronta.
 |
| Oppure l’aveva già incontrata (qui nel 1967 a una conferenza stampa per Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. |
Non ti portare il mondo sulle spalle. Per uno dei soliti paradossi, la canzone che Paul voleva suonare nel modo più semplice possibile fu la prima che i Beatles registrarono su un’apparecchiatura a otto piste, ai Trident Studios. Il risultato fu un sovrappiù di agitazione di cui la band non aveva bisogno. Gli orchestrali furono particolarmente sgarbati, come non risultava succedesse ad Abbey Road. Stavolta la partitura era così semplice che forse risultò offensiva. Paul li esortava dicendo “li volete i soldi o no?” Per convincerli a battere le mani nel finale gli si dovette offrire uno straordinario. Paul ammette di essersi comportato da “boss” in quell’occasione. Del resto i Beatles erano un’industria: occorreva rassicurare la clientela affezionata e i potenziali investitori. L’ultimo singolo non era stato un successo eccezionale. La boutique era stata quasi uno scherzo, da un punto di vista beatle; un flop con un pessimo ritorno d’immagine da un punto di vista imprenditoriale. Il viaggio in India aveva fatto discutere; il divorzio di John fa discutere ancora oggi. Serviva un segnale potente e Paul sapeva bene che segnale gli si chiedeva: un singolo che rimettesse in chiaro chi era la band più importante del mondo. Dopo averla suonata in lungo e in largo a parenti e amici, Paul aveva chiarissima l’immagine che la canzone avrebbe avuto: e nella sua chiarissima immagine non era previsto un ruolo per la chitarra solista. Quando Harrison propose di entrare nella strofa con un contrappunto, Paul disse semplicemente di no e George, altrettanto semplicemente, se ne andò. I tentativi di Paul di salvare il gruppo lo stavano sgretolando dall’interno.
Better better better better better better aaaaah! La lunga coda di Hey Jude è un anti-jam: invece di sfrenare gli strumenti, tutto si ripete senza sensazionali variazioni. Solo le urla di Paul creano un diversivo, ma non sono nemmeno in evidenza. Una volta svanito l’effetto sorpresa, non ci sarebbe bisogno di proseguire: ma è come se la band non riuscisse a smettere. Ancora un altro giro, dai, che ci fa sentire bene. Dopo un po’ dovrebbe sfumare. In effetti comincia a sfumare, ma è un trucco: va ancora avanti per due minuti, e in totale ne occupa quattro su sette (qualcuno ci ha voluto vedere la proporzione aurea). George Martin era perplesso: un singolo così lungo le radio non l’avrebbero suonato. “Lo suoneranno, se siamo noi”. Qualcuno attribuisce a Hey Jude la responsabilità delle derive sinfoniche del rock anni ’70, i dischi concepiti come lunghe suite quasi sempre strumentali. Hey Jude è un segno dei suoi tempi: c’è ancora qualcosa degli anni ’50 (i Drifters), c’è quel gusto retrò della seconda metà degli anni ’60 che aveva portato alla riscoperta delle progressioni barocche; c’è un’idea – lungamente accarezzata dai Beatles – di realizzare canzoni come mantra, mandala musicali senza inizio e senza fine. Un’idea che viene da oriente ma che Paul depura da ogni elemento esotico: un altro messaggio che vuole dare agli investitori è che le follie indiane sono finite.
Il momento in cui la fai entrare sottopelle. Il disco alla fine venne esattamente come doveva venire. Paul era così entusiasta che portò una copia provvisoria alla festa dei Rolling Stones per il lancio di Beggars’ Banquet (secondo alcuni rovinandola). Quando i Beatles suonarono Hey Jude in uno studio televisivo, erano di nuovo tutti e quattro assieme: anche Ringo, dopo essersi preso due settimane di ferie, era di nuovo al suo posto. Lennon scherzava, scambiava con Paul cenni di intesa che tutti erano felici di vedere: prove tangibili che la canzone non gli dispiaceva e che i Beatles esistevano ancora. E allo stesso tempo era pur sempre John: dopo la breve presentazione di David Frost, un attimo prima che le telecamere stacchino per il break pubblicitario, lo sentiamo urlare fuori campo “IT’S NOW OR NEVER”. Forse un riferimento alla rarità dell’evento (ora o mai più!), già sottolineata da Frost? (in effetti fu l’unica occasione per i telespettatori di vederli suonare assieme nel 1968 e nel 1969, anche se a parte Paul erano in playback). Oppure il presagio di un possibile scioglimento? Ma più semplicemente John aveva scoperto una delle fonti inconsce di Paul, e non resisteva all’impulso di rivelarla in diretta: se la prima parte del ritornello di Hey Jude ricorda il Te Deum di Ireland, la seconda parte suona molto simile a It’s Now or Never, ovvero a O sole mio.
Il movimento che ti serve è sulla tua spalla. Mi è capitato spesso in questi mesi di esprimere riserve su tanti mccartneyismi: versi involuti, scritti alla svelta e mai più rivisti, che Paul non riusciva a nascondere sotto l’alibi del surrealismo come il più sfacciato compagno. Lo stesso Paul era consapevole di non avere sempre le migliori parole a portata di mano. Magari gli sarebbe servito un piccolo aiuto da parte di John, ma ecco: a John certi mccartneyismi piacevano. Forse lo rassicuravano sulla sua maggiore caratura di paroliere, o forse in certi casi riusciva a capire Paul molto meglio di Paul stesso, molto meglio di noi. “The movement you need is on your shoulder” è un mccartneyismo che Paul sentiva di dover cambiare (“suona come se avesse un pappagallo sulle spalla”), mentre per John era “il miglior verso della canzone”. È anche possibile che scherzasse, o che volesse dirgli che il resto della canzone aveva persino meno senso. Il risultato fu che Paul mantenne il verso, e da quel momento, ogni volta che lo canta, dietro quella spalla sente John, e ogni volta si commuove. Non dovrebbe? Adesso lo sai che sono soltanto dei folli quelli che non lo fanno, rendendo il mondo un posto un po’ più freddo.