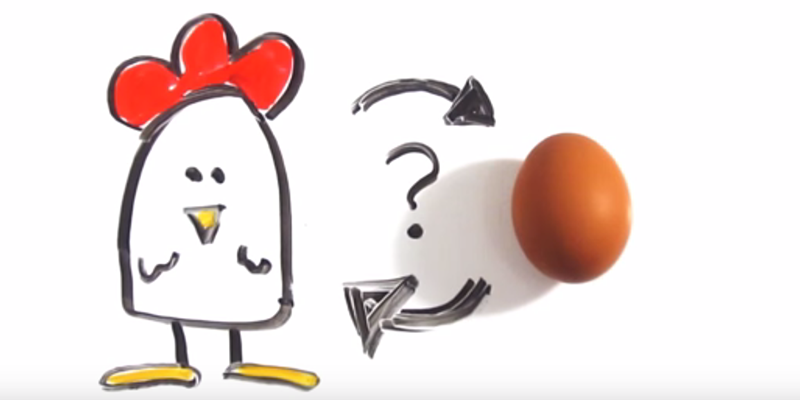Nasconditi ragazza, arriva John (i Beatles, #110-96)
Cinquant’anni fa stava per uscire Let It Be, il primo disco postumo dei Beatles. Cinquant’anni dopo eccoci qua, senza che nessuno che lo chiedesse abbiamo iniziato a raccontare le canzoni dei Beatles dalla più bistrattata alla più ammirata e con oggi abbattiamo il muro del 100! Vi immaginate quale sarà la canzone n. 100? No, non ve l’immaginate.
Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111).
110. If I Needed Someone (Harrison, Rubber Soul, 1965)
Se avessi bisogno di qualcuno da amare, tu sei la persona che mi verrebbe in mente – e sottolineo “se”. Fino a questo momento George Harrison era riuscito a incidere coi Beatles quattro sue canzoni, di cui qui riporto i titoli perché messi in fila mi hanno sempre fatto ridere: Non seccarmi, Ho bisogno di te, Ti piaccio troppo (e anche tu mi piaci), Pensa per te (perché non sarò con te). Insomma per George fino a tutto il 1965, scrivere una canzone significa rivolgersi direttamente a qualcuno, con lo scopo specifico di prendere le distanze. Se la musa del giovane John è la gelosia, potremmo dire che quella del primo George è l’autonomia: anche quando la sacrifica, come in I Need You, lo fa proprio perché la considera il suo bene più prezioso. If I Needed è l’ultima canzone del periodo, l’unica che Harrison sia riuscito a portare nelle scalette dal vivo, e riassume felicemente tutta la striminzita ma coerente poetica ur-harrisoniana: magari mi piaci, ma non ho bisogno di te. Siamo autorizzati a leggerci un sottotesto autoironico: in fondo se John con I’ll Cry Instead stava prendendo in giro il sé stesso geloso, anche Harrison aveva abbastanza spirito per sorridere di questo personaggio che ufficialmente non ha bisogno di nessuno, non ha tempo per nessuno, ma ti chiede comunque di scribacchiare il numero di telefono sulla tappezzeria (molto rock’n’roll quest’esigenza di dissimulare l’interesse) (e poi, certo, George si stava per sposare e sentiva l’esigenza di chiedere scusa a tutte le ragazze che se solo si fossero fatte vive un po’ prima di Pattie, chissà).
Se Rubber Soul è il disco centrale dei Beatles, If I Needed si trova in particolare in un affollatissimo crocevia. Da una parte c’è una strada che arriva dritta dalla California: George non si preoccupa di far sentire il tipico jingle-jangle dei Byrds, e a buon diritto, visto che i Byrds erano stati i primi a riconoscere l’influenza degli accordi spennati da George sulla Rickenbaker a 12 corde in A Hard Day’s Night: la strada insomma si percorre in due sensi e a quest’altezza il giovane Harrison ha più bisogno che mai di mostrare che anche lui ha uno stile distintivo che vantava tentativi d’imitazione. La canzone andò anche in classifica, grazie a una cover degli Hollies che a Harrison non piaceva troppo.
Sull’altro lato dell’incrocio c’è una via che porta ancora più lontano, verso l’India: If I Needed è la prima canzone di Harrison a suggerire un’interesse per i raga indiani, senza nessun bisogno di appariscenti oggetti di scena come il sitar o la tabla – fondamentali, invece, i cori e il basso ipnotico di Paul McCartney, e bisogna dire che sia qua che in Taxman che in I Want to Tell You sembra essere Paul il guru che sviscera l’essenza dravidica di canzoni apparentemente ancora del tutto occidentali. È come se Paul sapesse già che la strada di George porta verso l’India, quando ancora George sta fingendo di guardare da tutt’altra parte.
109. Birthday (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
Yes we’re going to a party, party. Prima di lanciarsi in pista, un po’ di numeri a caso: abbiamo già scoperto qual è il disco in assoluto meno apprezzato dai critici (With the Beatles). In particolare, il secondo lato di quel disco lo abbiamo già completamente coperto: nessuna canzone compare nelle prime 110. Sembra insomma il lato di 33 giri più scarso di tutta la storia dei Beatles. E invece qual è il lato migliore? Onestamente non lo so – bisogna fare la media e non credo che ne valga la pena – però posso dirvi qual è l’unico lato dei loro dischi che non abbiamo ancora cominciato ad ascoltare, ovvero quello in cui non c’è neanche una canzone sotto il 110: ebbene sì, è proprio quello che comincia con Birthday, il terzo lato del Bianco. L’avreste mai detto?
In generale non credo che nessuno lo consideri il miglior lato di quel disco: non contiene nessun grande classico, la canzone più famosa è Helter Skelter e non è famosa per i motivi giusti. Però non c’è nessun riempitivo inutile – a meno che non sia proprio Birthday, il primo brano che incontriamo risalendo. E però come si fa a considerare inutile Birthday? È veramente il punto centrale del Disco Bianco, quello che mette le cose in chiaro una volta per tutte: questo album è una festa, e come in tutte le feste non è che tutto vada alla perfezione, anzi. Fanculo alla perfezione, Birthday arriva a metà, dopo il minuto di raccoglimento per Julia, ed è più o meno il momento in cui accendono la luce e servono la torta con le candeline, il che significa che un sacco di gente è già ubriaca. E va bene così, sono felice che è il tuo compleanno. Se Sgt. Pepper era la risposta a Pet Sounds, questo pezzo è un breve e fortunato tentativo di fare qualcosa di paragonabile all’altro disco iconico dei rivali californiani, Beach Boys’ Party. Nei primi anni le feste erano lo sfondo in cui si incontravano i personaggi del beatleverso, più che altro per ballarsi o tenersi la mano o evitarsi. I tempi passano, i ragazzi crescono, ora sta ai Beatles non tocca più partecipare a una festa, ma organizzarla. E ci riescono alla grande, secondo me, come quelle famiglie che sprizzano energia anche quando litigano.
Birthday può sembrare un brano inciso alla svelta e lo è, ma è anche il vero manifesto del disco, la dichiarazione d’intenti: per quanto ci abbiano messo mesi a registrarlo, la maggior parte delle canzoni suona proprio come Birthday, che invece fu scritta e incisa in un giorno, buona la prima. Considerato che erano il gruppo più famoso del mondo e stavano scrivendo una canzone sul compleanno (giova ricordare che Tanti auguri a te è stata per lungo tempo una delle canzoni più redditizie), la scelta di buttar giù un rock’n’roll ridanciano non era affatto scontata. Da un punto di vista musicale poi Birthday è molto più interessante di quanto sembri. La prima parte è un solido blues basato su un riff semplice e martellante, suonato all’unisono da chitarra e basso. Niente di strano, insomma, salvo che è il 1968. L’idea di costruire canzoni sui basici riff di chitarra non era originalissima e aveva già regalato grandi soddisfazioni ai primi Kinks (You Really Got Me) e ai Rolling Stones (Satisfaction), ma nel 1968 sia Kinks che Stones facevano già altro – la fiaccola è passata ai Cream. Al termine della sbornia psichedelica, i Beatles tornano ai riff col Disco Bianco. Di lì a poco, un altro quartetto inglese imporrà i riff semplici e potenti su progressioni blues sempre più ossessive: stanno già provando da qualche parte a Londra, a un certo punto decideranno di chiamarsi Led Zeppelin. Ebbene sì, Birthday è il brano che assomiglia più a Heartbreaker.
108. The Word (Lennon-McCartney, Rubber Soul)
In the beginning I’ve misunderstood. But now I’ve got it, the word is good. Quelli che preferiscono Rubber Soul, hanno buon gusto. Forse troppo buon gusto per essere veri beatlemani. Rubber Soul è il disco cool, quello che pur senza smettere di fare passi avanti, non ne fa nemmeno uno falso, nemmeno uno più lungo della gamba. Gli esperimenti sono tutti controllati e rigorosi e somministrati a un pubblico già testato dai due dischi precedenti. I rischi (che ci sono), sono minimizzati, e forse è l’unico caso in cui Lennon e McCartney si sono detti ok, contentiamoci di fare al massimo quello che sappiamo già fare. Per esempio il blues come lo facciamo noi – un po’ di plastica? E sia. Un blues, però col bridge. Non era nemmeno la prima volta che ci provavano: quel che cambia è una maggiore consapevolezza dei limiti e delle capacità, una coolness che si taglia col coltello e ti può anche lasciare un po’ freddo se ti piacciono i Beatles maldestri e scavezzacollo.
Più di un compositore, al massimo delle sue capacità, si è lasciato tentare da quell’esibizione di coolness suprema che è la canzone su una nota sola. Rossini il più rigoroso, Elio il più situazionista, e chissà se Lennon aveva in mente l’esempio di Jobim: in comune con la Samba de uma nota só c’è l’idea di variare il monomelodismo della strofa con un bridge più movimentato. E se Jobim si faceva scrivere un testo autoreferenziale, Lennon è più sottile: la canzone che gira intorno a una nota sola anche dal punto di vista del contenuto dovrà girare intorno a un solo concetto, a una sola Parola. Questa Parola – ne siamo sicuri ben prima del ritornello – non può che essere “amore”, l’argomento del 99% delle loro canzoni fin qui. Sarebbe incredibile a questo punto che Lennon avesse qualcosa di nuovo da dirci, eppure succede.
La necessità di trattare l'”amore” come una parola astratta lo porta sugli imprevisti sentieri retorici del predicatore, da cui il divertente paradosso: la prima canzone composta durante l’assunzione di cannabis (secondo la testimonianza di McCartney) è anche la prima canzone in cui compare nei testi di Lennon una reminiscenza evangelica: “Say the word” viene nientemeno che da Matteo 8,8, la sfida tra Gesù Cristo e i Beatles è appena stata lanciata e Lennon comincia già a scopiazzare. Nel vago messianismo del testo sarà poi riconosciuta la profezia del flower power prossimo a sbocciare.
107. Mother Nature’s Son (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
All day long, I am sitting singing songs for everyone. Quando viaggi non sai mai cosa ti porti a casa, ma qualcosa comunque te lo porti. I Beatles andarono in India a cercare l’Assoluto; non lo trovarono; ci rimasero male; se la presero con il Maharishi. Tornarono a casa con splendide canzoni arpeggiate alla chitarra acustica. Niente assoluto, ma in compenso avevano scoperto il Fingerpicking. Buttalo via. Ne sarebbe valsa la pena anche solo per quello: non per le sedute col guru, ma per le pause sigaretta-chitarra con Donovan.
Il motivo per cui ho iniziato questa cosa è che riascoltando i Beatles mi sono accorto che per me ogni canzone era una storia. A volte anche più storie. Mi sembrava un’idea interessante raccontarle. Quasi sempre può essere un modo per convincere qualcuno ad ascoltarla, o riascoltarla, quindi perché no. Ci sono però casi in cui le storie danneggiano la canzone. Mother Nature’s Son è un breve idillio campestre tratteggiato da Paul alla chitarra e sostenuto da un’orchestrazione minimale (suggerita da Lennon), se posso usare “incantevole” una volta sola ogni venti canzoni me la gioco con questa. Una splendida mattina sotto un cielo terso, con appena qualche nuvola all’orizzonte, bianca, inoffensiva. Qualsiasi cosa io possa aggiungere la renderà più incantevole?
Per esempio: è la canzone che ha buttato fuori dal Disco Bianco Child of Nature di Lennon, perché erano entrambe ispirate a un sermone del Maharishi e quindi decisero di tenerne una sola. E a questo punto il cielo comincia ad annuvolarsi, cominciamo a domandarci se è stata la scelta migliore, ovvio che no! Child era più ispirata… ma forse proiettiamo, perché più che Child abbiamo in mente quello che sarebbe diventata, ovvero Jealous Guy, ma alzi la mano chi si immaginava nei primi anni ’70 che Jealous Guy sarebbe diventata una delle più iconiche canzoni di Lennon? Non è stato un po’ grazie ai Roxy Music? Non è stata la somiglianza a Imagine, la perfetta aderenza all’immagine di sé che Lennon volle dare da un certo momento in poi? Potremmo aggiungere che Mother’s Nature Son è la prosecuzione di The Fool On the Hill, che contribuisce a costruire quell’immagine eremitica di Paul che a sua volta sarebbe diventata la sua identità ‘pubblica’ nei primissimi anni postbeatlesiani; che sviluppa con più serenità più o meno le stesse trovate di Blackbird e all’interno del Disco Bianco si trova in una curiosa dialettica con Sexy Sadie, il brano che irride lo stesso Maharishi. Nel frattempo il cielo si è fatto plumbeo, si vedono già i primi fulmini dietro a quelle nuvole nere là in fondo, ecco fatto. Ogni canzone ha una storia, ma certe canzoni non ne hanno alcun bisogno.
106. This Boy (Lennon-McCartney, lato B di I Want to Hold Your Hand, 1963).
Quel ragazzo mi ha portato via l’amore, ma se ne pentirà; questo ragazzo invece ti rivuole. Cosa ci fa così in alto questa? This Boy prosegue la tradizione del lato B lento da suonare dopo aver stancato la ragazza saltellando sul lato A; in particolare è il lento che accompagna I Want to Hold Your Hand, il 45 giri che proiettò i Beatles nel mercato americano: e questo credo spieghi l’affetto particolare dei critici americani che la beatlemania fecero in tempo a viverla nei suoi primi giorni acerbi e incomprensibili, la loro passione per certi precoci momenti della ditta Lennon-McCartney che noi ascoltatori europei troviamo francamente datati. Abbiamo un orecchio diverso: This Boy per noi sembra un tentativo non troppo originale di muoversi sui sentieri del doo-wop, dei quartetti vocali anni Cinquanta – il che tra l’altro fa a pugni con l’idea abbastanza inglese e in generale continentale, secondo cui i Beatles costituirebbero una frattura tra i Cinquanta e i Sessanta, il pop dei nonni e il rock dei padri, il medioevo e la contemporaneità. Che Lennon possa essere stato tentato di ricostruire le atmosfere languide di qualche emulo dei Platters ci sembra un dettaglio secondario, da nascondere sotto il tappeto. In America non la pensano così. In America questo tipo di emulazione suonava così strana, quasi oltraggiosa, da costituire qualcosa di nuovo. Come scrive Dylan di I Wanna Hold Your Hand: quegli accordi erano un oltraggio, ecco, anche l’idea che i coretti vocali potessero farli tre zazzeruti ragazzi inglesi, aveva qualcosa di inconciliabile col buon gusto. Noi vorremmo che la Storia procedesse a scatti: vorremmo dimostrare che i Beatles hanno fatto la Storia inventando qualcosa di nuovo, il che è un po’ vero ma equivochiamo il senso di cosa sia un’invenzione: per noi dovrebbe essere una specie di creazione dal nulla. I Beatles non creavano dal nulla: prendevano tutto quello che sapevano, lo mescolavano un po’, lo eseguivano al meglio delle loro capacità ma fraintendendo questo o quell’elemento, e non facendo attenzione a dettagli che invece per gli ascoltatori tradizionali erano fondamentali. Il risultato è sì, qualcosa di nuovo, ma ottenuto attraverso un procedimento accidentale, evolutivo.
Un aspetto originale di This Boy è che parla di un triangolo: una ragazza e due ragazzi: uno la rifiuta, l’altro la rivuole. Situazione abbastanza topica per le canzoni pop, ma non per i Beatles (mi viene in mente solo You’re Going to Lose That Girl, forse You Can’t Do That), e questo malgrado la gelosia, lo abbiamo già detto quella dozzina di volte, sia la musa specifica di John Lennon. Ma forse è una gelosia talmente insofferente che non tollera la presenza di un rivale: è una gelosia preventiva, la ragazza deve stare attenta anche solo a guardarli, i potenziali concorrenti. Al punto che ascoltando This Boy può venire il dubbio che “that boy” e “this boy” non siano che figure dello stesso Lennon, sospeso tra le due polarità del suo carattere: quel ragazzo non ti vuole più, quest’altro sì. This Boy è il fantasma che opprime Paul McCartney mentre si danna per registrare Oh! Darling, un’altra canzone in cui il triangolo è troppo imbarazzante e penoso per essere esplicitato.
105. The Ballad of John and Yoko (Lennon-McCartney, singolo, 1969).
Succede tutto all’improvviso. Un mese prima Paul McCartney ha sposato Linda Eastman a Londra con una piccola cerimonia civile. Pochi giorni dopo, John Lennon, in vacanza a Parigi, chiede a Yoko Ono di condividere i cognomi. Lei dice di sì, ma si scopre che in Francia due sudditi di Sua Maestà non possono unirsi nel sacro vincolo. Che scemenze, bisognerebbe fare qualcosa per tutte queste frontiere inutili, che ne so, un’Unione Europea, seh, campa cavallo. Comunque contattano i loro agenti, che contattano le ambasciate e i consolati, che contattano qualcun altro e insomma alla fine si trova per questa capricciosa coppia di artisti-VIP una soluzione di compromesso: Lennon e Ono si sposeranno a Gibilterra, che non è Parigi neanche per sbaglio ma è abbastanza vecchia romantica Europa senza smettere di essere territorio britannico. Il viaggio prosegue ad Amsterdam, dove i due novelli sposi organizzano uno dei loro primi e più riusciti happening, il bed-in. Tornato da quella che a questo punto è una luna di miele, John porta una canzone da registrare ai Beatles, salvo che non è affatto chiaro se esistano ancora, i Beatles.
Dopo la deprimente conclusione del progetto Get Back! si erano dati una pausa: George Harrison è in vacanza, Ringo è impegnato sul set di un film; a Londra c’è solo Paul ma, a differenza di quello che succederà mesi dopo con Cold Turkey, Paul un singolo con John ha voglia di inciderlo. Suonerà il basso ma anche la batteria, che aveva già inciso in qualche pezzo del Bianco quando Ringo s’era eclissato temporaneamente. Sono momenti difficili per la Apple Corps: un singolo targato Beatles è comunque una rassicurante fonte di entrate, e una garanzia che tutto sta ancora in un qualche modo funzionando. E qualcosa sta funzionando. Non è certo la prima volta che gli artisti ancora noti col nome di Beatles incidono qualcosa in fretta e furia: non è più un’esigenza contrattuale ma forse è diventata un’esigenza esistenziale. Possiamo davvero immaginarci Paul che ascolta la canzone e pensa: se non lo assecondo stavolta, questo molla la ditta. E quindi Lennon avrà la sua canzone nuziale targata Beatles. Forse non ci teneva nemmeno. D’altro canto è probabile che se non l’avesse registrata con Paul, l’avrebbe mandata fuori da solo o con Yoko ai cori. Chi ha scritto su wikipedia che The Ballad non è una vera ballata non ha capito il senso del riferimento: Lennon ha in mente il senso del termine nel folk americano, in cui la Ballata è un brano più cronachistico che narrativo, che serve per informare il pubblico di qualcosa di importante e di appena successo; e quello che rende un filo imbarazzante l’ascolto di The Ballad of John and Yoko è che chi canta sembra davvero continuo di aver vissuto una genuina avventura, qualcosa di romantico e appassionante che dovrebbe interessarci. “Se vanno avanti così le cose, mi crocifiggeranno”, dice, e non è chiaro se stia scherzando o no.
The Ballad è un’instant song, la prima di un mazzetto di instant song che Lennon comporrà nei mesi successivi con varie denominazioni: qualche mese dopo ci sarà Give Peace a Chance targata Plastic Ono Band (ancora attribuita a Lennon-McCartney!), in autunno Cold Turkey che avrebbe potuto essere ancora un brano dei Beatles se McCartney non si fosse opposto; in febbraio Instant Kharma, la sua prima collaborazione con Phil Spector. I brani – registrati sempre al volo, con un’urgenza che è percepibile nell’esecuzione – erano parte di una strategia di occupazione dei media da parte della coppia Lennon-Ono, insieme con gli happening per la pace. Oltre alla pace nel mondo, Lennon stava anche lottando più o meno consapevolmente per costruire la sua immagine pubblica post-Beatles, e col senno del poi stupisce quanto Paul fosse pronto ad assecondarlo, perlomeno fin qui. La canzone d’altro canto è piacevole, anche e soprattutto per quell’aria di fatto-in-casa: e dire che, con l’eccezione di un brano sui generis come All You Need Is Love, è il primo vero Lato A di Lennon dopo un biennio di trionfi di Paul. Il rischio che diventi una hit è comunque parzialmente scongiurato con l’inclusione di quella sillaba blasfema nel ritornello, “Christ”. Alle radio inglesi e americane fu distribuita una versione decristizzata, il che trasformava il primo ascolto del singolo appena acquistato in uno choc, una specie di esperimento sociale, condotto per lo più sullo stesso bacino di ascoltatori che non avevano gradito quella famosa uscita di Lennon sull’essere più famosi di Gesù.
Ma insomma rimane sempre sospeso nell’aria quell’interrogativo: sta scherzando? Possono passare decenni dal primo ascolto prima di accorgersi che il testo è molto meno ironico di quando il tono di quella voce non autorizzi a pensare. A riscattarlo è l’attitudine con cui lo canta, quel tono beffardo con cui sembra prendersi gioco anche di sé stesso – come se da qualche parte nella sua testa ci fosse ancora quel ragazzo sfrontato che scrolla la testa davanti alle mattane dei due milionari.
104 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (Lennon-McCartney, nel disco omonimo, 1967).
Ha un senso trattare la Reprise del brano che dà il titolo a Sgt. Pepper come una canzone a parte? Secondo qualche critico sì, e chi siamo noi per opporci. Ultimate Classic Rock la inserisce in classifica più di cento posizioni sotto il primo brano; Vulture invece la mette quaranta posizioni più avanti! Al di là di tutto, è pur sempre il pezzo che ha introdotto nei dischi di musica leggera il concetto di reprise. Se non lo avessero fatto loro molto presto ci avrebbe provato qualcun altro, però oh, niente da fare, anche stavolta sono arrivati prima loro. Del brano iniziale mantiene soltanto il bridge, che si era sentito sul primo lato appena per ventiquattro battute, e lo ripresenta un po’ accelerato, quasi funky, come se Ringo avesse già capito che in certi casi più che un batterista serve una drum machine. Nella traccia vocale il falsetto di Lennon prende il sopravvento, causando nell’ascoltatore un misto di soddisfazione e rimpianto; soddisfazione, perché viene ripreso con più agio un tema che nel primo lato era stato abbozzato ma subito soppresso per introdurre altre cose più barocche e vistose ma non necessariamente migliori; rimpianto perché accidenti, allora è vero che sotto i costumi colorati c’è ancora una rock’n’roll band, e dispiace avere così poco tempo per sentirla. “We’re sorry but it’s time to go”, ma come? Siete appena arrivati!

Sgt Pepper (il disco) funziona “perché noi abbiamo detto che funzionava” (Lennon): in un certo senso è vero; il momento preciso in cui l’ascoltatore ha la sensazione che il Concetto funzioni è proprio quello in cui i suoni della fattoria si mescolano al “One-Two-Three-Four” della banda. Per un minuto, tutto sembra al suo posto. Ascoltando la Reprise abbiamo la sensazione di aver trovato la cornice intorno al quadro – e di aver capito che è un quadro-nel quadro, una mise en abyme, una band dentro la band. Poi comincia A Day in the Life, ed è subito chiaro che siamo fuori dalla cornice, quasi fuori dal disco, in uno spazio nuovo che i Beatles stanno appena iniziando a creare. Non c’è più bisogno di travestirsi – ma è stato divertente.
103. Run For Your Life (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Non posso mica passar la vita a farti stare in riga. Il disco più rappresentativo della band più di successo di tutto l’Occidente, nell’anno di grazia 1965, si conclude con un abbozzo di femminicidio. Il disco che vola in classifica ed entra in gran parte delle case dei possessori anglofoni di giradischi comprende il verso: you know that I am a wicked guy and I was born with a jealous mind. Sì, senz’altro il rock and roll da classifica si era già dato un’aria da maudit, ed Elvis aveva anche ventilato trascorsi carcerari, ma qui davvero Lennon non si sta bullando, non recita, non si atteggia: sta tirando fuori da sé un’ossessione con una spietatezza che capovolge il senso di Run for Your Life: quella che al primo ascolto ci può sembrare la canzone più datata del mazzo (anche per l’arrangiamento country che dopo i primi cinque dischi associamo istintivamente ai brani tappabuchi) si rivela il brano più contemporaneo.
Come suggerisce fortuitamente la copertina di Rubber Soul, Lennon fora la quarta parete, abolisce tutti i filtri tra il suo vissuto e il suo personaggio pubblico, si toglie per la prima volta la divisa da Beatle e confessa di essere un mostro, un un tizio da cui stare lontano. Oltre alle parole, è fondamentale il tono con cui le dice, il timbro quasi stridulo, satanico, di un tizio che ha deciso che è pazzo e che tutto sommato gli sta bene così. Non possiamo non pensare a Cynthia ma anche in questo caso, ricordiamo: Lennon canta soltanto di sé stesso ed è da sé stesso che propone a sé stesso di scappare. Certo, finire il disco con The Word sarebbe stato molto più rassicurante. Ma chi preferisce Rubber Soul forse ha ragione, c’è qualcosa di potente nell’idea di finire il disco con la canzone meno conciliabile, meno socializzabile: l’anno che era iniziato con un grido di Aiuto finisce con un Lennon braccato dalle proprie ossessioni: corri ragazzina, se vuoi salvare la pelle.

In seguito ovviamente lo stesso Lennon si sarebbe pentito di tutta questa sincerità. In un’intervista si sarebbe addirittura ridotto a puntare il dito verso un compagno – l’atteggiamento tipico del molestatore messo davanti alle proprie responsabilità: non la volevo incidere, ma sapete, George ci teneva tanto. George Harrison in effetti aggiunge un buon assolo e un tocco di falsetto nei cori che aumenta il senso di dissociazione. Ma è buffo pensare che John avesse bisogno di essere istigato da lui, per incidere Run for Your Life. E allo stesso tempo, dietro a ogni bullo c’è sempre un gregario che istiga e pungola, che ha voglia di veder scorrere il sangue.
102. I’ll Cry Instead (Lennon-McCartney, A Hard Day’s Night, 1964).
Quando sarà ora vi conviene nascondere tutte le ragazze del mondo, perché spezzerò il cuore a tutte, glielo spezzerò in due. Ma nel frattempo… invece piangerò. Non avrà portato la pace nel mondo, John Lennon, ma ha comunque fatto qualcosa di politicamente prezioso: è stato uno il primo macho a calare la maschera e rinunciare a un ruolo patriarcale che era stato quasi progettato per ricoprire. Sia all’interno del gruppo che nella sua vita privata, Lennon è stato un non-leader: il primo degli antieroi, il primo a svelare ed esibire la fatica che costa al maschio alfa nascondere dubbi e le paure sotto un ghigno. Lo ha fatto nel momento stesso in cui ha accettato nel gruppo una forza creativa come Paul, ben sapendo che non l’avrebbe mai potuta dominare. Come notava Philip Norman, tutti i gruppi del periodo si chiamavano “Tal dei Tali e Compagnia Bella”, vedì Gerry and the Pacemakers. Anche i Beatles avrebbero potuto chiamarsi John and the Moondog, o John and the Silver Beatles, e se non successe fu perché John, malgrado le sue pose da leader, non lo voleva. Fu John Lennon a inventare il concetto di Band che diamo per scontato da mezzo secolo, un pool di artisti-compositori legati da un sodalizio artistico senza nessun leader apparente: fu lui che lasciò a Paul la libertà di incidere Yesterday quando ancora poteva esercitare un qualche diritto di veto, e addirittura gli suggerì di ripescare l’arpeggio di Michelle: se i Beatles esplosero creativamente in modo incontrollabile, fu John che lo permise.
Costa qualche fatica ammetterlo, visto che nessuno dei due John estremi risulta così simpatico: né quello femminicida di Run for Your Life, né quello ripiegato a larva sulla moglie-madre Yoko. E allo stesso tempo bisogna riconoscergli di essere stato l’autore che a un certo punto ha smesso di considerare la gelosia un simpatico argomento per canzoni da teenager, e si è accorto che somigliava più a una malattia. Questo in realtà succede all’altezza di Getting Better, non certo con I’ll Cry Instead, che è una più semplice variazione su un tema tipico di molte hit r’n’b: dietro la maschera da uomo c’è un ragazzino che piange. Ma nei brani di Smokey Robinson si tratta di un meccanismo funzionale a conferire al personaggio del cantante una maggiore profondità: mi vedi qui tutto allegro ma in realtà in segreto mi struggo, ecc. In I’ll Cry Lennon va più avanti in direzione dell’autoparodia, anche a causa dell’arrangiamento country: musica e parole sono esattamente quelle che ci si aspetterebbe dal solito macho possessivo che Lennon ha appena interpretato con molta convinzione in You Can’t Do That. La rivelazione arriva inattesa nel ritornello, proprio come una maschera che casca all’improvviso: tutto quello che posso davvero fare è… piangere.
101. The Night Before (Lennon-McCartney, Help!, 1965)
Quando penso alle cose che abbiamo fatto, mi viene voglia di piangere. The Night Before descrive con più versi a disposizione la stessa situazione di Yesterday: ieri ero felice e innamorato, oggi è successo qualcosa di irreparabile. E come in Yesterday qualcosa non torna nella verbalizzazione: “trattami come mi trattavi la notte prima” non è meno incongruo di “Ieri arrivò all’improvviso” o “credo nello ieri”. Ma insomma siamo nella fase in cui Paul comincia ad accorgersi che le relazioni sono cose complicate, e “Treat me like you did the night before” è un verso di una goffezza disarmante e spietata: non potresti comportarti con me come se rispetto a ieri non fosse successo niente? Il machismo è finito, almeno sul versante di Paul: i personaggi maschili sono sempre più insicuri e smarriti. Sul versante John c’è ancora spazio per qualche scenata di gelosia, ma ormai si è capito che è quasi tutta scena.
The Night Before è uno di quei brani composti e incisi dai Beatles col pilota automatico, al punto che gli stessi protagonisti hanno ricordi molto vaghi. Lo spezzone dedicato di Help!, ambientato a Stonehenge, colpisce per lo scarto sempre più notevole tra immagine e contenuto: anche quando cantano di amori difficili, i Quattro devono sorridere e scambiarsi smorfie di entusiasmo e soddisfazione. Che importa se la bruma è fredda e il vento soffia, ridete perdio, siete i Beatles. Lennon è ormai accreditato come l’organista del gruppo; Paul canta e doppia l’assolo di George (su un’ottava diversa). Probabilmente era una soluzione di compromesso per lasciare a George il ruolo di chitarra solista anche nei casi in cui Paul arrivava con un pezzo già completo di chitarra solista; da un punto di vista stilistico però è un modo di far sentire l’assolo come qualcosa di diverso; non più lo sfogo esibizionistico di un chitarrista, ma un breve movimento coordinato, una variazione. Più un riff che un assolo, ormai.
100. Everybody’s Got Something to Hide Except Me and My Monkey (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Take it easy! Il Disco Bianco è una festa. Non delle più riuscite, ma avresti comunque voluto esserci. Comincia a razzo, sbanda quasi subito, c’è chi è ubriaco prima della torta, c’è chi si apparta per fare sesso o farsi, chi litiga davanti a tutti e non gliene frega più un cazzo, chi se ne sta in un angolo a pensare alla mamma, chi ha preso la pastiglia sbagliata e vede tutto distorto, chi ha il mal di mare, e in mezzo alla stanza ci sono John e Yoko che ballano e sudano come due bambini in overdose da zucchero filato. Forse sono fatti anche loro, forse sono solo felici e spudorati. Non hanno niente da nascondere. Take it easy!
C’è del metodo in questa allegria. Di tutti i brani del Bianco che predicano un ritorno al rock, Everybody è (con Birthday) il più programmatico. Sarà un rock libero dalle gabbie tradizionali, non più strutturato su un giro blues, ma imbastito intorno a riff di chitarra semplici e graffianti raddoppiate dal basso, e un Ringo scatenato (se Ringo torna). Sarà deliberatamente spensierato: basta lagne, la vita è già difficile, ora facciamo festa. È un rock che non assomiglia né a quello d’importazione delle cover beatlesiane fino al ’65, né a quello post-psichedelico, più torrido ma ancora blueseggiante che a questa altezza stanno perfezionando i Rolling Stones e gli altri gruppi della Seconda Invasione, Small Faces o Yardbirds. È un rock che se non fosse così gioioso sarebbe un filo più simile al quello melodrammatico di Tommy, che uscirà solo l’anno dopo, ma in linea di massima è un unicum, qualcosa che solo i Beatles stavano facendo in quel momento, e neanche loro ci credevano del tutto. È il rock di Everybody’s Got Something, Birthday, Hey Bulldog, I’ve Got A Feeling, Dig A Pony. È un prodotto più lennoniano che mccartneyano, ma Lennon non aveva più le forze per imporlo e Paul tradiva un approccio più derivativo: vogliamo fare un rock? Possiamo farlo alla Chuck Berry (Back in the USSR), o alla Fats Domino (Lady Madonna), o perfino alla Beatles prima maniera (One After 909).
Se invece avessero deciso che quella di Everybody’s Got Something era la direzione giusta (e non si fossero sciolti), forse verso il 1969-70 avrebbero codificato un loro preciso stile rock, proprio come fecero i Rolling Stones tra Beggars’ Banquet e Sticky Fingers. Che rock sarebbe stato? Non possiamo saperlo, non è successo, e probabilmente non sarebbe potuto succedere. È una domanda oziosa. Ma tutto è ozioso qui, quindi take it easy e proviamoci: che rock avrebbero suonato i Beatles a cavallo tra Sessanta e Settanta, se invece di spaziare tra tutti i generi musicali di Occidente e Oriente fino a disperdersi, avessero deciso di delimitare un sound preciso e cristallizzarlo, come gli Stones e gli Who e tutti i ragazzini che negli anni ’60 avevano avuto la botta di culo di scalare le classifiche e negli anni ’70 volevano farne un mestiere? La butto lì: sarebbe stato un rock simile a quello dei primi Led Zeppelin. Estremo, spensierato, basato su riff graffianti, grandi esibizioni vocali e un Ringo fracassone e scatenato. Non ho ovviamente argomenti per sostenere questa cosa, ma provate nella vostra testa a immaginare Robert Plant che canta Everybody’s Got Something to Hide. Nel momento in cui prende la canzone in gola e la porta un gradino più su: Take it easy! e un altro gradino: Take it easy! Everybody’s Got Something è la finestra aperta su quello che avrebbero potuto diventare i Beatles, se avessero ancora potuto accontentarsi di diventare qualcosa. Il punto è che no, non era così facile, e lo sapeva John per primo.
99. Long Long Long (George Harrison, The Beatles, 1968).
C’è voluto tanto, tanto, tanto tempo. Ogni canzone dei Beatles, abbiamo detto, è un esperimento. Long Long Long ne contiene parecchi, tra cui forse uno sul principio di indeterminazione, ovvero: esiste Long Long Long prima che la ascoltiamo? Probabilmente sì, ma dipende molto da cosa abbiamo ascoltato prima: i Beatles o Dylan? Il Disco Bianco o Blonde On Blonde? Siamo tra quelli che abbiamo semplicemente alzato il volume al massimo e pensato beh, ma questa canzone brevissima è stupenda! O siamo quelli che abbiamo riconosciuto con una smorfia di soddisfazione il riferimento, e ci siamo compiaciuti con George, bravo George, che idea infilare proprio alla fine del terzo magico lato una versione supercondensata di Sad Eyed Lady of the Lowlands. Un riferimento che non era così scontato nemmeno nel 1968 – certo, Dylan era già il recalcitrante Divo della Controcultura, e Blonde era il suo disco più venduto. Era una indiscussa celebrità, ma non paragonabile a quella dei Beatles. I Beatles se la giocavano con Gesù, Dylan poteva dirsi contento se Johnny Cash lo invitava in tv. Più che un plagio è l’ennesimo rimpallo di una lunga partita: quando Lennon aveva scritto Norwegian Wood Dylan aveva risposto con Fourth Time Around; quando i Quattro lo avevano cartonato sulla copertina di Sgt Pepper, Dylan li aveva nascosti in quella di John Wesley Harding. E insomma a partire dalla fine del 1968, per la maggior parte degli ascoltatori Sad Eyed Lady diventerà la versione estesa di Long Long Long.
Un altro esperimento riuscito con Long Long Long ha a che vedere con la relatività, non nel tempo ma nello spazio, ovvero: sarebbe ancora la stessa canzone se non si trovasse esattamente dov’è, seminascosta al termine di quell’incredibile terzo lato che è tutto un saliscendi di pezzi fracassoni e intermezzi acustici, e proprio al termine del pezzo più frastornante di tutti, un pezzo che sembra non voler finire? Avrebbe ancora lo stesso significato, quel Long Long Long scandito eterealmente da George, se non venisse subito dopo l’urlo sdegnato di Ringo, “Ho le vesciche alle dita?” Il terzo esperimento ha a che vedere col volume, perché è probabile che durante Helter Skelter molti scandalizzati ascoltatori del 1968 l’abbiano abbassato, e che quindi non stiano ascoltando George, se non a livello subliminale. Long Long Long è la classica canzone di cui ti accorgi dopo un po’ che è iniziata, e forse l’ingresso rumorista di Ringo, oltre a riecheggiare sulle macerie di Helter Skelter, serve proprio ad avvertire: ehi, alzate il volume, c’è ancora una canzone su questi solchi. È incisa pianissimo, ma c’è. Era un espediente abbastanza originale per i tempi (e oggi nell’era della compressione dinamica lo è ancora di più): dopo aver dimostrato di poter suonare più forte di tutti, i Quattro decidono di suonare più piano di sempre, insomma di potersi permettere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. In realtà il momento è calcolatissimo e forse l’esperimento tiene anche conto di una variabile ormai sconosciuta: la fragilità dei solchi di vinile più vicini al centro del disco. Long è una canzone fragile nel punto più fragile del supporto. Qualcosa di simile alla pudica Sad Eyed Lady che Dylan aveva rinchiuso in un lato del disco tutto per lei, come una dama nella torre più alta del castello. È come se non volesse davvero essere ascoltata, e quando decidiamo che invece vogliamo farlo davvero, quando alziamo il volume come si punta un faro su un fuggitivo, Long si ribella ed esplode nell’ennesimo esercizio di caos.
98. Magical Mystery Tour (Lennon-McCartney, Magical Mystery Tour, 1967).
That’s an invitation. Quando ho iniziato questa cosa, volevo semplicemente scrivere di un argomento che conoscevo abbastanza bene. I Beatles credevo di conoscerli, a causa di una frequentazione iniziata nella prima adolescenza. Ovviamente sbagliavo: primo perché tutto sommato tante cose mi sfuggivano (e mi sfuggono ancora), secondo perché non è una buona idea scrivere sulle cose che hai conosciuto nella prima adolescenza. Come ho potuto dimenticare uno degli assiomi fondamentali della mia esistenza, ovvero che gli adolescenti non capiscono niente? Come posso fidarmi delle mie opinioni sulle canzoni dei Beatles se molte di esse nascono da prime impressioni scaturite in un momento in cui non capivo niente e ascoltavo le cassette su un registratore portatile panasonic mono? Per dire, non sarà colpa del mio acerbo orecchio, della mia scarsa strumentazione, se ho sempre avuto la sensazione che Sgt Pepper sia mixato male? Come se non riuscisse a soddisfare le pretese che lo costruiscono – mentre Revolver è un superbo disco in bianco e nero, e Magical Mystery Tour è già una gioia di colori, sin da questo brano che è poco più che una sigla ma è splendido, la premessa di un mondo fantastico in cui sarebbe potuto succedere di tutto e i Beatles avevano la possibilità di farlo succedere. Cambia tempo, cambia timbro, cambia tutto e tutto ancora funziona. Poi un bel giorno scopro che il brano Magical Mystery Tour fu inciso durante le sessioni di Sgt Pepper – possibile?
A me continua a sembrare che siano passati mesi, è come se lo stesse già citando, e allo stesso tempo suonasse già più addomesticato, più vicino al nostro orecchio, più technocolorato. Ho sempre immaginato nella mia testa Sgt Pepper come il primo disco a colori, e ho sempre immaginato i colori di Sgt Pepper un po’ maldestri, sbiaditi o ingialliti come le polaroid o i film mal restaurati del periodo. Invece Magical Mystery Tour comincia con quel suono di fanfara squillante che mette per un attimo tutto a fuoco. O forse nel frattempo mi ero comprato uno stereo decente? Waiting to take you away – take you today.
97. When I’m Sixty-Four (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band, 1967).
Granny songs, le definiva John. Le canzoni del nonno, il debole di Paul. When I’m 64 è la prima vera granny song ed è anche il manifesto di tutte quelle che seguiranno. Quello che stava iniziando come un divertimento, in realtà era una presa di posizione: io sono Paul McCartney, e un giorno avrò 64 anni. Come il Sergente Pepe, come mio padre. Forse capiterà anche a voi, ma non ci state pensando. Io invece ci penso da sempre. Hope I die before I grow old, cantava Roger Daltrey. You’ll be older too, risponde Paul. When I’m 64 è l’anti-MyGeneration, molto più di quanto Helter Skelter sia l’anti-I Can See For Miles. Io non rappresento una generazione, ci spiega Paul. Faccio rock perché sono giovane: quando sarò vecchio farò le cose che piacciono ai vecchi, musica inclusa. Gli ascoltatori ridacchiano, sembra uno scherzo. Ma non finisce con le risate, come il pur seriosissimo brano precedente.
Paul scrisse When I’m 64 a 16 anni. La strimpellava col piano già al Cavern Club, mentre gli altri tre erano in pausa a fumare. Prima o poi avrebbe voluto registrarla, ma coi Beatles per molto tempo sembrava impossibile. Bisognava creare le premesse, trasformare una rock’n’roll band in qualcosa d’altro: ma anche dopo aver aggiunto i violini in Yesterday, il sitar in Norwegian Wood, questo brano sembrava unbeatlable. Da cui forse l’idea geniale di Sgt Pepper: e se invece di fare il solito disco dei Beatles, facessimo finta di essere un altro gruppo, un gruppo più eclettico? Poteva essere un modo per riciclare idee valide ma fino a quel momento troppo eccentriche. Alla prova dei fatti tuttavia l’unico vero ripescaggio operato in Sgt Pepper fu questo vecchio brano di Paul in cui Paul si immagina nonno: questo appunto poteva essere uno dei sensi della casacca del Sergente Pepe, un tizio che se “ha insegnato la banda a suonare”, lo ha fatto comunque almeno “vent’anni fa oggi”.
Il Sergente potrebbe essere il vecchio Paul, coi baffi che lo fanno somigliare un po’ di più al padre (che aveva appena compiuto 64 anni). La Band del Club dei Cuori Spezzati potrebbe essere i Beatles tra vent’anni, barbuti e impolverati, molto oltre la parabola del loro successo, relegati a suonare marcette nei piovosi parchi del Merseyside. Gli altri tre non l’hanno ancora capito, sono convinti che il disco parli del loro passato; Paul lo sa, che passato e futuro sono illusioni: tutto era già scritto sin dall’inizio. Ringo è nato battendo il tempo col piede sbagliato, George era un guru a 16 anni, John un rocker che per sopravvivere doveva diventare un compositore, Paul un compositore che per sopravvivere doveva atteggiarsi a rocker. Alla fine hanno tutti regalato qualcosa agli altri: forse le migliori canzoni le ha composte John, e Paul ha cantato la migliore Long Tall Sally. Ma era tutto già predisposto, compreso forse chi dovesse soccombere a un successo insostenibile, e chi dovesse sopravvivere per raccontarcelo.
96. Within You Without You (Harrison, 1967, Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band).
Stavamo parlando dello spazio tra di noi. Avete presente il film Inception, quel trucco per cui ogni sogno rallenta un po’ il tempo, quindi se all’interno del sogno sogno di sognare un altro sogno, alla fine posso vivere cento anni in un istante? Within You Without You non dura cent’anni ma è come se. È un sogno di George, chitarrista della banda di Sgt Pepper, che a sua volta è un sogno di Paul.
Come tutti i brani harrisoniani del 1967, Within You è tra le canzoni più divisive dei Beatles. C’è chi all’inizio non capisce cosa ci faccia in Sgt Pepper e magari vent’anni dopo la trova l’unica cosa ascoltabile in tutto il disco, e chi fa il percorso inverso e speriamo tutti di incontrarci in qualche punto del percorso. Se Sgt Pepper è una parentesi (facciamo finta di essere un altro gruppo), Within You Without You è un inciso nella parentesi, uno spettacolo nello spettacolo: ci viene chiesto di immaginare che la Banda ceda temporaneamente il gazebo a un guru venuto dall’Oriente a predicare la vanità dell’Io.
Era stato Paul McCartney il primo a forzare il concetto di gruppo al punto da introdurre nei dischi dei Beatles veri e propri siparietti solistici, canzoni come Yesterday registrate senza contributi dei tre colleghi. A questo punto però il gioco si fa escheriano: Within You è un siparietto di George al centro di un siparietto di Paul. Se i Beatles in Sgt Pepper sono temporaneamente sospesi, Within You è il momento in cui sembrano completamente dimenticati. Concentriamoci sulle cose più importanti, ci suggerisce George, e in qualsiasi altro contesto il suo tono saccente riuscirebbe irritante, ma inserito tra due numeri di varietà come Mr Kite e When I’m 64 risulta quasi un sollievo: finalmente c’è qualcuno che sta prendendo sul serio qualcosa. Qualsiasi cosa. Within You è il risultato della collaborazione della più improbabile coppia di compositori della Ditta Beatles: Harrison e George Martin. Il primo porta tre raga cuciti assieme, da suonare su sitar e tabla; al secondo tocca l’ingrato compito di traslitterare la composizione in qualcosa di suonabile per un’orchestra occidentale, e bisogna dire che ci riesce sorprendentemente bene: certo, tutti ricordiamo Within You per il suono così ben distinguibile del sitar: ma sono i violini a creare un salto di qualità rispetto all’esperimento, già riuscito, di Love You To: non sappiamo se Harrison se ne stesse rendendo conto, ma Within You è il suo divano occidentale-orientale: un tentativo di conciliare due universi musicali che sorprende ancora oggi. Per cinque minuti George si concede una seduta di meditazione, prima di congedarsi tra le risate: nessuno è profeta in patria, che ci fa quel guru seduto su un tappeto sotto il chiosco del Sergente Pepe? Ma lo conosciamo, suo padre non guidava l’autobus? Appena un istante di silenzio, e poi riparte la banda. Tutto ok, salvo che siamo invecchiati all’improvviso. Un istante fa eravamo giovani, ora di anni ne abbiamo… 64.