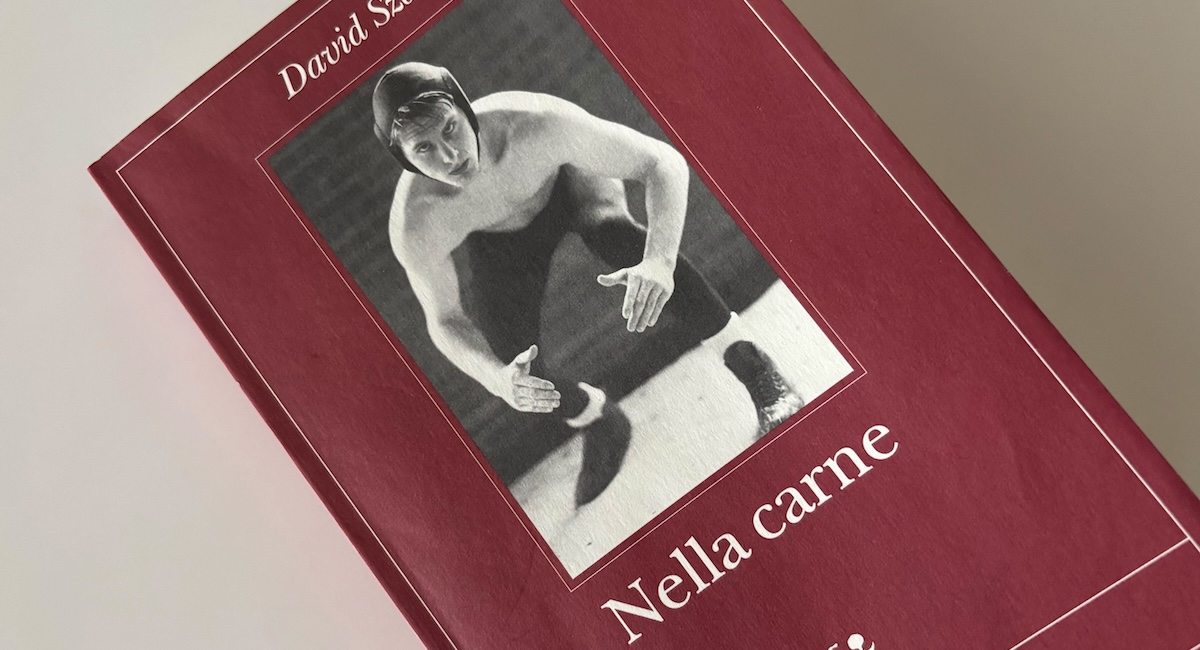“Getting so much better all the time” (Beatles, #75-66)
Cinquant’anni fa i Beatles erano ormai ufficialmente sciolti. Cinquant’anni dopo, Paul McCartney ha partecipato a una raccolta fondi suonando When the Saints Go Marchin’ In con la tromba, lo strumento con cui ha iniziato a fare musica da bambino (e che deve ancora perfezionare, diciamo). E in effetti c’è qualcosa di trombettista, a volerlo sentire, in certe sue linee di basso: quel modo un po’ bandistico in cui cerca di tenere insieme ritmo e melodia. Nel frattempo noi andiamo avanti con la classifica, ormai siamo agli sgoccioli, mancano soltanto… 75 canzoni.
Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76).
75. Golden Slumbers (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
Una volta c’era un modo di tornare a casa nel sonno. Quanto dev’essere fantastico svegliarsi nei panni di Paul McCartney, con una melodia in testa che magari è Yesterday? Quanto dev’essere angosciante svegliarsi nei panni di Paul McCartney, quando ti accorgi che è da un po’ che non ti viene nessuna melodia nuova e magari non te ne verranno mai più, è finita, avevi un dono e qualcuno te l’ha sottratto, forse sei venuto meno a una promessa come i fratelli cattivi delle fiabe, e non lo sai perché è successo dall’altra parte del sogno. E da questa parte c’è la Più Grande Band del Mondo da portare avanti, con la sua corte dei miracoli e un socio in affari che non va d’accordo nemmeno con sé stesso e la colerebbe a picco per capriccio. Se solo ci fosse un modo per tornare a casa in sogno – d’altronde, sei pur sempre nei panni di Paul McCartney. Ti basta sederti al piano di tuo papà, c’è uno spartito di una ninna nanna del Seicento, tu non hai mai voluto imparare a leggere la musica proprio perché meno ne sai, più hai spazio per inventarne: e infatti te la inventi e scrivi… la ninna nanna più assurda di tutte. Soooooogni d’or negli oooocchi tuoooooi!
Su Youtube c’è uno sketch di Sesame Street con Bocelli che canta una ninna nanna al recalcitrante pupazzo Elmo, sulle note di Partirò. Proprio quando Elmo comincia a chiudere gli occhietti, Bocelli attacca l’acuto. Ecco, Golden Slumbers fa la stessa cosa ma in questo caso è umorismo involontario, una delle tipiche incongruità di Paul. Come quando canta I’m Down ridendo a trentadue denti, o racconta la storia di un assassino seriale come se fosse una filastrocca divertente e non la è. Lennon racconta che Paul ci sapeva fare coi bambini, compreso suo figlio Julian, molto più di lui. Non c’è motivo per dubitarne ma confrontando le ninne nanne lennoniane del Disco Bianco con quella che Paul scrive per Abbey Road, non c’è dubbio su chi dei due conoscesse realmente l’esperienza di addormentare un bambino.
Con Golden Slumbers il Medley di Abbey Road muove il passo decisivo verso il finale. Se è un carosello finale – e ormai ne ha tutta l’aria – Golden Slumbers è il momento in cui entra l’orchestra, cioè George Martin. Insomma qui a congedarsi è la premiata ditta di Yesterday e Eleonor Rigby, e lo fa con un brano che ne mette in luce i pregi e i difetti: il gusto barocco si perdona volentieri, forse perché si dà dei tempi sempre più brevi. Questo a George Martin bisogna riconoscerglielo: tutte le sue pretese sinfoniche non hanno mai allungato un pezzo dei Beatles più di trenta secondi, di minutaggio ne ha sprecato molto più Lennon con l’avanguardia e col blues. Golden Slumbers può non corrispondere alla tua idea di canzone dei Beatles; McCartney che si tira fuori dal ventre un acuto da Motown in una ninna-nanna sembra l’ideale per svegliare del tutto un bambino sonnacchioso; però è appena un minuto e mezzo, non glielo vuoi lasciare a Paul un minuto e mezzo per salutare gli orchestrali? Ed è commovente, non dite di no. I bambini da addormentare li avremo sempre, ma i Beatles si sono sciolti una volta sola. Un bel peso da portarsi sulle spalle, per un bel po’ di tempo.
74. Because (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
Siccome il mondo gira, mi fa andare su di giri. La prendo un po’ lontana: una volta ho sentito dire che Abbey Road è il beatle-disco preferito da Elio. Forse anche dalle Storie Tese. (A rifletterci è ovvio, anche se non è così ovvio da spiegare). Sarà per questo motivo, la prima volta che mi è capitato di ascoltare Ignudi tra i nudisti io avevo già capito il trucco. Hanno rovesciato una canzone, ho pensato. L’ho capito perché Elio aspirava e bofonchiava proprio come i cantanti quando il nastro di una musicassetta si rovesciava; perché il bridge arrivava molto prima del solito; e la struttura in generale sembrava strana eppure in un qualche modo necessaria, come se ogni nota suonata e cantata mi stesse chiedendo di essere ascoltata in un qualche modo diverso. Ma non ci sono poi molti modi diversi di ascoltare una canzone; un’immagine si sviluppa in uno spazio bidimensionale, puoi inclinarla in vari modi; ma una canzone si muove solo nel tempo, l’unico modo di vederla in un modo diverso è invertire il senso del tempo. O forse l’ho capito al volo perché mi ricordavo che il disco beatle preferito da Elio è Abbey Road, e in Abbey Road c’è Because, e tutti a un certo punto ci siamo convinti che Because fosse nata da una sonata di Beethoven incisa al contrario… salvo che non è vero.
L’equivoco nasce da un appunto di Lewisohn: nello studio Yoko Ono esegue la sonata – dimostrando probabilmente, nell’occasione, una perizia con lo strumento superiore a quella di ciascun Beatle. John, pensoso, le chiede di suonarla al contrario. Yoko esegue, ed ecco Because. Dunque niente nastri invertiti in questo caso – l’inversione è manuale, il che ci pone altri interrogativi: cosa ha rovesciato davvero Yoko? L’ipotesi più convincente la spiega questo signore su Youtube.
Yoko dunque inverte l’arpeggio degli accordi, ma la Because vera e propria nasce soltanto quando Lennon decide di ricombinare l’arpeggio originale con quello invertito: per cui più che di un Beethoven rovesciato bisognerebbe parlare di un Beethoven specchiato e raddoppiato: ecco spiegato il mistero di Because, la sua arcana corrispondenza con una sonata di due secoli prima. Come molte soluzioni è abbastanza deludente, e ci fa rimpiangere il mistero. Perché abbiamo creduto per tanto tempo che suonando il disco al contrario ci avremmo sentito Beethoven? Perché i Beatles coi nastri invertiti erano stati i primi a giocarci, benché nel 1969 anche questo gioco li avesse stancati; e più in generale perché Because, come e più di Ignudi, si presenta con una struttura ambigua e irrisolta, e ti dà la stessa sensazione che ogni nota debba stare esattamente dove sta, ma debba essere ascoltata in una direzione diversa da quella in cui la stai ascoltando. Sei dal lato sbagliato delle cose.
Siccome il vento fischia, mi fischia la testa. Ho sentito dire che potrebbe esistere un universo parallelo dove il tempo gira nella direzione contraria alla nostra. Se con gli alieni di quell’universo potessimo vederci in conferenza su Meet, li vedremmo fare magari tutto quel che facciamo noi ma al contrario: e anche se fossimo simili o addirittura identici, non riusciremmo a capirci: all’inizio li saluteremmo dicendo “ciao” e loro ci risponderebbero “addio” perché tutto quello che ci diremo dopo loro ce l’hanno già detto. Non riusciremmo nemmeno a far loro ascoltare i Beatles, tranne forse Because, una canzone che per qualche scherzo dell’entropia faceva parte del loro universo ma è rimasta intrappolata nel nostro, come una manciata di antimateria.
Siccome il cielo è azzurro, mi fa piangere. Ha un che di lugubre, Because: è un esercizio mirabile ma freddo, astratto, e lascia un senso di insoddisfazione che il brano successivo non consola, anzi. Tutti però la trovano incantevole per via dei cori (specie da qualche anno in qua, quando è stata isolata la traccia vocale), tutti fingono di non avvertire che sono cori funebri. Il testo è composto da un trittico di giochi di parole tipicamente lennoniani che in un’altra canzone sarebbero apparsi esilaranti, e invece qui sembrano gli esercizi freddi di un dadaista di laboratorio. Poi arriva un bridge che per un attimo ti convince che la canzone potrebbe finalmente risolversi, e invece no: rimane sospesa, gelosa del suo segreto. Because di solito non viene considerata parte del medley finale di Abbey Road, eppure è un brano che fa sistema come pochi altri: le sue terzine sono una reminiscenza di Here Comes the Sun (anche se l’accordo in maggiore è passato a un minore), che a loro volta preparano l’orecchio all’arpeggio più semplice e marziale che ascoltiamo nella chiusa di You Never Give Me Your Money. Non solo: lo stile vagamente romantico la ricollega al crescendo finale di She’s So Heavy, che aveva chiuso il lato precedente. Se George Martin è il principale responsabile di un certo filone barocco nelle canzoni dei Beatles, è curioso pensare che Yoko Ono potrebbe essere l’ispiratrice del filone romantico.
73. Getting Better (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967).
I used to get mad at my school (No I can’t complain). Vent’anni fa, quando finalmente uscirono le prime rilevazioni statistiche sulla qualità dell’educazione in Europa, scoprimmo con una certa sorpresa che il metodo educativo migliore era quello… finlandese. Sul serio, non se l’aspettava nessuno. Del resto è per questo che esistono le rilevazioni statistiche, no? Per farci scoprire cose che non ci saremmo mai immaginati. E quindi, cosa aveva di così innovativo la scuola finlandese? Non lo sapevano nemmeno i finlandesi, che peraltro in quel periodo stavano cambiando metodo, abolendo le classi statiche, le lezioni frontali, ecc.. Addirittura smisero di addestrarsi ai test – e sì che erano diventati un modello per il mondo proprio perché i loro studenti erano stati i migliori a fare i test. In effetti da lì in poi sono sempre peggiorati nelle rilevazioni. Non importa, ormai abbiamo deciso che sono i migliori del mondo e continuiamo a invidiarli e cercare (malamente) di copiarli, anche perché abbiamo il sospetto che nelle loro scuole ci si diverta molto. E dunque anche noi stiamo mettendo in discussione le classi statiche, le lezioni frontali, ecc.. E peggioriamo anche noi, più rapidamente dei finlandesi (anche perché partivamo già più in basso). A un certo punto a qualcuno è venuto il sospetto: ma vuoi vedere che in realtà è tutto un equivoco? Che i finlandesi siano diventati un modello non per la scuola che stavano inventando in quel momento, ma per quella che avevano prima, quella con le classi statiche e le lezioni frontali e i professori esigenti e gli studenti suicidi? E se è così, vale proprio la pena di dirlo in giro?
I Beatles, fino al 1967, rappresentavano tutto ciò che c’era di nuovo e di migliore nella prima generazione postbellica. Con tutta la loro svergognata esibizione di talento allo stato brado, a Lennon e McCartney bastava scuotere le chiome in tv per avvertire che l’epoca del rigore era finita, che le vecchie scuole non servivano più a nulla, che gli insegnanti che “ci riempivano di regole” avevano i giorni contati. E in effetti è proprio così. Ma i Beatles quelle scuole le avevano pur fatte… E oggi che ogni briciolo di talento in ciascun alunno è vezzeggiato dall’asilo nido fino alla maturità, oggi che l’idea di restare attenti a una lezione per più di trenta minuti è vista come un abuso di potere, e ogni lezione dovrebbe essere gamificata: oggi ne saltano fuori dalle nostre scuole dei talenti come Lennon e McCartney? Apparentemente no. Ma forse è solo un bias.
Me used to be angry young man. I bias (vorrei tanto che si potesse chiamarli ancora “pregiudizi”) sono “pattern sistematici di deviazione dalla norma o dalla razionalità nel giudizio”. Uno dei più importanti è il bias del sopravvissuto, e ne soffrono tutti quelli che vogliono diventare youtuber o influencer (compresi molti youtuber o influencer). Ai miei tempi ne soffriva chiunque mettesse in piedi una rock’n’roll band. Insomma, il pregiudizio che perturba la razionalità del nostro giudizio è che vediamo un sacco di gente che ce la fa. Partono da zero e diventano uomini o donne di successo, ai miei tempi diventavano anche dei divi del rock, persino in Italia ne abbiamo avuti tre o quattro che hanno fatto soldi seri. Se tutta quella gente ce le fa, perché non dovremmo farcela anche noi? Perché siamo dei poveri illusi e facciamo caso soltanto a quell’uno su un milione che ce la fa: non ai 999.999 che ricadono a terra malamente.
Quel che è terribile è che anche l’Uno su un milione talvolta soffre dello stesso pregiudizio/bias, ovvero pensa: beh, se ce l’ho fatta io non doveva essere così difficile. E quindi sceglie di ridiscendere tra i suoi simili nelle vesti insopportabili dell’ottimista programmatico, il ragazzo fortunato che invita tutti a “credere nei loro sogni”, perché più ci credi più si avverano. È un pattern sistematico di deviazione dalla norma che lo trasforma in un maledetto irresponsabile che manda poveri falliti a sbattere contro il muro della Realtà. I più altruisti creano etichette, sindacati di artisti, enormi bolle di talento inutile che creano effetti indubbiamente artistici quando esplodono. Poi la gente scrive che ce l’ho con Paul McCartney ma è il contrario, provo una sincera pena per lui, per la generosa speranza con cui fondò l’Apple e per come la vide marcire e cadere. Qualcun altro dopo aver sognato la melodia di Yesterday si sarebbe convinto di essere un genio sovrumano, lui tutto il contrario: da bravo babyboomer, era convinto che quel genio ce l’avessero tutti, e che bastava snidarglielo. In fondo fino a quel momento stava andando tutto bene. Stava andando sempre meglio. Tutto sempre meglio, tutto il tempo.
I Beatles sono l’equivalente musicale del bias del sopravvissuto. Li ascoltiamo, li guardiamo e pensiamo: di gruppi così non ne possono esistere più. Vediamo solo loro, non tutti quelli che ci hanno provato nello stesso momento e per qualsiasi motivo non ce l’hanno fatta. Viste le premesse era quasi fatale che dovessero diventare gli alfieri di quell’ottimismo moderatamente socialdemocratico che fino a quel momento animava la società europea e americana degli anni Sessanta. Rilassati, divertiti, sta migliorando tutto. Getting Better è il secondo sguardo all’indietro di Sgt Pepper, dopo With a Little Help (da cui riaffiora lo stesso quattro quarti martellante, una soluzione ritmica platealmente reazionaria rispetto a quelle proposte nel primo brano e in Lucy). Dopo i colori acidi di Lucy, è un ritorno al bianco e nero – te l’immagini suonata dai quattro manichini neri di Madame Tussaud, più che dai loro avatar in carne ossa dai costumi sgargianti. Cosa sarebbe successo ai Beatles se dopo Revolver si fossero detti: torniamo indietro? Siamo solo un gruppo pop-rock con un seguito di ragazze che stanno crescendo e vogliono cominciare ad ascoltare brani cantati da fidanzati ideali con la testa sulle spalle? “Sto facendo del mio meglio, e devo ammettere che sono diventato una persona migliore da quando tu sei mia”. Avrebbero potuto accontentarsi di essere questo, i Beatles? Forse sì.
Tranne uno.
I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Così, a secco, senza neanche avvertire – la musica cambia appena un po’, si percepisce una vibrazione sinistra che forse è un sitar, e nel bel mezzo del pezzo più pop di un disco pop, un beatle ci informa che era abituato a picchiare la sua donna. E quel beatle, anche se si nasconde dietro la voce serena di Paul, è evidentemente John Lennon. Perché scegliere proprio l’inno alle magnifiche sorti e progressive, per ricordare a tutti di essere un mostro geloso? Perché forse è finita – la stessa Cynthia conferma che l’ingestione quotidiana di LSD aveva posto fine alle violenze domestiche, non ditelo ai servizi sociali. Ma insomma la vita sta migliorando anche per John, e del resto “più di tanto non può peggiorare” (It can’t get much worse). Scegliete voi cosa vi irrita di più: il vittimismo esistenziale del milionario John che anche quando si concedeva le sostanze migliori sul mercato continuava a cantare “sono solo ho voglia di morire”, o l’ottimismo programmatico di Paul che porterà i Beatles a sfracellarsi commercialmente contro quel monumento alle velleità di una generazione che fu l’Apple Corps. Alla fine è impossibile non compatirli entrambi, in fondo erano due orfani che avevano vinto alla lotteria il ruolo di eroi di una generazione. Non è sorprendente che abbiano buttato via tanti e soldi (e anche molto talento). È incredibile che siano riusciti a resistere per così tanto tempo. E per così tanto tempo, a migliorare. Getting so much better all the time.
72. Yer Blues (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Esatto, sono solo e voglio morire. Ma mettetevi un attimo nei Rolling Stones. Nascete suonando blues nell’indifferenza generale, finché qualcuno non ha la pensata di promuovervi come i rivali dei Beatles. L’idea frutta immediata visibilità, ma vi condanna anche a un confronto schiacciante, perché i Beatles non stanno fermi un attimo e anche a voi ora viene richiesta la stessa cosa, un attimo prima eravate un gruppo di blues inglese che cominciava a suonare credibile e un attimo dopo eccovi a strimpellare strumenti rinascimentali e bonghi, ma sempre tenendo un occhio a quello che fa la concorrenza, sempre con l’affanno di inseguire chi è partito prima e non deve imitare nessuno. Finché non ce la fate più – anche perché lo showbiz vi mangia vivi e la polizia non ha con le vostre consuetudini scapestrate la stessa tolleranza che ha coi quattro Membri dell’Ordine Britannico. Arriva il punto in cui più che il lato oscuro dei Beatles ne sembrate diventati la parodia. L’accoglienza tiepida riservata a Their Satanic Majestic Request muove Jagger e Richards a un ripensamento: basta andare a rimorchio, ritroviamo la nostra identità. Eravamo un gruppo blues, rimettiamoci a suonare il blues. Ottima idea. Probabilmente è quella che ha salvato gli Stones, diciamo per quattro quinti. A dicembre esce un ottimo album, Beggars Banquet – proprio nei giorni in cui il Disco Bianco trionfa nelle radio di tutto il mondo, ma che importa? Non è più una gara, ognuno faccia quel che sa fare: e non c’è dubbio che ormai gli Stones sappiano fare un ottimo blues. Per promuovere il disco hanno un’idea: uno special natalizio per la televisione, proprio come il Magical Mystery beatlesiano dell’anno prima, ma meno immaginifico: un concerto ambientato in un circo, con Mick Jagger vestito da impresario. Ottima idea. E si possono anche invitare gli amici: gli Who, i Jethro Tull (con Tony Iommi!), Taj Mahal, e John Lennon, sì, dice che viene se può portare Yoko Ono. Lo accompagnano Eric Clapton (i Cream si sono già sciolti) e il grandissimo batterista dei Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell. Un bassista non c’è, ma si presta Keith Richards. È la prima volta in assoluto che Lennon suona in pubblico senza in un gruppo che non siano i Beatles. E cosa suona? Yer Blues, dal disco appena uscito. Dopodiché?
Dopodiché suonano anche gli Stones, ma non ha molta importanza. Il Rock’n’Roll Circus non verrà mai programmato, saranno gli stessi Stones ad accantonarlo. Non erano soddisfatti della loro prestazione, avrebbero voluto lavorarci un po’, ma poi succedono altre cose. Brian Jones (che si aggirava sotto il tendone già in evidente stato confusionale) viene licenziato e muore poco dopo. Se il Circus è rimasto inedito fino al 1995, girl… you know the reason why. Dopo essere andati vanamente all’inseguimento dei Beatles per tre anni, tre anni in cui dischi ottimi avevano comunque perso la sfida con Revolver e con Sgt Pepper, gli Stones avevano deciso di concentrarsi su quello che sapevano fare meglio: sul rock e sul blues. Ottima idea: poi però arriva in casa John Lennon con la fidanzata matta e due amici, sale sul palco, suona un solo blues e li stende. Non c’è giustizia a questo mondo.
Il gruppo improvvisato in quel pomeriggio si chiamava “Dirty Mac” (“Vecchio sporcaccione”), uno sberleffo all’ultima novità del blues inglese, i Fleetwood Mac di Peter Green appena sbarcati in classifica con Black Magic Woman. Prima di far entrare Yoko fa in tempo a suonare un pezzo solo, ma quel pezzo è Yer Blues, e non c’è gara. Non c’è gara coi Fleetwood Mac e non c’è gara coi Rolling Stones. (Gli unici a non impallidire sono gli Who, ma loro non fanno blues, ormai sono un genere a parte). Nel 1968 lo stato dell’arte del blues inglese è un pezzo dei Beatles – ma com’è possibile? Che siano sempre i migliori, anche quando sono in crisi, anche quando perdono un manager e una direzione artistica? Possibile che a John Lennon in ritiro indiano basti pensare “adesso faccio un blues” per alzare di colpo il livello di tutta la scena? Pure è così.
Anche se magari non sembra. Yer Blues non è invecchiata bene come altri brani del Bianco. In un disco pieno di pastiche in effetti c’è il grosso rischio di non prenderla sul serio. Per Lewisohn è una parodia del blues inglese del periodo. Potrebbe anche darsi – bisognerebbe ascoltare il blues inglese del periodo. I Fleetwood Mac, senz’altro, e ovviamente i Cream, gli Yardbirds di Jeff Beck e Jimmy Page e anche gli Stones di Beggars Banquet. Ecco, chissà se Lennon si è dato pena di ascoltarli. Magari nemmeno. Gli basta intonare “Yes I’m lonely wanna die” per far sembrare tutta la scena una platea di poser. O sciocchi, cosa pensate che sia il blues? un rock’n’roll per esperti, per filologi, per virtuosi della scala pentatonica? Non avete capito niente e non perderò tempo a spiegarvelo. Il blues è disperazione e voglia di morire, il blues è un urlo primordiale. E se non sono già morto, non è grazie al vostro soul di plastica. Nei quattro minuti di Yer Blues Lennon accelera, rallenta, inserisce fraseggi tipici nei posti sbagliati, un assolo di due-note-due, si permette insomma tutte le libertà che un purista inglese del blues nel 1968 avrebbe esecrato: e il risultato è il pezzo più robertjohnsoniano mai inciso in Inghilterra. Non hai bisogno di maestri per suonare il blues (l’unico che Lennon riconosce è il Dylan di Ballad of a Thin Man): basta aver voglia di morire, e John “si sente suicidiario come il mr Jones di Dylan”.
Yer Blues va presa sul serio. Fa parte di quel mazzo di brani del Disco Bianco che attestano un precoce desiderio di ritorno alle origini; viene incisa dal vivo, in uno sgabuzzino, da quattro musicisti che vogliono tornare a guardarsi in faccia mentre suonano. I cambi di tempo che Lennon non era riuscito a chiarire con sé stesso nel demo, Ringo e Paul li afferrano al volo (e Richards Clapton e Mitchelli li riprodurranno fedelmente, segno la Yer Blues del Disco Bianco era proprio come Lennon la voleva). Per quattro minuti i Beatles partecipano al Blues Boom del 1968 e riportano tutto a casa. Per ascoltare un blues inglese altrettanto viscerale e disperato bisognerà aspettare un annetto – il tempo necessario a Jimmy Page per rilevare gli Yardbirds e ribattezzarli Led Zeppelin: il gruppo che nei primi anni Settanta venderà più dischi di tutti, ma soprattutto più dischi dei Rolling Stones.
Yer Blues è invecchiata peggio di altri brani del Bianco perché, in effetti, è l’anteprima di quello che diventerà il marchio di fabbrica dei primi LZ: un nuovo genere di blues, ritmicamente imprevedibile, melodrammatico e urlato, sofferto e sanguinante. È abbastanza clamoroso che i pionieri del genere non fossero gli Yardbirds o i Cream o i Fleetwood, ma gli autori e interpreti di Obladì Obladà.
71. I’m Down (Lennon-McCartney, lato B del singolo Help!, 1965).
“Plastic soul man, plastic soul”. Cosa intendeva Paul con questo commento finale alla take 1 (si sente in Anthology 2)? Non è chiaro, ma all’inizio del brano aveva affettato un accento americano per esprimere un desiderio: “let’s hope this one turns out pretty darn good, huh?” I due commenti racchiudono il brano come due parentesi, o forse due virgolette. Come se Paul pensasse ad I’m Down più come a una performance che a una canzone. All’inizio c’è un misterioso americano che dice: speriamo che funzioni. E alla fine, lo stesso americano scuote la testa, anche se in una direzione ambigua: cosa vuol dire davvero “plastic soul”?
Oggi diamo per scontato che la plastica sia il materiale “finto” per eccellenza, quello che può prendere tutte le forme senza averne nessuna in natura – ma nel 1965 la plastica era ancora qualcosa di entusiasmante che stava migliorando la vita a milioni di persone. Un soul di plastica è necessariamente un soul finto? O piuttosto un soul malleabile, capace di plasmarsi a piacere? I’m Down fu registrata 55 anni fa, in uno dei giorni più interessanti della storia della musica, per via che durante le stesse sessioni Paul registrò anche Yesterday e I’ve Just Seen a Face. Tre canzoni così diverse, e tutte e tre così felici. Yesterday è dal primo istante uno standard confidenziale, I’ve Just Seen un post-skiffle irresistibile che Paul si sarebbe portato con sé anche nelle esibizioni live dei Wings, e quanto ad I’m Down… beh, era una mossa quasi obbligata. Persino tardiva. Da sempre i Beatles chiudevano le loro esibizioni con un pezzo urlato, che mandasse a casa il pubblico col sorriso sulle labbra e la voglia di rivederli al più presto. Il più famoso è Twist and Shout, ma molto più spesso avevano usato Long Tall Sally. Sempre cover, in ogni caso: non avevano mai tentato di scrivere un brano così. Finché nel 1965 Paul rompe gli indugi e scrive I’m Down. È anche un modo per inserire nella scaletta dei concerti un brano in più della ditta Lennon/McCartney: ma perché non ci avevano pensato prima? Cosa li tratteneva? È come se urlare una propria canzone non fosse facile come urlare una canzone di qualcun altro. Paul non può più nascondersi in Little Richard: deve essere sé stesso, ma chi è davvero?
Un ragazzo fortunato. Ci sono canzoni performative: Here Comes the Sun è un mattino di sole anche se fuori piove. Help! è davvero un grido di aiuto. I’m Down è esattamente il contrario: la più smaccata bugia mai raccontata da un cantante al microfono. Paul non è mai “down”, anzi non è mai stato così felice. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di vedere i filmati delle esibizioni al Sullivan Show o allo Shea Stadium, dove ridono tutti come matti e John si cimenta nel suo assolo di organo Vox col gomito; o quella in Germania dove Paul si ricorda come ringraziare il pubblico in tedesco e poi dimentica le parole della sua stessa canzone, un bel lapsus. Perché assegnare a una canzone così divertente un testo brontolone come I’m Down? Non c’è un vero perché, a volte le canzoni nascono con le prime frasi che ti vengono in mente, e quando provi a cambiarle non trovi niente di meglio. Due sono gli argomenti che non tradiscono mai il paroliere: l’amore e il sentirsi giù, (gli americani lo chiamano “blues”). Non c’è bisogno di inventare niente, le frasi sono già pronte all’uso con le rime già pronte. Del resto non ha la minima importanza: come in Dizzy Miss Lizzy, come in Long Tall Sally, come in Twist and Shout, le parole sono solo un pretesto per urlare. E tuttavia vedere John e George ridersi in faccia mentre si dividono il microfono cantando “I’m down” sembra quasi una presa di posizione. Siamo i Beatles, nessuno ci prenda sul serio. Produciamo oggetti di plastica, i dischi questo sono. Ricicliamo il blues e il rock’n’roll e lo trasformiamo in canzoncine ridanciane, ed è divertente. La cosa vi scandalizza? Ce ne faremo una ragione. Ma sul serio: come potete deprimervi, mentre noi ridiamo?
70. Twist and Shout (Bert Berns – Phil Medley; incisa dai Beatles in Please Please Me, 1963).
Torciti e urla. E se dopo aver inciso il primo disco avessero preso anche loro l’aereo sbagliato, quel tipo di aereo che nel 1959 avevano preso Buddy Holly e Ritchie Valens? Ci ricorderemmo ancora di quel simpatico quartetto protagonista di un breve revival inglese del rock’n’roll, i Beatles? Forse no: per rimanere nel Libro devi diventare grande in America, il che sarebbe successo solo qualche settimana dopo. O forse sì, perché per passare alla Storia a volte basta un pezzo solo: pensa ai Trashmen! (chi?) Ma come chi, quelli di Surfin’ Bird. O i Kingsmen, (chi?) quelli che registrarono Louie Louie così male che la gente ci sentiva dentro qualsiasi cosaccia le dettasse l’immaginazione e la FBI aprì un’inchiesta, storia vera. O a Chubby Checker di cui nessuno saprebbe citare tre pezzi in fila, ma almeno due twist li conoscono tutti. O Ritchie Valens, che quell’aereo lo prese davvero (aveva solo 17 anni!), ma aveva fatto in tempo a incidere La Bamba, e tanto ci basta. Anche perché Twist and Shout altro non è che la Bamba formato twist, scritta da due autori (Bert Berns e Phil Medley) che volevano proprio mettere insieme le due cose, ma poi passata a Phil Spector che immancabilmente insieme alle due cose voleva infilarcene tantissime altre, sicché la Twist and Shout dei Top Notes, la prima in assoluto (1961), sembra già un cross-over, una parodia. Ma Berns non si diede per vinto e alla fine riuscì a farla incidere come l’aveva in mente a un terzetto di reduci del twist, gli Isley Brothers.
Dopodiché forse Twist and Shout esiste già in natura, in fin dei conti cosa c’è di più naturale della progressione I-IV-V, cosa suona più spontaneo all’orecchio umano di un passaggio dal primo accordo al quinto, magari con una breve sosta al quarto per creare un po’ di tensione? E però prima che Valens portasse La Bamba alla radio, l’idea non era venuta a nessuno e anche dopo ci mise un po’ ad attecchire: gli Isley Brothers con la loro Twist and Shout rividero la Top40, e forse tutto sarebbe finito lì se un anno dopo un John Lennon rauco e febbricitante non avesse deciso di terminare le 15 ore di session del suo primo album riprendendo Twist and Shout con la stessa violenza autolesionista con cui la sparava contro le basse volute di mattoni del Cavern Club. Se avesse inciso anche soltanto quel pezzo, John Lennon sarebbe… uno sconosciuto, dal nome oscuro quanto quello dei cantanti che coverizzarono Bird is the World o Louie Louie. Ma quella voce, la sua voce avrebbe fatto il giro del mondo, e lui forse sarebbe impazzito dall’imbarazzo perché c’è qualcosa di osceno in quella voce, e lui non scherzava quando affermava di odiarla.
Twist and Shout avrebbe reso qualsiasi gruppo di sconosciuti una one-hit-wonder e forse avrebbe avuto più senso così, in fondo è quel che resta di un brano tradizionale messicano infilato da un autore professionista in uno stampino commerciale già esausto (il twist), poi ripreso nel quartiere a luci rosse di Amburgo da un oscuro gruppo di rocker inglesi dalla tonsille devastate dalla nicotina, trasformato in uno sguaiato inno alla dissoluzione che porta finalmente il rock’n’roll in un nuovo decennio. Il felpato professionismo dei vocalist americani viene riletto da un mancato mozzo di Liverpool che canta ogni verso come fosse l’ultimo senza sapere se riuscirà ad arrivare alla nota più alta – in effetti non è che ci arrivi realmente, la sua blue note non è un ammiccamento, è uno sforzo disperato di un chitarrista che torce le corde vocali come fossero corde della sua chitarra. Quel mancato mozzo e i suoi colleghi sciamannati diventeranno poi la band più famosa del mondo, scrivendo e cantando brani diversissimi ma tutti più complicati di Twist and Shout: però alla fine anche solo Twist and Shout ci sarebbe bastata. Non voglio dire che sia il più grande brano del rock, ma l’ultima volta che ho controllato il più grande brano del rock aveva come ritornello una versione un po’ più lenta e rantolante di Twist and Shout. Tutto grazie a Lennon. E a Bert Burns. E a Valens (e non a Phil Spector).
69. Two of Us, Lennon-McCartney, Let It Be, 1970).
We’re on our way home. We’re going home. Potenza del contesto. Registrata da qualsiasi altro artista in qualsiasi altro disco, Two of Us probabilmente non mi avrebbe detto un granché. Inserita da Lennon e McCartney all’inizio del loro disco postumo, Two of Us mi commuove. Non importa aver letto dappertutto che i “due di noi” erano Paul e Linda in gita in campagna. Nella mia testa i due vagabondi in impermeabile che scrivono cartoline accostandole ai muri non possono che essere Paul e John. Hanno ricordi più intricati della strada che hanno percorso, stanno tornando a casa da qualcosa che dalla distanza sembra una guerra. Comunque è finita, il nemico è battuto, non c’è più bisogno di litigare. Stanno tornando a casa e sarebbe bello se ci tornassero assieme. Sappiamo che non è così ma per un attimo vogliamo crederci. La storia dei Beatles è la storia di un’amicizia: è questo che la rende struggente e ci fa tornare sempre sul luogo del misfatto, anche se sappiamo come va a finire. Si può assistere a Romeo e Giulietta per cento volte e maledire ugualmente quel frate che si attarda con un messaggio importantissimo nella borsa: si può ascoltare Two of Us cento volte e continuare a domandarsi: perché non avete fatto la pace quando eravate ancora in tempo?
Paul nel periodo di Let It Be è sospeso tra tentazioni quasi jazzistiche e un impulso a semplificare gli arrangiamenti – anche per ridurre al minimo le discussioni coi colleghi coinvolti in un delicatissimo divorzio a quattro. Two of Us cattura questa tensione: una canzoncina apparentemente facile, suonata alla buona, con un bridge che all’improvviso si impenna – un improvviso sussulto di orgoglio, che rientra subito nei ranghi. Ma alla fine è la cosa migliore del brano, ed è anche quella a cui John dedicò più impegno, perché armonizzare sulla “strada che si allunga là fuori” gli costava effettivamente fatica ma almeno era una sfida. Potenza del contesto: Two of Us cattura la dolcezza dell’incontrare un vecchio amico con cui hai litigato ma gli vuoi comunque bene ma ci hai pur sempre litigato. Ma se l’avesse incisa qualcun altro, in qualsiasi altro disco, non ci avrei mai fatto caso.
(Nella versione di Let It Be Naked, mi pare che McCartney si limiti a tagliare la presentazione sardonica di John: “I Dig a Pygmy‘, di Charles Hawtrey e the Deaf Aids … Prima parte, in cui Doris si procura la carota”. Un’ottima idea: la frase in questione non era riferita alla canzone, ma era una delle sciocchezze che Lennon lanciava al microfono nelle pause sigaretta; Phil Spector probabilmente voleva suggerire l’idea di una registrazione estemporanea, ma introdurre la prima canzone che parla sicuramente di Linda con il greve doppiosenso di “Doris gets her oats” era un bel colpo sotto la cintura).
68. Lady Madonna (Lennon-McCartney, singolo del febbraio 1968).
See how they run, come corrono, ‘sti ragazzi. Che cosa ci si aspettava dai Beatles all’inizio dell’anno di grazia 1968? Che continuassero a essere la più grande band del mondo, apprezzata da grandi e piccini; però anche innovativi, come erano sempre stati e certo non potevano smettere di esserlo proprio ora. D’altro canto dopo alcune sbandate situazioniste e psichedeliche sarebbe stato apprezzato anche un certo ritorno all’ordine, al rock’n’roll; però sempre garbato, per le urla sguaiate c’erano già Stones e Who. In vista della rivoluzione un po’ di realismo sociale non avrebbe guastato, sempre condito da quell’ottimismo che era indelebilmente associato alla loro immagine pubblica. Ci si aspettava tutto questo dai Beatles, all’inizio del 1968: e Paul McCartney, infallibilmente, lo consegnò entro la scadenza: giusto in tempo per accompagnare in India chi andava alla ricerca di sé stesso.
Sul serio: non c’è nessuna promessa che i Beatles avessero fatto fin qui che Lady Madonna non mantenga, e te lo fa pure sembrare facile. È un pezzo allegro, ma il testo a pensarci bene è triste (ed è anche uno dei più riusciti testi di Paul, il migliore dei suoi bozzetti liverpooliani). È un ritorno al sano e vecchio rock’n’roll, o almeno così fu considerato dai critici che non sapevano bene cosa pensarne; c’era in effetti nell’aria una certa sensazione di stanchezza per le follie del ’67. Il disco psichedelico degli Stones aveva lasciato tutti perplessi, Bob Dylan aveva appena pubblicato un disco spogliato all’osso ed enigmatico come John Wesley Harding. Ma a dire il vero Lady Madonna non rappresenta nessuna inversione di rotta, anzi chiarisce sempre di più la vocazione di Paul e soci per il pastiche, il numero in costume: quindi sì, c’è un bel rock pianistico alla Fats Domino nella strofa, ma il bridge si sposta sui territori swing che Paul ha iniziato a esplorare con When I’m 64, per impennare sul finale (“See how they run”) con un ricordo di quei cori barocchi che erano un marchio di fabbrica della casa dai tempi di Paperback Writer. Anche l’arrangiamento sembra voler tenere i piedi in due scarpe, professionismo e giocoleria: Paul convocherà una sezione di ottoni ma non offrirà loro nessuno spartito da suonare: non solo, ma lui e gli altri ragazzacci si metteranno a scimmiottare gli ottoni in sordina con le voci in falsetto. A un certo punto un sassofonista esasperato produrrà un assolo free che si accompagna perfettamente all’allegra concitazione raccontata dal testo. Non solo Lady Madonna è in perfetta continuità con le trovate di scena e il bozzettismo di Sgt Pepper, ma dimostra che rispetto a Sgt Pepper le idee sono persino più chiare, gli arrangiamenti più nitidi, Paul più ispirato. Tutto quello che ci si aspettava dai Beatles, Lady Madonna lo forniva in due minuti e mezzo: di fronte a questa strabiliante dimostrazione di superiorità offerta da un Paul McCartney che aveva appena incassato il fiasco televisivo del Magical Mystery Tour, come reagì il pubblico?
Tiepidamente.
Oddio, il disco lo comprarono – però non arrivò mai al primo posto nella classifica americana, un caso abbastanza raro per i Beatles. Non aiutava il Lato B – The Inner Light, la composizione indiana meno compromissoria di George Harrison. Fu in assoluto il singolo meno lennoniano della storia dei Beatles – insoddisfatto dalla resa di Across the Universe, John aveva fatto un grande passo indietro. Ma insomma il relativo insuccesso di Lady Madonna dimostrava quello che i Beatles già prima di partire per l’India sapevano: non si poteva fare meglio di così. I Beatles avevano abituato il loro pubblico a un livello di qualità e innovazione impossibile da garantire ancora a lungo. Ormai ci si aspettava da loro con cadenza semestrale un capolavoro o un cambio di paradigma, o entrambe le cose insieme. Lady Madonna è uno dei brani dei Beatles che più si avvicina all’antico concetto di standard, quelle canzoni che conosci da sempre e puoi ascoltare tutti i giorni senza stancartene. Pur mantenendo un’impronta visibile del loro autore, gli standard possono essere rifatti da qualsiasi interprete e non tradiscono mai. Persino Fats Domino incise Lady Madonna, visto che tutti dicevano che sembrava un pezzo suo. Ne fece una buona versione in cui non cambiava praticamente nulla: il più grande complimento che Fats potesse fare a Paul McCartney. Ma sul serio, cosa puoi cambiare in Lady Madonna? Per Lennon era un pezzo “che non andava da nessuna parte”. In un certo senso è vero: non c’era più nessuna parte dove andare, Lady Madonna si limita a mantenere la posizione. La gente si aspettava qualcosa di più, ma cosa?
67. Carry That Weight (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969)
Oh boy, questo peso te lo porterai addosso per un bel po’ di tempo. Qualche settimana dopo, quando John Lennon manifestò l’intenzione di lasciare dal gruppo, disse, testuale: “voglio un divorzio”. Se ci pensate, è terribile – qualsiasi divorzio lo è. Un matrimonio può finire, capita ai migliori. Ma un divorzio è per sempre. Ti segna la vita: non puoi smettere di essere divorziato: c’è un prima e c’è un dopo. E non capita a tutti – sposarsi, quello sì è alla portata di tutti. Sposarsi ti rende simile a chiunque altro, ma divorziare, quando capita, è come se capitasse solo a voi. Dovrete conviverci per tanto, tanto tempo. E dire che Paul ci aveva appena promesso di cantarci una ninna nanna. Invece, senza preavviso, parte un coro da stadio – la voce di Ringo è in evidenza, il ricordo di Yellow Submarine si inserisce subliminalmente, insieme a un presagio: questa cosa ce la porteremo addosso a lungo. E così siamo agli sgoccioli, e queste patetiche carte che ci stanno allontanando, queste ripicche da ragazzi, queste scemenze da avvocati sono il casus belli che ci dividerà per sempre, qualcosa per cui tutto il mondo ci rimprovererà finché campiamo, e alcuni di noi camperanno a lungo (per una macabra coincidenza, sono i due che cantano il coro).
Per tutte le volte che lo abbiamo accusato di inventarsi storie inutili, bisogna riconoscergli che nel momento in cui qualcuno doveva raccontare l’episodio più doloroso, è stato proprio Paul a non tirarsi indietro. E solo Paul del resto avrebbe potuto riuscirci – tutta l’esperienza maturata con le sue canzoni del disamore, alla fine gli ha permesso di realizzare con You Never Give Me Your Money e Carry That Weight un dittico di sincerità disarmante.
66. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Lennon-McCartney, nell’album omonimo, 1967)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
È successo vent’anni fa oggi. Ci sono cose quasi impossibili da catturare con una macchina fotografica, o un registratore, o una videocamera. Per esempio, il momento in cui cresciamo – impossibile, cresciamo troppo lentamente. La nostra prima nostalgia, il primo caso in cui ci voltiamo indietro: salvo che quando l’abbiamo vissuto non ce ne rendevamo conto, che era il primo. Oppure: il momento in cui nasce una moda. Il problema è che non nascono mai veramente, è tutto un perenne divenire. Londra, che a metà anni ’60 era diventata il punto di riferimento della moda giovanile, tra 1966 e 1967 impose un brusco cambiamento di rotta, deciso non si sa bene da chi – probabilmente nessuno. In ogni caso, nel giro di qualche mese si passò da uno stile modernista, ispirato dalla corsa allo spazio e dalla op art, a un improvviso interesse per la chincaglieria del passato – all’improvviso Portobello invase Carnaby Street. Il perché non è chiaro e non è chiaro neanche il percome: la storia della moda procede un po’ per narrazioni orali, poi ogni tanto qualcuno fa una mostra retrospettiva e una serie di collezioni, messe in fila, sembrano assumere un significato. Ma non è come la storia della musica, in cui almeno sai quali dischi hanno venduto e quali ti tiravano dietro: nella moda è tutto un successo fino a prova contraria e le prove nessuno le ha. Alla fine forse l’istantanea più affidabile di quel particolare momento è proprio quella scattata dai Beatles all’inizio del loro disco più ambizioso e colorato – pochi mesi prima, l’elegante Revolver si era concluso con il brano più avantgarde mai inciso dai Quattro, Tomorrow Never Knows. Il disco nuovo si presenta diversissimo già dalla copertina, eccessivamente variopinta: i Beatles non sono più gli unici protagonisti, anzi non sono mai stati così piccoli, vestiti da buffoni e circondati da un gruppo di celebrità intergenerazionale; come se il mondo degli adulti finalmente si fosse degnato di accoglierli. Quanto alla musica, beh – il primo brano sembra un rock piuttosto duro per il 1967, in linea con quanto suggeriva già Revolver nell’anno precedente. McCartney canta con la tipica foga little-richardiana su una nota sola: oggi non avremmo difficoltà a considerarlo un rap. È un suono brutalista e moderno: racchiude l’energia ribelle di una generazione e… dura sedici battute.
Poi partono gli ottoni.
Un pubblico finto reagisce con stupore; poi si mette a ridere. Ma è un disco o un musical? È come se i Beatles crescessero in quell’esatto momento: un istante impossibile da fermare sulla pellicola o sul nastro. Tutto quello che era importante un attimo prima… non lo è più. Molto altro bolle in pentola, avremo una sezione di ottoni e tanti numeri in costume. Sì, eravamo la rock band più importante del mondo, l’anno scorso. Adesso siamo qualcosa di nuovo, ma anche di vecchio. Qualcosa che comunque vi piacerà, sedetevi e godetevi lo show.
Succede tutto in pochi secondi. Il brano, a dire il vero, dopo l’inserto di ottoni continua a rockeggiare come se niente fosse. Invece è cambiato tutto, quello che nel 1966 era avanguardia ora è solo una posa fra tante. Nei negozi è arrivata roba nuova – che in realtà a guardare bene è roba vecchia, buffe giacche e vestiti di vent’anni fa. La guerra era appena finita, papà McCartney suonava vecchi standard jazz al pianoforte, mamma Lennon strimpellava il banjo, il Sergente Pepper insegnava alla sua banda a suonare. Possibile che nel 1967, mentre compitava parole a caso per il nuovo disco, Paul McCartney conoscesse già la Regola dei Vent’anni, quel teorema del consumo per cui nel momento in cui ogni generazione comincia a guardarsi indietro, il punto in cui si fissa è situato di solito vent’anni prima? Fino a poco prima forse guardarsi indietro non conveniva: c’era la guerra, razionamenti e bombardamenti. Nel 1967 all’improvviso è come se si aprissero gli archivi: tutto il passato diventa riciclabile, ricolorabile, interessante. La parola “postmoderno” è ancora un tecnicismo accademico: i Beatles non sono stati ancora informati ma sono già i più postmoderni di tutti. C’è però un prezzo da pagare; il nuovo disco sarà pieno di musica di ogni genere, ma il rock per ora è sospeso: confinato nel brano di esordio e nella ripresa sul secondo lato. Come se fosse un genere ancora troppo moderno per essere rivisitato.