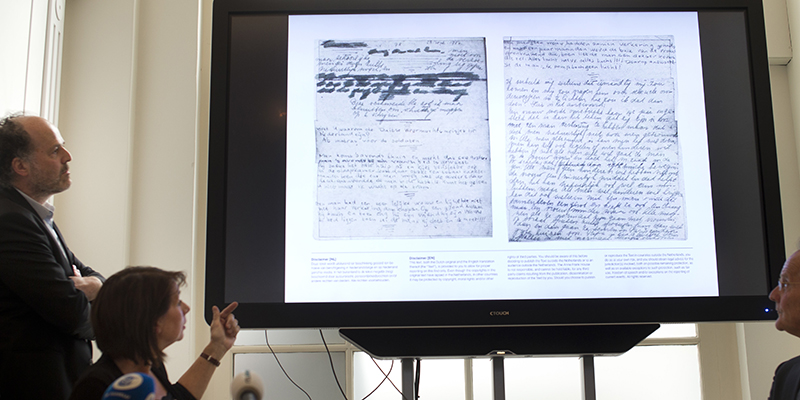Non sapete cosa sia la precisione se non conoscete i fact checker del New Yorker
La rivista più autorevole del mondo ha raccontato storie e aneddoti su uno dei motivi per cui è considerata tale: la squadra che evita gli errori

I due chitarristi della band statunitense The National, Aaron e Bryce Dessner, sono gemelli: monozigoti, secondo la prima versione di un articolo che il New Yorker dedicò al gruppo nel 2023. Per averne certezza, in fase di revisione dell’articolo, lo storico reparto di fact checking della rivista si era messo in contatto con uno dei gemelli, Bryce, che aveva confermato che fossero monozigoti. Ma dopo la pubblicazione si era fatto vivo Aaron, per segnalare alla redazione che no, erano eterozigoti.
A quel punto, la stessa persona incaricata del fact checking dell’articolo avviò una conversazione con entrambi i Dessner. Bryce scrisse «non abbiamo mai fatto il test, ma nostra madre pensa che siamo monozigoti», pochi istanti prima che Aaron scrivesse «nostra madre dice che siamo eterozigoti, ma a dirla tutta non abbiamo mai fatto il test». In mancanza di certezze, l’articolo online fu corretto riducendo il dettaglio dell’informazione: «gemelli», e basta. «Una versione precedente di questo articolo riportava in modo errato la relazione familiare tra i fratelli Dessner», c’è scritto tuttora in fondo all’articolo.
Storie come questa sono la ragione della fama del reparto che nel New Yorker si occupa della verifica dei fatti: non è infallibile, come dimostra l’esempio dei gemelli Dessner, ma ci si avvicina molto. Ed è per il lavoro di questo specifico reparto, oltre a quello del resto della redazione, se da cento anni la rivista è considerata un modello straordinario di accuratezza e affidabilità.
Proprio uno dei 25 revisori di cui è composto il reparto, Zach Helfand, ha raccolto in un recente articolo sul New Yorker storie esemplari e spiegazioni dei metodi e dei criteri di lavoro del gruppo, di cui lui fa parte da pochi anni. È un lavoro non facile da spiegare, ha scritto, perché include attività di verifica che tipicamente svolge anche l’autore o l’autrice dell’articolo, più altre che vanno molto oltre il lavoro abituale del resto della redazione.
In un certo senso, è come se il responsabile del fact checking riscrivesse l’articolo da capo, soffermandosi sui punti deboli e assumendo una prospettiva che metta in dubbio ogni affermazione. Parla con tutte le persone usate come fonti dell’articolo, anche quelle non direttamente citate o citate solo di sfuggita (gli autori devono consegnare al revisore ogni appunto, registrazione e trascrizione). Le persone contattate possono confermare o no quanto scritto dall’autore o dall’autrice, segnalare eventuali errori, fornire più informazioni di contesto o prove, ma non possono apportare modifiche.
Un caso di lavoro ordinario di questo tipo, per esempio, è anche quello condotto nel 2022 dal responsabile della revisione di un articolo su Francesco Costa, attuale direttore del Post e all’epoca conduttore del podcast Morning. Conteneva, tra le altre cose, un breve virgolettato attribuito al peraltro direttore Luca Sofri e tratto da un’ora di conversazione tra lui e l’autore dell’articolo. Il responsabile del fact checking si era poi messo in contatto con Sofri chiedendogli di confermare sia il virgolettato, sia altre informazioni di contesto.
In caso di disaccordo o punti controversi il revisore ne discute con l’autore e il direttore, che ha l’ultima parola. «È un processo intenzionalmente conflittuale, come un procedimento giudiziario», in cui si cerca di assumere la prospettiva migliore di entrambe le parti, ha scritto Helfand sul New Yorker. Riguardo al rapporto che si crea tra autori e revisori, ha aggiunto che in linea generale «più è bravo il giornalista, più va d’accordo con i revisori». Lo scrittore Jay McInerney, che lavorò anche come fact checker per la rivista, una volta scrisse che gli autori odiano i revisori nella misura in cui dipendono da loro.
Ai revisori neoassunti, al momento del loro primo incarico, viene chiesto di stampare le bozze dell’articolo e sottolineare tutti i fatti: quasi tutto l’articolo, praticamente. «Nomi e cifre sono fatti; anche le virgole possono esserlo. Fumetti, poesie, fotografie, copertine: pieni di fatti. Le opinioni non sono fatti, ma si basano su molti fatti». Anche i colori sono fatti, ha scritto Helfand, citando come esempio un articolo in cui l’autrice aveva scritto in un passaggio «una striscia gialla di escrementi di uccello»: il revisore aveva consultato alcune fonti anche in quel caso, scoprendo che gli escrementi degli uccelli in effetti possono essere gialli, in caso di problemi al fegato.
Sono fatti anche le date, che a volte sono contenute nelle citazioni. In un articolo del 2016, verso la fine, l’autore scriveva di un artista che aveva detto che si sarebbe sposato «il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate». Il revisore lo chiamò, si congratulò con lui e lo avvisò che il solstizio quell’anno era il 20 giugno: l’artista spostò la data del suo matrimonio.
A volte il fact checker pone al suo interlocutore domande talmente assurde che, in qualsiasi altra situazione, l’interlocutore si chiederebbe se il fact checker «non abbia avuto un aneurisma cerebrale», ha scritto Helfand. Una volta, nel 2009, il revisore di un articolo chiese alla scrittrice inglese Zadie Smith se a una festa per il compleanno di Ian McEwan avesse notato una lumaca strisciare sul bordo di un bicchiere. Nel 1993, per verificare una frase contenuta in un altro articolo, un revisore chiese al cantante Art Garfunkel di confermare che avesse due braccia, dopo che un giornalista lo aveva descritto mentre salutava con entrambe.
Altri esempi di domande strambe citate da Helfand sono: «il cuoco svedese [un personaggio dei Muppet] ha un monosopracciglio? no, ha due sopracciglia che si congiungono sopra il naso». Oppure: «un pècari [un lontano parente dei cinghiali, che vive nel sudovest degli Stati Uniti e in America Centrale e del Sud] potrebbe inseguire un essere umano su un albero? sì, se è un pècari labiato, che è grande come un piccolo orso e incline a fuggire in preda al panico».
Una delle cose più belle del lavoro, ha scritto Helfand, è diventare «un esperto per due settimane su un argomento a cui non avevi mai pensato molto: la scienza missilistica, il prepuzio, la sabbia». Tra persone del reparto di fact checking è del tutto normale porsi ogni giorno a vicenda domande del tipo «qualcuno è mai stato canottiere agonista?», o «qualcuno ha avuto contatti con il presidente del Gabon?». E non è infrequente che qualcuno risponda sì, data l’estrema eterogeneità della formazione, delle esperienze e delle vite personali dei dipendenti del reparto.
La maggior parte ci arriva sperando di diventare autore o redattore, ha scritto Helfand, ma per lui è stato come «un’iniziazione: c’erano storie segrete, notti insonni e strane usanze, anche se meno di una volta». Lo ha descritto come «il gruppo più eterogeneo di persone ansiose che avessi mai incontrato, tralasciando le convinzioni politiche e l’età». Ne fanno parte revisori cresciuti poveri e cresciuti con miliardi, gente di New Orleans e gente di Nanchino, persone che hanno studiato nelle migliori università e altre che hanno fatto la scuola pubblica e basta.
Uno dei capi storici del reparto di fact checking, Peter Canby, andato in pensione nel 2020, aveva lavorato nel Maine come raccoglitore di vongole e come potatore di alberi, prima di arrivare al New Yorker, per caso. Il reparto parla in tutto 15 lingue, tra cui urdu, cantonese, giapponese, arabo, greco, russo e twi, e conosce il greco antico e il latino.
Per essere assunto Helfand ha sostenuto tre colloqui di lavoro, uno dei quali includeva un quiz di verifica con domande di cultura generale su attualità, arte e politica. Per esempio: «cosa ha stabilito il caso Marbury contro Madison?», «chi ha scritto il racconto su cui si basa Drive My Car?», «sai nominare i gruppi statali e non che combattono nella guerra siriana?». Ma la funzione del quiz è ambigua, ha detto Helfand, ritenendo che sia anche un modo di verificare la capacità delle persone di pensare sotto pressione.
Forse è «solo un modo per divertirsi», ha aggiunto, citando una domanda rimasta nel quiz per anni: «Qual è il miglior film di tutti i tempi?». Un revisore ragionevole la definirebbe una richiesta non verificabile, ma si racconta che fosse solo una possibilità data ai migliori candidati di non ottenere il massimo dei voti. Tutti infatti sapevano che Martin Baron, a lungo capo del reparto, adorava Viale del tramonto: bastava non dare quella risposta. Ed era importante non prendere il massimo, per non dare l’impressione di essere dei saputelli: «un saputello è incline all’eccesso di sicurezza», ha scritto Helfand.
Per lungo tempo la sala più frequentata dal reparto è stata la biblioteca dei libri usati per le verifiche, perlopiù volumi enciclopedici e titoli come Who’s Who in the People’s Republic of China, del sinologo Wolfgang Bartke. Ai neoassunti viene però ricordato di non fidarsi troppo dei libri, perché tendono a non essere verificati: servono però come orientamento per altre ricerche. In quella sala il reparto teneva anche una riunione settimanale, tutti i venerdì, in cui i revisori discutevano di articoli problematici e si lamentavano di alcuni autori e redattori.
In un’altra biblioteca frequentata dai fact checker, più piccola, capitava che quelli con scadenze molto ravvicinate passassero la notte sul pavimento, con solo un cuscino. Era anche la sala per le conversazioni riservate con persone come Julian Assange, che richiedevano metodi tecnologici di cui ai revisori non era permesso parlare. In un certo senso, ha scritto Helfand, i fact checker della rivista sono le persone impegnate nel «business della riduzione dei danni», considerando che spesso nel loro lavoro i giornalisti finiscono per farli.
Al New Yorker circola anche un aneddoto – inverificabile, secondo i fact checker – che è considerato una specie di mito della fondazione del reparto. Nel 1927 la rivista pubblicò un articolo in gran parte inventato sulla poeta Edna St. Vincent Millay, la cui madre si presentò poi in redazione minacciando una causa legale. Per dissuaderla la direttrice Katharine Angell le promise che sarebbe stata pubblicata una rettifica, e da quel momento in poi il fondatore Harold Ross decise che serviva un reparto stabile di persone incaricate di verificare i fatti. Ma non è ben chiaro cosa indusse davvero Ross a prendere quella decisione.
Un’idea che Ross riuscì a trasmettere ai fact checker, ha scritto Helfand, è l’importanza di «comprendere il mondo in tutta la sua stranezza». Ma anche la disponibilità e l’inclinazione ad ammettere la propria ignoranza: si racconta che una volta entrò nell’ufficio del reparto chiedendo «Moby Dick è la balena o l’uomo?».
Tra le altre storie notevoli sul reparto c’è la verifica di cui dovette occuparsi nel 1973 Sara Lippincott, incaricata del fact checking di un articolo dello scrittore e giornalista John McPhee, vincitore del Premio Pulitzer nel 1999. L’articolo raccontava la storia di un pallone incendiario giapponese che durante la Seconda guerra mondiale aveva attraversato l’oceano Pacifico e colpito un cavo elettrico che riforniva un sito nucleare segreto. Era quello usato per arricchire il plutonio per la bomba atomica diretta a Nagasaki, e quell’incidente ne aveva causato una disattivazione temporanea.
«Come faceva McPhee a saperlo? Qualcuno glielo aveva detto. Come faceva quella persona a saperlo? Ne aveva sentito parlare, di seconda mano», ha scritto Helfand. Lippincott, la fact checker, trascorse settimane a cercare di rintracciare una fonte di prima mano, e trovò una pista da seguire solo prima che la rivista andasse in stampa. «Chiamò la fonte a casa, in Florida. Era al centro commerciale. Come raggiungerlo in tempo? Chiamò la polizia. Lo trovarono e lo portarono in una cabina telefonica. Sapeva dell’incidente? Sì. Come? Era il responsabile del sito del reattore; aveva visto accadere tutto. Il dettaglio fu inserito nell’articolo».
– Ascolta anche la puntata del podcast “Per fare il Post” con Marco Surace e Cecilia Pigozzi: Gli errori finiscono quando si smette di cercarli