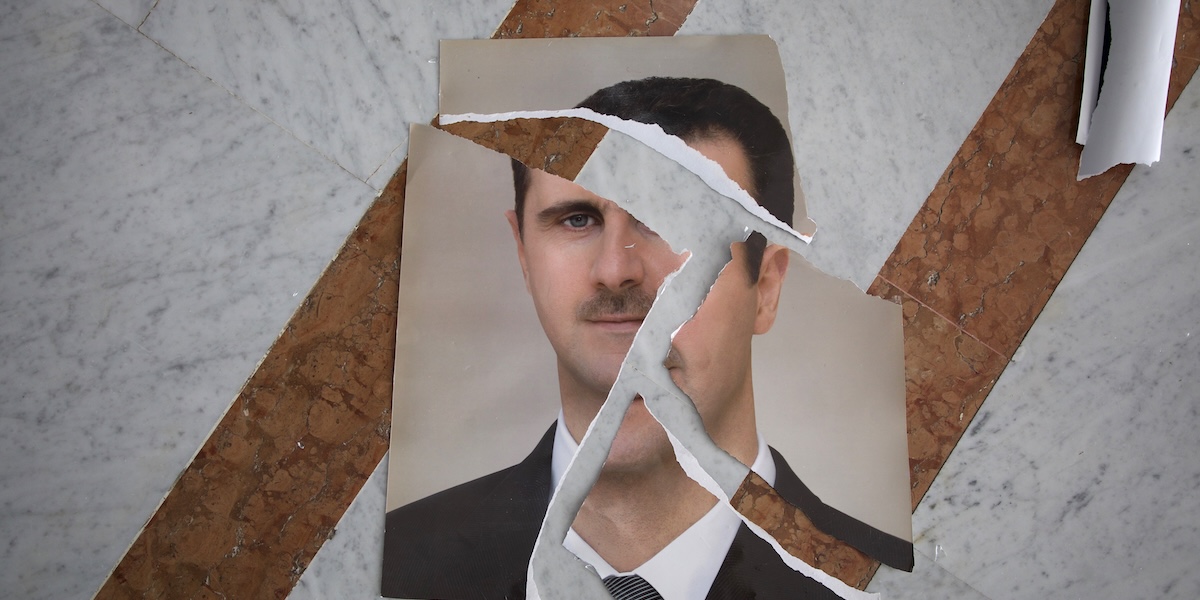Quando vinse Tony Blair
Il ruolo, le qualità e i limiti della leadership di Tony Blair sul partito laburista e sul governo britannico, ora che se ne parla di nuovo, in un capitolo della biografia di Andrea Romano
di Andrea Romano

Una polemica con linguaggi sgradevoli da parte di un assessore del PD a Ferrara nei confronti di Nichi Vendola ha riportato in discussione il ruolo, le qualità e i limiti della leadership di Tony Blair sul partito labourista e sul governo britannico. Ma è la stessa campagna di Matteo Renzi per le primarie e il governo italiano ad avere molti tratti comuni e spiegabili con quel periodo, con vent’anni di ritardo (come avviene per molte cose in Italia). Sabato su Repubblica Michele Serra aveva suggerito ai giornali una maggiore chiarezza su Blair e il blairismo, e Andrea Romano gli aveva risposto sul Post. Ma Romano – storico all’Università di Roma Tor Vergata – è anche autore di una biografia di Blair, The Boy (Mondadori, 2005), di cui pubblichiamo il capitolo che racconta come divenne leader del Labour e primo ministro del Regno Unito.
*****
Nelle sue memorie, scritte nel 2003 dopo aver lasciato il governo in polemica con l’intervento in Iraq, l’ex ministro degli Esteri Robin Cook rievoca un incontro avvenuto poco tempo prima con Roy Hattersley: l’ex numero due di Neil Kinnock, con il quale Cook aveva polemizzato praticamente su tutto nel corso dei passati decenni di militanza comune. Perché Hattersley era il leader storico della destra laburista e Cook una tradizionale figura di riferimento per le diverse anime della sinistra interna. Eppure, i due vecchi compagni di partito si trovano ora a «condividere commenti e lamentele sulla leadership del governo e del partito», rimpiangendo insieme il buon tempo andato. Quando Blair non era ancora apparso all’orizzonte e le due anime tradizionali del partito – quella revisionista e quella intransigente – potevano duellare in santa pace, riconoscendosi reciprocamente il controllo di un’area precisa dell’identità laburista.
La scena descritta da Robin Cook rende bene il significato della leadership di Blair sul Labour. Che non segnò il ritorno dei revisionisti al controllo del partito dopo un periodo di «intransigenza». E non solo perché lo stesso John Smith provenisse già dalla destra laburista. In realtà, la scelta del Labour di puntare le sue carte su Tony Blair, al momento della morte di Smith, equivalse nei fatti a superare il tradizionale conflitto che aveva attraversato la sinistra britannica sin dal secondo dopoguerra.
Si trattò di un patto, politico e personale. Tra un partito che era rimasto lontano dal potere per quindici, lunghi anni e colui che poteva finalmente garantirne il ritorno a Downing Street. Perché incarnava meglio di altri, compreso Gordon Brown, la capacità dei «modernizzatori» di incalzare il thatcherismo sul suo terreno, conquistando il centro della mappa politica britannica. E perché sembrava aver trovato le parole giuste, a partire dai temi della criminalità, per riconnettersi a una comunità nazionale che non aveva ancora del tutto superato le perplessità verso il Labour.
Alcuni leader laburisti, come Clement Attlee o lo stesso John Smith, erano arrivati al vertice sospinti da un legame ombelicale con quel partito. Vi erano nati e cresciuti, sapendo rappresentarne in forma empatica gli umori e le sensibilità. Altri vi erano arrivati quasi dall’esterno, come condottieri stranieri a cui un principato pericolante affida lo scettro del potere. Furono di questo secondo tipo i leader come Hugh Gaitskell e Harold Wilson, giunti al Labour in età adulta e provenienti da altre carriere. Capaci di guidare il partito in virtù di una forza di carattere razionale piuttosto che passionale. Quella stessa forza che nel 1994 spinse i laburisti ad affidarsi a Blair. Già nelle ore immediatamente successive all’improvvisa scomparsa di John Smith, quando l’interrogativo che si posero i maggiorenti e la gran parte dei militanti del Labour fu uno solo: «Chi ha le maggiori possibilità di farci vincere le prossime elezioni?». Perché la lontananza dalle leve del potere si era fatta ormai insopportabile, patologica. Soprattutto dopo la delusione del 1992, quando la vittoria era sembrata a portata di mano. E soprattutto per un partito che non aveva mai avuto nella propria ragione sociale la testimonianza politica fine a se stessa. Almeno non dalla fine degli anni Trenta, quando aveva saputo reinventarsi come partito nazionale e di governo.
Le risposte a quella domanda convergevano su Tony Blair, dai punti più diversi del partito. L’ala radicale, ormai depurata dalle sue manifestazioni più estremistiche, vi vedeva un giovane lontano dal linguaggio tecnocratico di Wilson e Callaghan. Una figura che tra l’altro aveva saputo leggere il thatcherismo con la lente della «nuova sinistra». E dunque come nuova egemonia, per quanto regressiva, secondo la lezione venuta da «Marxism Today». Certo, non si trattava né di «un figlio del popolo» né del miglior amico dei sindacati. Ma era comunque meglio delle antiche vestali del revisionismo, che tra l’altro aveva mostrato di saper bacchettare per l’incapacità di uscire dall’ottimismo della crescita. Gli esponenti della tradizione revisionista, pur bacchettati, vi vedevano l’erede dell’ispirazione più pragmatica della leadership di Neil Kinnock, dimostrata in particolare nell’impegno a ridurre lo strapotere sindacale sul partito. Ma tutti volevano disperatamente vedervi il profilo di colui che avrebbe finalmente condotto il Labour fuori dal tunnel dell’opposizione. Forse anche John Smith ci sarebbe riuscito, pensavano i molti (ma non tutti) che avevano creduto alla sua scommessa sull’inevitabile autodistruzione dei conservatori. Ma, dopo la morte di Smith, nessuno della sua generazione appariva in grado di offrire le stesse certezze che la figura di Tony Blair ispirava in un partito disposto a molto, pur di concludere una traversata nel deserto durata ormai quindici anni.
Per tutte queste ragioni, la corsa di Tony Blair verso la leadership laburista non incontrò nessun ostacolo di rilievo. Nessuno, tranne Gordon Brown. Colui che aveva studiato da leader di partito – come forse avrebbe commentato un osservatore italiano – sin dai primi e brillanti passi di una carriera che si era sempre svolta all’insegna dell’eccellenza politica. Colui che avrebbe potuto candidarsi alla guida del Labour dopo le dimissioni di Kinnock. E che nel giro di un paio di anni si era trovato scavalcato, nelle percezioni del partito ma soprattutto del pubblico, da quel coetaneo che al suo ingresso a Westminster lo aveva scelto come tutore e che ancora nel 1992 aveva immaginato di poterne essere il numero due. Tuttavia Gordon Brown non rappresentò per Blair un ostacolo propriamente politico. Nel merito delle cose da fare, per riportare il partito al governo e per guidare il paese, i due esponenti laburisti condividevano anche i minimi dettagli di uno stesso orizzonte. Non era un caso, d’altra parte, che la coppia «Brown e Blair» (prima in quest’ordine, poi in ordine inverso) avesse rappresentato dalla fine degli anni Ottanta in avanti la punta d’attacco della squadra che mirava con più convinzione alla «modernizzazione» del partito. Pur con tutta l’indeterminatezza che quel termine portava con sé.
L’ostacolo rappresentato da Brown per la corsa di Blair era invece di natura strettamente personale. Nel senso che entrambe le personalità avrebbero potuto ambire a candidarsi alla leadership, in virtù di identiche considerazioni politiche. E sebbene tra di loro si fosse ormai consolidato un rapporto di vicinanza e famigliarità – mai trasformatosi in amicizia – era pur vero che la prospettiva finalmente realistica di guidare il partito nel quale avevano speso la parte decisiva delle loro vite rappresentava per entrambi un’ambizione difficilmente controllabile. Il rischio era dunque che nessuno dei due volesse fare un passo indietro. E che dinanzi al meccanismo implacabile dell’elezione per la leadership laburista – un autentico sistema di primarie, che non ammette camuffamenti plebiscitari – si producesse una doppia candidatura. Che avrebbe finito per dividere il campo dei «modernizzatori», rischiando di favorire un esponente della vecchia guardia. E producendo una rivalità tutta personale tra figure politiche del tutto simili, come a volte accade nei moderni partiti personalizzati.
Da qui la principale difficoltà che dovette affrontare Blair nei giorni immediatamente successivi alla morte di Smith. In una vicenda che si svolse largamente nell’ombra, tra colloqui riservati dei rispettivi emissari e cene a quattr’occhi fra i due leader. E che nelle ricostruzioni giornalistiche degli anni a venire avrebbe assunto i toni di un dramma shakespeariano. Alimentando un genere particolarmente popolare nella stampa britannica, sia quella colta sia quella tabloid, con consiglieri che tramano alle spalle di questo o di quello, donne che incitano i rispettivi partner a essere ambiziosi e implacabili, patti segreti siglati in ristoranti alla moda. Il dramma ha avuto persino una sua trasposizione cinematografica, nel film per la televisione The Deal, diretto da Stephen Frears e trasmesso da Channel Four nel settembre 2003. La verità è che non era nell’interesse di nessuno che si producesse una frattura tra i due leader. Ciascuno dei quali sapeva di dover assolutamente contare sull’appoggio dell’altro. Non solo per il controllo del partito, ma soprattutto nella prospettiva non più immaginaria di un governo del paese che avrebbe richiesto a tutto il Labour la piena disponibilità delle sue migliori risorse politiche e personali.
La forza della candidatura di Tony Blair era nelle cose: nei sondaggi che già dalla domenica successiva alla morte di Smith lo davano largamente in testa su Brown nelle preferenze degli elettori (e non solo dei militanti laburisti); nei favori della stampa progressista che aveva messo gli occhi su di lui sin dall’inizio degli anni Novanta; nell’appoggio del più ampio gruppo dirigente del partito, che da entrambi questi canali ricavava la convinzione che fosse proprio Blair la figura più adatta ad attrarre finalmente al Labour il sostegno della maggioranza del paese. È del tutto evidente che Brown vivesse questi segnali con sofferenza. Si trattava di una dolorosa delusione personale per chi, come lui, si era preparato da anni a questo momento. Venendo superato proprio sul traguardo. Avrebbe potuto provare a ribaltare i pronostici, promuovendo una campagna a proprio favore che facesse appello a quei larghi settori laburisti che ne apprezzavano il più tradizionale cursus honorum e la più rassicurante affidabilità di partito. Ma sarebbe stata una scelta di rottura e piena di incognite, da cui il Labour sarebbe probabilmente uscito con molte ferite. Anche perché Blair non avrebbe rinunciato in alcun modo alla propria candidatura.
Fu lo stesso Brown a dar prova di responsabilità, rivelando la tempra di chi aveva ricevuto dai decenni vissuti nella sinistra britannica non solo una grande ambizione ma anche una solida educazione morale e politica. La sua rinuncia prese la forma riservata di un accordo diretto con Blair, favorito dalla mediazione di Mandelson, con il quale vennero poste le basi di una divisione dei compiti nel futuro governo laburista. Tra i due fu concordato un vero documento politico, la cui ultima bozza preparatoria è stata recentemente pubblicata dalla stampa britannica. Vi si riconosceva che «Tony risulta essere in vantaggio nei sondaggi di opinione … pur essendo entrambi sostenuti dall’appoggio di una larga parte del partito e dei sindacati»; l’obiettivo che i due si ponevano era «garantire che la nomina del nuovo leader sia orientata a un unico scopo: assicurare l’elezione di un governo laburista che possa contare sulla più ampia unità del partito»; e per questo «Gordon ha preso una decisione che privilegia la coesione e lo spirito di squadra rispetto all’ambizione personale». Il ruolo che veniva garantito a Brown era quello di stratega dell’agenda economica del futuro governo laburista, secondo un «programma di giustizia sociale, di valorizzazione delle competenze e delle opportunità di lavoro» di cui «Tony garantisce la realizzazione».
L’intesa fu sancita nel corso di una cena a due, la sera del 31 maggio 1994, al ristorante Granita, nel quartiere londinese di Islington. Si trattava di un accordo destinato a segnare tutto il successivo decennio laburista, all’insegna di una divisione dei ruoli tra il leader, che avrebbe garantito la raccolta dei consensi decisivi per conquistare e mantenere il governo del paese, e colui che di quel governo avrebbe retto il timone delle politiche economiche. In cambio della leadership di partito – a cui rinunciava senza condizioni, e dunque senza alcun accenno a un’ipotetica, futura staffetta alla guida del governo – Gordon Brown riceveva carta bianca nel suo terreno di elezione. Ma soprattutto era un accordo possibile solo perché quelli che si spartivano il campo erano due generali alleati. Diversi per molti aspetti nel loro profilo pubblico ma del tutto simili per quanto riguardava la direzione da imprimere al partito e al corso politico del paese. Da qui la forza di un’intesa che negli anni a venire avrebbe resistito a tornanti anche drammatici. E che nell’immediato permetteva a Tony Blair di affrontare con estrema sicurezza la corsa per la guida del partito.
Perché, in effetti, quella che si aprì il 10 giugno, con la presentazione ufficiale della sua candidatura, fu una formalità piuttosto che un’autentica campagna per la leadership. Poco poté essere raccolto dagli altri due contendenti, John Prescott e Margaret Beckett. E il 21 luglio 1994, con il 57% dei voti e all’età di quarantuno anni, Tony Blair veniva designato leader del Partito laburista. Quel partito che si affidava alle capacità taumaturgiche di un giovane dirigente, iscritto da meno di vent’anni e presente in Parlamento da poco più di dieci, per tentare il quinto e consecutivo assalto al dominio politico dei conservatori. Era questa la natura del vero patto su cui poggiava la leadership di Blair: quello siglato con il Labour, non tanto la divisione dei compiti definita con Gordon Brown. E tuttavia quel patto avrebbe dovuto essere rapidamente alimentato da qualcosa di più di un senso di fiducia disperata, quale aveva sorretto la scelta dei moltissimi che avevano designato Blair alla leadership. Di lì a poco non sarebbe più bastata l’eco della sua campagna sul crimine o la benevolenza dei principali editorialisti politici. Blair avrebbe dovuto rapidamente convincere il partito dell’efficacia delle proprie convinzioni e della propria strategia, ponendo al contempo le basi per la lunga campagna che si sarebbe svolta nel paese in vista del voto popolare del 1997.
Ma se le sue convinzioni erano quelle maturate nel corso degli anni, a partire dalle passioni morali dell’università, qual era la sua strategia? Come contava di far vincere il partito di cui era diventato capo? Da questo punto di vista, la campagna per la leadership non fu un’occasione molto utile. Troppo ampio il consenso che lo sorreggeva, troppo scontata la sua elezione per spingerlo a mettere a fuoco pubblicamente la sua prospettiva di movimento. In realtà quella prospettiva andava prendendo forma dietro le quinte, negli incontri con coloro che sarebbero stati i suoi principali collaboratori al vertice del partito. E nell’elaborazione di idee di fondo che avrebbero rappresentato lo scenario sul quale si sarebbe poi definita una vera strategia elettorale.
Philip Gould, in particolare, ci racconta di un memorandum riservato che Blair scrisse in giugno. Dunque, prima della formalizzazione della sua nomina a leader. Tra i «principi strategici» che Blair si riprometteva di sviluppare, al primo posto troviamo: «Cambiamento e rinnovamento: una nuova direzione per il paese; principi tradizionali ma applicazione moderna; onorare il passato senza rimanere bloccati al suo interno; senza Smith dovremo promuovere il cambiamento con coraggio, senza cautela». Tra le «idee»: «Una nuova e ambiziosa agenda per la sinistra, che vada al di là della vecchia barriera tra destra e sinistra; dobbiamo essere radicali ma moderni, dobbiamo ridefinire cosa significa essere di centrosinistra». Sotto il titolo «Determinazione»: «Blair crede in ciò che dice e dice ciò in cui crede». E soprattutto, al paragrafo «Principio basilare», una rappresentazione sintetica del proprio credo socialista: «Il socialismo non è un pacchetto di rigide ricette economiche ma un insieme di valori incentrati sulla fiducia nella società e nella comunità; ovvero nell’idea che le persone possano vivere meglio all’interno di una società forte e coesiva, dove i doveri vadano di pari passo con le opportunità. Dobbiamo rifondare la Gran Bretagna come una società forte, questo è l’obiettivo del nostro socialismo per una nazione finalmente unita. Ma dobbiamo farlo avendo in mente il mondo contemporaneo. Questo significherà imprimere una nuova direzione al nostro paese. Inoltre, dobbiamo ridefinire i termini della coesione sociale e della comunità, attraverso un sistema di welfare il cui obiettivo non sia più la creazione di una classe di cittadini a carico dello Stato, bensì la possibilità di dare a tutti l’opportunità di migliorare la propria condizione».
Un insieme di concetti che Blair affidava, in forma più articolata, a un pamphlet dal titolo Socialism pubblicato in quegli stessi giorni di giugno dalla Fabian Society. Nel quale si leggeva, tra l’altro: «Il Partito laburista e la sinistra britannica hanno di fronte a sé la straordinaria opportunità di conquistare il terreno e il linguaggio delle opportunità, attraverso politiche che siano perfettamente coerenti con i propri principi tradizionali: in particolare con l’obiettivo di dare agli individui i migliori strumenti per migliorare la loro condizione nella nuova economia contemporanea. Adattando quei principi al mondo contemporaneo nel quale viviamo. Il nostro pensiero e le nostre nuove idee devono concentrarsi su questo obiettivo, liberandosi da vincoli ideologici del tutto artificiali».
È difficile non vedere in queste note, buttate giù alla vigilia della sua designazione a leader, il nocciolo del blairismo così come di lì a poco sarebbe stato conosciuto dalla sinistra britannica. Come sintesi estremamente semplificata della strategia politica laburista, quella bozza di lavoro avrebbe potuto essere scritta anche dieci anni dopo. A conferma non tanto della particolare coerenza del disegno blairiano, che in realtà avrebbe conosciuto più di un aggiustamento, quanto della compattezza del suo nucleo ideologico di fondo.
Quel nucleo risultava essere in buona sostanza il frutto di un incontro a tre: da una parte le migliori intuizioni della tradizione del revisionismo laburista, filtrate dall’esperienza degli anni di Neil Kinnock (la critica all’economicismo socialista, lo Stato che dà strumenti e non semplice assistenza); dall’altra l’afflato radicale della sinistra laburista (la nuova direzione da imprimere al paese, la possibilità di essere allo stesso tempo radicali e moderni); e sullo sfondo, a connotare il tutto, la forte ispirazione morale e comunitaria che aveva animato Tony Blair sin dagli anni di università. Un’ispirazione che già nei suoi primi passi da politico aveva sorretto l’idea di una necessaria trasformazione del sistema di welfare britannico, insieme a un altrettanto necessario allargamento dello spazio politico del Labour. Facendogli dire già nella sua lezione australiana del 1982 che «la Gran Bretagna sta diventando la patria di due diverse società: coloro che hanno impieghi ben pagati o che lavorano nelle industrie dove i sindacati sono forti, e coloro che sono senza lavoro o che non sono protetti da nessun sindacato. Rivolgere il nostro appello elettorale solo a una delle due parti attirerebbe su di noi l’ostilità dell’altra».
Di lì a pochi mesi il progetto del New Labour si sarebbe presentato anche come cesura radicale con una parte della storia precedente di quel partito. Tony Blair avrebbe tratto da quella cesura la forza per alimentare la sua stagione da leader e il progetto di estendere i confini del consenso laburista oltre i tradizionali serbatoi elettorali. Ma se è vero che la leadership di Blair rappresentava l’abbandono delle cautele che avevano segnato gli anni di John Smith, oltre che la definitiva sepoltura delle tentazioni massimaliste covate dal partito negli anni Ottanta, è altrettanto vero che gran parte della contrapposizione tra «New Labour» e «Old Labour» aveva una funzione mitologica. Intendendo fondare una nuova tradizione che fosse strumentale al consolidamento di un leader all’interno del proprio partito, e di quel partito all’interno della nazione britannica. Perché, in realtà, i punti di contatto tra il nascente fenomeno del blairismo e la vicenda laburista del Novecento erano molti e non casuali. Configurando quel fenomeno come il punto di arrivo di un’articolata storia politica e non solo personale.
I segni della continuità con correnti diverse della tradizione laburista, ben al di là di quella revisionista, erano visibili anche nella scelta dei collaboratori di cui Blair volle circondarsi in quella fase iniziale della sua leadership. Il nucleo dei partigiani della «modernizzazione», quello che ne aveva sorretto le convinzioni e l’avanzata personale negli anni di Kinnock e di Smith, rimaneva intorno a lui nelle figure di Mandelson, Gould e Alastair Campbell. Quest’ultimo, entrato nel suo staff come addetto stampa nel 1994, già da anni era molto noto come stella del giornalismo politico (oltre che come una delle persone più vicine a Neil Kinnock). Ma al di là della cerchia di sodali e consiglieri strategici, Blair scelse di essere affiancato da due giovani quasi sconosciuti provenienti dal mondo dei think-tank, i pensatoi dove competenze scientifiche e ispirazione politica si mescolano nella produzione di scenari strategici e soluzioni tecniche spesso fascinose quanto velleitarie. E che, soprattutto in ambito anglosassone, svolgono tradizionalmente la funzione di bacino di alimentazione per le idee di politici desiderosi di percorrere nuove strade.
I due erano David Miliband e Geoff Mulgan, provenienti rispettivamente dall’Ippr (Institute for Public Policy Research) e da Demos. Il primo era figlio d’arte: il papà Ralph Miliband era stato negli anni Sessanta uno degli intellettuali che con maggiore vigore si erano opposti al pensiero revisionista, soprattutto con il suo Parliamentary Socialism del 1961. Accusandolo in particolare di voler perseguire un disegno compromissorio e moderato, del tutto lontano dai veri ideali di trasformazione della società. Da tanta intransigenza – e non senza una qualche ironia della sorte – erano usciti due figli destinati ad accompagnare sino a oggi il lavoro dei dioscuri del New Labour. David con Blair (alla guida della sua «policy unit» fino al 2001, poi come viceministro per l’Istruzione, infine come responsabile della campagna elettorale del 2005 insieme ad Alan Milburn) e il fratello Ed come capo dello staff politico di Gordon Brown. Una coppia di giovani brillantissimi, che ben prima di compiere trent’anni avevano già conquistato una posizione centrale nel cervello politico della nuova leadership laburista.
L’Ippr era stato fondato alla fine degli anni Ottanta da Patricia Hewitt, l’ex stratega di Neil Kinnock. E dell’aspirazione al rinnovamento di quest’ultimo aveva voluto sviluppare i contenuti, specialmente negli anni della bonaccia di John Smith, guardando soprattutto al modello di agitazione politico-culturale dei think-tank statunitensi. David Miliband, in particolare, si era occupato di un progetto destinato a lasciare più di una traccia negli anni a venire: una serie di seminari programmatici riservati, nei quali venne affidato ad alcune personalità del mondo delle idee e della politica il compito di suggerire le modalità di una completa reinvenzione della strategia laburista. Questo lavoro venne svolto tra il 1993 e il 1994, ben prima della morte di Smith e quando non vi era motivo di ritenere che la leadership laburista non dovesse rimanere a lungo nelle sue mani. Il prodotto finale, però, un volumetto dal titolo ambizioso ma non del tutto fuori bersaglio di Reinventing the Left, doveva casualmente apparire in pubblico all’indomani della scomparsa di Smith e nel pieno dell’emersione della candidatura di Blair.
Vi comparivano per la prima volta le incursioni propriamente politiche di Anthony Giddens, che dal suo terreno sociologico si muoveva a suggerire «una completa rifondazione del nostro sistema di welfare», in grado di «restituire all’individuo una forte autonomia di azione» e di «ricostruire la rete della solidarietà sociale attraverso la conciliazione tra autodeterminazione e interdipendenza nelle diverse sfere della vita della comunità»; così come vi si trovava una corposa riflessione di Gordon Brown (a cui era stato affidato il compito della sintesi politica finale), incentrata sulle potenzialità dell’individuo come soluzione per rivitalizzare una comunità nazionale devastata dal thatcherismo. Un testo nel quale Brown prefigurava «uno Stato che dia nuovi strumenti ai suoi cittadini [l’“enabling state” di Kinnock], che offra una via d’uscita a coloro che sono intrappolati nel welfare e dimostri che il vero ruolo di un governo è valorizzare la responsabilità individuale e non sostituirsi a essa. Per questo il welfare dovrebbe essere un trampolino di lancio, piuttosto che una semplice rete di sicurezza».
Erano idee che coglievano con qualche preveggenza lo spirito del tempo e che di lì a poco avrebbero rappresentato l’ispirazione di fondo del New Labour. Idee che David Miliband, nell’introduzione al volume, collegava l’una all’altra con lucidità sorprendente per un giovane di ventotto anni. Collocandole sullo sfondo di una crisi che non era solo della sinistra ma più in generale della democrazia, se si guardava ai fenomeni di antipolitica che si andavano diffondendo in tutto il mondo occidentale (e si pensi a cosa accadeva in Italia in quei mesi del 1993-94). Ma alla sinistra quella crisi richiedeva la ricerca di nuovi strumenti di mobilitazione, che restituissero ai suoi valori tradizionali e alla sua prospettiva politica la capacità di governare i fenomeni sempre più complessi che la globalizzazione faceva emergere nelle società occidentali. Quegli strumenti di mobilitazione – era questo il senso di fondo del lavoro svolto dall’Ippr – non potevano essere trovati nel cerchio rassicurante delle identità tradizionali. Viceversa, i valori tradizionali dell’eguaglianza e della solidarietà dovevano «essere accompagnati da un nuovo impegno verso l’estensione dell’autonomia personale», giacché «l’interesse collettivo sarà garantito dall’integrazione tra l’azione pubblica e le decisioni di mercato, piuttosto che dalla loro giustapposizione».
Il tema dell’antipolitica come sfondo del rinnovamento ideale del laburismo appare particolarmente rilevante se visto a dieci anni di distanza. Perché mette in luce come una delle spinte originarie del blairismo sia stata proprio l’intenzione di accrescere la forza autonoma della politica, nei confronti sia dei rischi di svuotamento della democrazia connessi ai processi di globalizzazione sia della diffusione di sentimenti di disillusione verso le istituzioni pubbliche. Il New Labour nasce quindi come tentativo di «ripoliticizzare» la sinistra, adeguando attorno ai valori tradizionali i suoi strumenti di mobilitazione. Non tanto in senso organizzativo (attraverso partiti più efficienti e militanti), ma soprattutto con la scelta di percorsi nuovi sui quali far transitare quei valori: l’accento sull’autonomia personale, la liberazione dalla «trappola del welfare», lo Stato che mette in condizione i propri cittadini di affrontare la novità delle sfide e delle minacce.
Un afflato intensamente politico che in quello stesso periodo stava sviluppando anche Geoff
sizione più defilata rispetto a Miliband, almeno per i primi anni da leader. La duplice particolarità di Mulgan era la sua provenienza dalle file della nuova sinistra britannica e la specializzazione accademica nel campo delle telecomunicazioni. Nello specifico, Mulgan aveva insegnato tecnologie della comunicazione digitale al Polytechnic of Central London ed era stato tra i principali collaboratori di «Marxism Today». Proprio negli anni in cui da quella tribuna solo formalmente ortodossa venne articolandosi quella particolare lettura del thatcherismo che avrebbe influenzato Blair e altri dei più vicini collaboratori di Kinnock. Insieme a Martin Jacques, condirettore della rivista, Mulgan aveva fondato nel 1993 Demos, un think-tank tra i più eclettici della scena britannica, allora come oggi molto abile nel mescolare campi di indagine assai distanti tra di loro, come i nodi della privacy, la comunicazione pubblica, le politiche per la famiglia.
Nei mesi finali della leadership di John Smith, in particolare, Mulgan aveva pubblicato Politics in an Antipolitical Age. Un libretto dai toni visionari – e di forte visibilità sui giornali del periodo – che muoveva dalla stessa considerazione che aveva spinto Miliband e l’Ippr a concentrare la propria attenzione sul peso crescente dell’antipolitica. Disegnando per la sinistra britannica, come soluzione alla perdita di senso e all’indebolimento dei propri valori, il profilo di un nuovo tipo di attore collettivo: il «politico come creatore sociale», che «avrebbe avuto con i propri elettori una relazione diversa da quella basata sugli interessi materiali e focalizzata invece sulla comunicazione e la mobilitazione attorno a valori condivisi». «Ciò che legittimerà questo nuovo tipo di politico» scriveva Mulgan «sarà la sua abilità nel definire nuovi confini e nuovi interessi comuni attorno a cui creare un proprio elettorato … La sua capacità sarà non tanto quella di evangelizzare un’ideologia recuperata dai filosofi, quanto quella di creare una composizione tra principi etici di derivazione pragmatica, esperienze concrete e idee innovative.»
Quella che poteva sembrare una fumosa fantasia era invece un prezioso suggerimento strategico per Tony Blair. E più in generale per coloro che, al vertice del Labour, si interrogavano dopo la scomparsa di John Smith sulle forme che avrebbe dovuto concretamente assumere il loro obiettivo di rilanciare la capacità del partito. Se era ben definita la comune intenzione di riprendere la via della «modernizzazione», dopo la pausa imposta dalle cautele di Smith, meno chiaro era il percorso da seguire per riempirla di contenuti. Per innovare nel merito e nella forma la proposta politica laburista, soprattutto in vista di una stagione che avrebbe dovuto dimostrare rapidamente la capacità di mutare i rapporti di forza a favore della sinistra. In vista di un appuntamento elettorale che era sì previsto di lì a tre anni – nel 1997 – ma che per la leadership inizialmente tanto nuova quanto fragile di Blair avrebbe potuto rappresentare la prima e ultima possibilità di dimostrarsi vincente.
La capacità del nuovo leader fu quindi quella di attingere da subito a una pluralità di correnti di pensiero interne alla sinistra britannica, ben al di là dei ristretti confini della tradizione revisionista e fino a comprendere le componenti più brillanti della «nuova sinistra» di derivazione neomarxista. Accanto al «nucleo duro» dei modernizzatori, la scelta di David Miliband e Geoff Mulgan doveva rivelarsi particolarmente feconda. Contribuendo a dare corpo e struttura al suo profilo intellettuale. E innestandosi su una base di convinzioni il cui perimetro era già segnato dalla comunità come luogo della realizzazione dell’autonomia individuale, dal pragmatismo, dalla centralità delle convinzioni etiche. Quella che rimaneva solidamente ancorata alla tradizione revisionista era l’idea che il mercato fosse il luogo nel quale doveva realizzarsi l’azione pubblica. Una convinzione che non veniva articolata nei termini solari e ottimistici della stagione di Crosland, ma che comunque prevedeva che la politica progressista dovesse andare d’intesa con il mercato e non contro di esso. Anche e soprattutto per valorizzarne la capacità di produrre benessere pubblico e sviluppo. Così come di diretta derivazione revisionista era il metodo politico che la nuova leadership laburista sceglieva di perseguire: la ricerca di una più ampia e articolata estensione dell’area di consensi del partito, attraverso un nuovo connubio tra il proprio elettorato tradizionale e l’appello a quei settori della società che non erano geneticamente legati alla sinistra.
D’altra parte, la stessa rappresentazione storica che Blair aveva della sinistra britannica, delle correnti politiche e di pensiero che l’avevano animata, sembrava guardare a un perimetro più ampio di quello tradizionalmente associato al Partito laburista. Nella galleria d’onore del Labour, tra le figure e le stagioni principali della sua vicenda storica, Blair era attratto soprattutto dall’esperienza del governo di Clement Attlee ed Ernest Bevin. Da quel primo esecutivo del dopoguerra che in soli cinque anni era riuscito a collocare su binari completamente nuovi la nazione britannica, in economia così come in politica estera. E per quanto il modello di welfare disegnato da quel governo apparisse definitivamente superato all’attuale leadership laburista, rimaneva il fatto che Attlee e i suoi uomini erano riusciti a dare una prova di efficacia e lucidità politica mai eguagliata. In una certa misura, nel gruppo dei «modernizzatori» laburisti vi era la stessa duplice consapevolezza della grandezza e del limite di quell’amministrazione che era stata della generazione dei revisionisti degli anni Cinquanta.
Come Crosland e i suoi contemporanei, anche Blair e i suoi alleati riconoscevano al primo governo laburista del dopoguerra la capacità di aver saputo ridisegnare il profilo della nazione. Perdendo tuttavia l’occasione di accompagnare la Gran Bretagna nella nuova fase storica che essi stessi avevano contribuito ad aprire: quell’età dei consumi e dell’affluenza, alla quale non sarebbe stato sufficiente applicare il grandioso programma delle nazionalizzazioni e del welfare universalistico. Implicitamente, la nuova leadership laburista intendeva misurarsi con quella che Peter Mandelson definiva «la lacuna collettiva mostrata dal grande governo riformatore del 1945». Candidandosi a colmarla con pari ambizione ed eguale pragmatismo.
Ma la particolare lettura che Blair dava di quell’esperienza di governo aveva anche un tratto nuovo e rivelatore. Perché, al di là dello spirito nazionale già espresso dalla coalizione guidata da Churchill negli anni di guerra, egli vi riconosceva anche l’eredità della tradizione liberale e neoliberale. E dunque di quella multiforme corrente politica e di pensiero che aveva dato forma per la prima volta, tra il finire dell’Ottocento e il secondo decennio del Novecento, alla rappresentanza delle classi popolari e alle aspirazioni politiche di coloro che su quella rappresentanza intesero far perno per riformare profondamente l’economia e le istituzioni britanniche.
Un anno dopo la sua elezione a leader, Blair avrebbe rievocato in questi termini il cinquantennale della vittoria laburista del 1945. Rendendo un omaggio particolarmente ispirato al «più grande governo britannico di questo secolo», «l’eccezione piuttosto che la regola» nella vicenda del Labour, la cui «fortissima carica di consenso politico era destinata a non essere mai più ritrovata dal nostro partito». Una carica le cui radici Blair collocava anche nella tradizione liberale, e in particolare in quella fase storica segnata da «personaggi che erano al contempo liberali e socialdemocratici, figure di transizione collocate a cavallo di due diverse stagioni storiche, nel momento che vide il passaggio dal dominio di un’etica politica a un’altra». Era la descrizione di personalità come Lloyd George, Beveridge o Keynes. E soprattutto era l’immissione ufficiale del riformismo liberale tra i miti di fondazione del New Labour.
Un passaggio che nelle intenzioni di Blair doveva essere una riconciliazione tra cugini separati, con benefiche conseguenze per la lucidità politica del Labour. Perché «proprio per il bisogno di distinguersi dai riformatori liberali, lo statuto laburista si identificò con una particolare corrente del pensiero socialista. Quella incentrata sulla proprietà statale. Con la conseguenza di segnare la nostra ideologia con una visione troppo angusta del socialismo democratico». Ma non solo di storia si trattava. Perché il compito della leadership laburista guidata da Blair doveva essere la definitiva emancipazione del Labour da quella visione riduzionistica del socialismo, completando il percorso già avviato da Kinnock. Così come la ricomposizione in termini propriamente politici di un fronte progressista che andava al di là degli attuali confini del Labour; che si alimentava anche alla tradizione intellettuale liberale e neoliberale; e che su questa strada doveva fatalmente incrociare il Partito liberaldemocratico. Ovvero il soggetto nato dalla fusione tra il vecchio Partito liberale e il nuovo Partito socialdemocratico sorto nel 1981 da una costola del Labour. Dopo il testa a testa delle elezioni del 1983, quel soggetto non aveva più rappresentato una minaccia diretta all’egemonia laburista sull’opposizione ai conservatori. Era stato questo uno dei risultati più preziosi della lunga e tenace leadership di Neil Kinnock. Lo sguardo rivolto da Blair ai liberaldemocratici non era più condizionato da meccanismi competitivi, quanto dall’esigenza di far sponda su quel soggetto politico e sulla tradizione di cui esso era titolare per rafforzare la torsione che egli intendeva imprimere al Labour. Verso quello spazio dell’autonomia e della valorizzazione individuale che negli ultimi vent’anni era stato occupato dal liberismo thatcheriano, ma che poteva essere recuperato ai valori liberali e comunitari che il suo Labour intendeva rappresentare di fronte alla nazione.
In questo tentativo egli doveva provare a riappropriarsi degli ispiratori neoliberali del governo laburista di Attlee. Ma doveva anche – e necessariamente – fare i conti con il Partito liberaldemocratico. In questo secondo binario della sua interlocuzione con il liberalismo, un ruolo fondamentale fu svolto da Roy Jenkins. L’ex ministro laburista ed ex presidente della Commissione europea, ma soprattutto l’ex leader del gruppo di transfughi laburisti che nel 1981 aveva guidato la scissione a destra: «il capo della banda dei quattro», come era apostrofato in quei mesi dagli ex compagni di partito. Quasi quindici anni dopo quella scissione, le passioni che l’avevano accompagnata si erano definitivamente sopite. Per il venir meno di una competizione diretta, ma anche per il ruolo svolto da Paddy Ashdown: leader liberaldemocratico dal 1988, in passato ufficiale dell’esercito e diplomatico (e secondo alcuni anche agente dei servizi segreti), che per formazione e convincimenti personali era naturalmente spinto a ricercare una collaborazione con i settori del Partito laburista maggiormente impegnati nell’innovazione della propria proposta politica. E dunque con Tony Blair, anche prima che questi giungesse alla guida del Labour. Ma prima che lo facesse Ashdown, fu proprio Blair a ricercare un’interlocuzione con lui e Jenkins negli ultimi mesi della leadership di John Smith. Scrisse in forma privata una lunga lettera all’anziano laburista-liberale per chiedergli alcuni suggerimenti di economia, alla quale Jenkins rispose con un invito a cena. Doveva nascerne una frequentazione a tre, destinata a farsi abbastanza assidua dal momento dell’elezione di Blair a leader e fino alle elezioni del 1997. Una consuetudine di incontri nella quale Jenkins svolgeva la parte del vecchio maestro, che intratteneva Blair con conversazioni di alto profilo e suggerimenti di letture (per le vacanze estive del 1996 gli prestò i discorsi di Keir Hardie e Lloyd George). Mentre Paddy Ashdown era impegnato nel saggiare la disponibilità di Blair a impegnarsi in una vera alleanza politica con i liberaldemocratici. Per i quali la condizione fondamentale era la riforma in senso proporzionale della legge elettorale. O almeno l’attenuazione di quei rigidi criteri uninominali che penalizzavano oltremodo il loro partito, così come era sempre accaduto per ogni forza terza del panorama politico britannico.
La parte svolta da Blair in questo ménage non fu semplice. Da un lato era attratto dalla prospettiva di ricomporre quella che egli in cuor suo riteneva la frattura storica tra liberali e laburisti, ricostruendo quel fronte progressista spezzato dopo la prima guerra mondiale. Così come apprezzava la forza politica di alcuni temi cari al Partito liberaldemocratico e in particolare ad Ashdown, tra cui la dura critica della passività mostrata dall’Europa – e dal governo Major – di fronte alla tragedia bosniaca. Non ultimo, pesava l’elemento di indiscutibile vantaggio tattico che un’alleanza organica tra i due partiti avrebbe portato alla causa dell’opposizione nelle prossime elezioni politiche. Per tutti questi motivi, nei colloqui con Ashdown e Jenkins, Blair si spinse sino a ipotizzare un governo di coalizione con il leader liberaldemocratico nel ruolo di ministro degli Esteri. Dall’altro lato, l’impegno a garantire la riforma proporzionale della legge elettorale costituiva per lui un limite gigantesco. Che si fece sempre più invalicabile con il passare dei mesi, mano a mano che l’avvicinarsi delle elezioni del 1997 rendeva sempre più evidente nei sondaggi il vantaggio dei laburisti sui conservatori. La formalizzazione di quell’alleanza divenne sempre meno necessaria in termini tattici.
Così come divenne sempre più difficile da giustificare, per il leader laburista, dinanzi a un partito che cominciava a credere alla possibilità di tornare (da solo) al governo del paese. E che d’altra parte non aveva del tutto dimenticato che i liberaldemocratici erano pur sempre gli eredi degli scissionisti della «banda dei quattro». I colloqui con Ashdown continuarono fino alla vigilia delle elezioni, sempre meno fattivi e senza mai approdare a un vero accordo. E il sogno di sanare «lo scisma verificatosi tra le forze progressiste britanniche all’inizio del secolo» (come lo definì Blair nel corso di una telefonata ad Ashdown la notte della sua vittoria elettorale del 1997) fu riposto nel cassetto. In attesa forse di tempi migliori.
Per quanto il dialogo con il partito di Jenkins e Ashdown non producesse frutti concreti, l’attrazione verso i valori liberali rimandava a un tratto strutturale della nuova proposta politica laburista. Quella tensione verso la valorizzazione dell’autonomia individuale all’interno della comunità che voleva rappresentare – nella visione della nuova leadership blairiana – il punto di caduta di un intero decennio di rinnovamento politico. Il senso ultimo del tentativo di ricucire lo strappo tra il filone liberale e quello laburista del progressismo britannico non era tanto nella rincorsa nostalgica a un passato ormai lontano, quanto nella convinzione che gli sforzi compiuti dal Labour dal 1983 in avanti potessero trovare il loro approdo nella confluenza tra quelle due culture politiche. E dunque in una nuova sintesi, dove trovassero il proprio posto la visione del nuovo welfare disegnato da Gordon Brown come «trampolino di lancio» accanto al bisogno di una nuova politica contro il crimine; la centralità delle politiche educative come principale strumento di inclusione sociale, accanto all’obiettivo di restituire alla politica la sovranità e la capacità di mobilitazione perdute da anni.
Era una nuova mappa dei valori e delle cose da fare quella che la leadership laburista definì tra il 1994 e le elezioni del 1997. Una nuova geografia disegnata lungo le coordinate di una comunità da ritrovare, di un individuo da responsabilizzare e di una politica da rendere più forte dell’antipolitica. Questo aggregato instabile di valori e coordinate veniva tenuto insieme dal concetto di «modernizzazione», che Blair si incaricò di utilizzare nelle sue varie forme con una frequenza quasi ossessiva (uno studio del linguista Norman Fairclough su 53 discorsi del leader laburista tra il 1994 e il 1999 ha trovato 89 ricorrenze di «modern» e altre 87 di «modernise» o «modernisation»). Ma si trattava, per l’appunto, di un artificio retorico. Estremamente funzionale, perché rimandava a una «modernità» che il corpo del Labour aveva sentito sempre come cosa propria e perché intendeva schiacciare nell’angolo i conservatori di ciò che moderno non era. Ma anche abbastanza capiente e indeterminato da poter contenere una grande massa di rappresentazioni simboliche e soluzioni politiche. Tutte certamente moderne. Ma tutte, altrettanto certamente, ricavate dalla nuova leadership laburista da quanto era andato maturando all’interno del partito nel corso del passato decennio.
A quella nuova sintesi Blair aggiunse anche del suo. Con un’immagine personale orientata a massimizzare i tratti di novità e freschezza che già da alcuni anni gli avevano guadagnato l’attenzione della stampa, così come a testimoniare la propria convinzione in quei valori su cui aveva spinto il partito a schierarsi. Con una retorica pubblica che per chiarezza e forza dialettica mostrava di avere largamente beneficiato dalla sua passata esperienza di avvocato. E soprattutto con un accento tutto personale sui temi grandi e scivolosi dell’etica e della morale. Che non si faceva alcuna remora a toccare i tasti del «bene» e del «male», così come d’altra parte aveva mostrato di voler fare già da ministro ombra degli Interni quando si era trovato alle prese con l’assassinio del piccolo James Bulger. Al contrario, invece di indurlo a muoversi con più cautela su questo terreno, il nuovo ruolo di leader ne liberò ulteriormente la spinta ad argomentare le proprie convinzioni sui temi morali. Quasi a voler rivendicare fino in fondo la sua funzione di portabandiera di un nuovo blocco di valori di base, sui quali poter poggiare l’inedito profilo del Partito laburista. Senza temere di apparire posseduto da una passione morale (o invasato dal moralismo, secondo alcuni dei suoi critici). Ma, al contrario, consapevole di muoversi sul terreno minato dei grandi interrogativi, per testimoniare quell’impasto di certezze laiche e convinzioni non negoziabili che costituiva la sostanza del suo particolare «Beruf» politico.
Poteva anche apparire spiritato il Blair che nel 1995 dichiarava che «l’unica via per ricostruire l’ordine sociale è attraverso i valori forti, trasmessi attraverso la famiglia e gli individui». Ma era un leader che sapeva di rivolgersi alla sinistra, chiamata a «prendere sul serio i temi dell’etica» perché «solo i forti e i potenti sono in grado di difendersi da soli; quelli che hanno più da perdere dall’assenza di regole sono le persone deboli e vulnerabili; e le prime vittime del crollo della comunità sociale sono coloro che hanno meno». Così come sapeva di rivolgersi, al di là della sinistra, a un paese che aveva conosciuto la forza morale del thatcherismo. Venendo conquistato anche dall’energia delle affermazioni apodittiche della sua guida politica. E che negli ultimi anni – gli stessi dell’ascesa di Blair – aveva assistito al declino di un Partito conservatore guidato da un leader che non aveva mai saputo eguagliare il carisma di Margaret Thatcher. L’argomentazione di Blair voleva misurarsi idealmente con quel carisma, saltando John Major e la sua debolezza per andare a incrociare le armi direttamente con la figura che aveva plasmato lo spirito pubblico per più di un decennio. Perché la crisi del thatcherismo aveva lasciato un vuoto nel cuore morale della Gran Bretagna. Quel vuoto che Blair intendeva riempire con un’etica di segno opposto ma di eguale forza argomentativa. E laddove la Thatcher aveva decretato la morte della società, Blair annunciava al paese che «quella cosa chiamata società» rappresentava l’unica via d’uscita alla crisi della nazione. E che doveva essere rianimata anche attraverso una robusta iniezione di valori morali e comunitari.
Era un aspetto del suo disegno politico lungo il quale il leader laburista incontrava e rielaborava le idee e le convinzioni maturate negli anni della formazione personale, comprese quelle che avevano a che fare con lo spazio della religione. Uno spazio intimo e riservato per definizione, generalmente in ambito britannico e specialmente tra coloro che esercitavano la professione politica. Per i quali è sempre stato buon uso evitare riferimenti troppo espliciti alla propria fede, secondo un’antica tradizione di «understatement». Anche per questo il modo con il quale Blair si trovò a spiegare al pubblico la propria religiosità – già ampiamente annunciata dalla stampa – non fu dei più semplici. E non solo perché scelse di farlo in occasione di una ricorrenza religiosa, la Pasqua del 1996, e sulle colonne del conservatore «Daily Telegraph».
Nella riflessione in prima persona affidata a quel quotidiano – e titolata Perché sono cristiano – comparivano i riferimenti d’obbligo alle letture che avevano influenzato la sua fede (e in primo luogo all’insegnamento di John Macmurray); l’auspicio ecumenico di un dialogo sempre più ampio e intenso tra cattolici e protestanti; l’evocazione del perdono e della riconciliazione che i giorni di Pasqua ispirano in ogni credente. Ma c’era anche qualcosa di assai meno innocuo. In primo luogo un attacco al thatcherismo condotto per linee religiose ma senza ricorrere al tradizionale strumento retorico della compassione (laburista) contrapposta all’egoismo (conservatore). Ricordando il modo in cui Margaret Thatcher aveva citato la frase di san Paolo «Chi non vuol lavorare, neppure mangi» (2 Ts 3,10) a sostegno di un taglio ai sussidi di disoccupazione, Blair ne rivendicava il senso volgendolo in direzione della propria idea di responsabilità. Spiegando che «san Paolo in realtà intendeva dire che ognuno di noi ha il dovere di darsi da fare per il bene comune; che per ricevere dei benefici occorre dare e non solo prendere … che la comunità nella quale viviamo sarà danneggiata se ciascuno di noi non accetterà su di sé la propria parte di responsabilità».
Ma altrettanto particolare era l’esempio che Blair sceglieva di prendere dall’iconografia religiosa per illustrare la propria rappresentazione dell’intreccio tra religione e politica. Quell’esempio era Ponzio Pilato, «figura straordinariamente affascinante perché così umano e imperfetto, lacerato tra principi e realtà politica». Di più: secondo Blair era «possibile vedere in Pilato una sorta di archetipo del politico, colto in mezzo ai termini conflittuali di un classico dilemma politico. Noi sappiamo che le sue azioni furono sbagliate. Ma sappiamo anche che la storia ci ha sempre proposto un conflitto tra ciò che è giusto e ciò che è opportuno … E non sempre è chiaro, neanche in retrospettiva, dove sia davvero il giusto. Il dilemma è sempre uno solo: è necessario fare ciò che appare giusto e corrispondente ai princìpi o ciò che risulta politicamente opportuno? È necessario applicare un valore di moralità assoluta o un criterio di utilità relativa?». Non sarebbero passati molti anni prima che quel dilemma si presentasse concretamente dinanzi a Blair, negli stessi termini in cui lo aveva prefigurato allora. Riferendosi a Ponzio Pilato, ma forse già pensando a se stesso.
Fu lungo queste coordinate politiche e personali, nel corso dei due anni successivi alla sua elezione a leader, che Tony Blair affinò la nuova mappa dei valori con la quale il Partito laburista si sarebbe predisposto alla prova del 1997. E mentre si faceva più netto il profilo delle idealità su cui si sarebbe giocata la partita con i conservatori, il nuovo gruppo dirigente del Labour si concentrava sul messaggio da trasmettere al paese. Un compito reso più facile dalla potente spinta favorevole di cui poté beneficiare quella nuova leadership nella sua fase iniziale. L’effetto di immagine ricavato dalla nomina di un «giovane capo che finalmente parla chiaro» alla guida di un partito che nella percezione pubblica non si era ancora del tutto liberato dalle ombre del passato, fu tale da provocare quella che John Rentoul ha definito una «bolla speculativa di consenso». Tanto forte da indurre i sondaggi, già alla fine del 1994, a quotare il Labour a un improbabile 61% di preferenze tra gli elettori. Ma anche da provocare una reale impennata nell’afflusso di nuovi militanti o nel ritorno di chi si era allontanato dal partito. Con il risultato di portare il numero degli iscritti al Labour, in pochi mesi, da 260.000 a 330.000.
Si trattava di un capitale potenziale che doveva essere utilizzato al più presto. E che la nuova leadership decise di spendere in due colpi di teatro di grande valore simbolico, realizzati all’interno del partito ma rivolti a tutto il paese. A significare la determinazione a muoversi lungo i binari di un’irreversibile innovazione di immagine e contenuti. Il primo fu il lancio dell’espressione «New Labour» come nuova denominazione ufficiosa del partito. Il secondo fu la cancellazione della celebre «Clause IV» dello statuto sugli obiettivi strategici del partito in materia di proprietà dei mezzi di produzione – nella sua versione originaria, mai modificata dopo il 1918 – e la sua sostituzione con una ben diversa formulazione. Autentici colpi di mano, per quanto veicolati all’approvazione molto ampia del partito, che Blair concepì nel corso della sue prime vacanze estive da leader. Che trascorse per una buona parte dell’agosto 1994 in Lunigiana nei dintorni di Aulla, ospite dei genitori di Tim Allan, dove mise a punto il piano che avrebbe realizzato alla ripresa autunnale. Tale piano avrebbe avuto il suo momento decisivo all’apertura della conferenza di partito, l’appuntamento annuale previsto quell’anno per l’inizio di ottobre. Per Blair sarebbe stata la prima occasione per presentarsi, nelle nuove vesti di leader, dinanzi a un partito che lo aveva appena scelto con un ampio margine di consensi ma che doveva ancora esserne conquistato.
I delegati che il 2 ottobre 1994 entrarono nel salone di Blackpool dove si apriva la conferenza si trovarono dinanzi al solito, enorme fondale. Questa volta di un bizzarro colore pistacchio. Ma soprattutto dominato dalla scritta NEW BRITAIN, NEW LABOUR. Qualcosa di più di uno slogan, qualcosa di meno di un vero e proprio nome nuovo per il partito. Scelto nelle settimane precedenti attraverso una defatigante discussione interna al gruppo dei più stretti collaboratori di Blair, con alcuni (Mandelson e Gould) che suggerivano formule meno dirette come LABOUR’S NEW APPROACH. La paternità della versione definitiva fu di Alastair Campbell, evidentemente ispirato dalla tensione giornalistica a ricercare sempre il titolo più efficace e attraente. Perché tale era quella formulazione, non a caso destinata a sopravvivere sostanzialmente intatta per oltre un decennio. Un titolo che allora, a meno di due anni dalla vittoria di Clinton, rimandava ancora una qualche eco dei New Democrats che avevano conquistato la Casa Bianca. Ma che alle centinaia di delegati che se lo trovarono di fronte in quella sala, senza esserne stati avvertiti, dovette trasmettere immediatamente il senso di qualcosa di irreversibile che stava accadendo al loro partito. Quello slogan – e la buona accoglienza che ricevette da una platea che in passato non aveva mai temuto di fischiare i propri leader – furono solo la prima sorpresa della conferenza. Perché il discorso di Blair – un vero capolavoro di retorica, rivolto a «quei genitori che vogliono che i propri figli studino in aule che non cadono a pezzi», a «quegli uomini e a quelle donne che si svegliano al mattino e scoprono per l’ennesima volta che qualcuno è entrato nella loro cucina per rubare il televisore», a «quei pensionati che hanno paura di uscire di casa» – si concluse con una lunga tirata sulla necessità che il Partito laburista «dicesse la verità su ciò che intendeva fare e realizzasse davvero ciò che intendeva fare».
Cosa significava? Niente di più e niente di meno dell’annuncio di una proposta rivoluzionaria: il cambiamento del punto dello statuto laburista che dal 1918 in avanti aveva stabilito che ogni governo laburista avrebbe dovuto «garantire ai lavoratori manuali e dell’ingegno il pieno godimento e la più giusta distribuzione dei frutti della propria fatica, sulla base della proprietà comune dei mezzi di produzione, distribuzione e scambio». Ovvero la nazionalizzazione come orizzonte strategico delle politiche economiche laburiste. Codificata in un precetto programmatico che al suo primo apparire aveva avuto l’obiettivo di marcare tutta la differenza possibile dai liberali, dai quali i laburisti si erano appena separati. Ma che con il passare degli anni aveva assunto le sembianze di un totem inattaccabile, sul quale si erano già infranti nel 1959 i propositi di modifica del leader Hugh Gaitskell.
Idealmente, Blair riprese il discorso da quel tentativo fallito. Mettendo il partito dinanzi all’esigenza primaria di «dire la verità» su ciò che si era e su ciò che si aveva intenzione di fare al paese. Quella verità non coincideva più – e da tempo – con l’orizzonte delle nazionalizzazioni. Ma era il momento di metterla nero su bianco, «in termini tali da non poter essere equivocati dal pubblico e da non poter essere volontariamente stravolti dai conservatori». Era un approccio ragionevole e assai poco ideologico alla questione della «Clause IV». Che tuttavia, per la carica identitaria che questa aveva assunto nel corso degli anni, non poté evitare l’opposizione di un fronte non irrilevante all’interno del partito. Dove la sinistra tradizionale si trovò alleata a una parte della cospicua rappresentanza di provenienza sindacale. E persino ad alcuni esponenti della vecchia scuola revisionista come Roy Hattersley, che iniziò da allora a polemizzare con Blair. Tuttavia il colpo riuscì, anche per la forte spinta positiva su cui poteva contare la nuova leadership. E alla fine di una consultazione capillare del Labour, formalizzata nel corso di una successiva riunione plenaria dei delegati, il 65% del partito sostenne una nuova formulazione che archiviava il totem delle nazionalizzazioni scolpito da Sidney Webb quasi ottant’anni prima. Sostituendolo con una formulazione scritta di proprio pugno da Blair e intrisa della sua fede nelle virtù della comunità e della responsabilità: «Il Partito laburista è un partito socialista democratico, convinto che attraverso i nostri sforzi congiunti si possa ottenere più di quanto non sia possibile fare da soli; che sia necessario dare a ognuno gli strumenti per realizzare le proprie potenzialità e a tutti noi una comunità nella quale il potere, il benessere e le opportunità siano nelle mani dei molti e non dei pochi. Dove i diritti di cui godiamo riflettano i doveri che abbiamo. E nella quale sia possibile vivere insieme, liberamente, in spirito di solidarietà, tolleranza e rispetto».
Blair aveva fretta. Non poteva contare sui dieci anni della leadership di Neil Kinnock. Né si sentiva al riparo dalla possibile ripresa di iniziativa dei tory, che per quanto colpiti dal «mercoledì nero» del 1992 e appesantiti dalla debole guida di Major potevano ancora fare affidamento sul sostegno potenziale della maggioranza del paese. La «bolla speculativa» di consenso si sarebbe potuta sgonfiare nel giro di breve tempo. Anche per questo i due colpi di mano sul New Labour e sulla «Clause IV» erano venuti ben prima dei suoi cento giorni da leader. Con l’obiettivo di imprimere al Labour uno shock irreversibile. Ma soprattutto di liberarsi rapidamente dei «conti di bottega» lasciati aperti dal passato, per poter finalmente parlare al paese. Quel paese attendeva di esaminarlo, con animo benevolo ma non meno severo del solito. E alla Gran Bretagna Blair rivolse un’argomentazione destinata a incardinare il percorso laburista verso le elezioni.
Quello che serviva al paese – cominciò a dire già in quella sua prima conferenza di partito da leader – era una nuova coesione nazionale. Che sanasse le divisioni inflitte alla società e alla comunità civile dal ventennio thatcheriano. Non tanto attraverso il ritorno al giorno prima dell’avvento di Margaret Thatcher – l’obiettivo velleitario e resistenziale sul quale si era attestato il Labour nei primi anni Ottanta – ma con una nuova prospettiva di innovazione e unificazione civile che puntasse a fare della Gran Bretagna «una nazione di nuovo giovane».
«One Britain, young country», fu questo il temario essenziale della lunga campagna politica lanciata nel paese da Blair all’indomani della sua nomina a leader e fino alle elezioni del 1997. Era l’eco del bisogno di coesione che aveva spesso attraversato quella società così tradizionalmente corporativa e tanto rigidamente compartimentata. Formalmente si trattava di una citazione dallo slogan «One Nation» coniato dal conservatore Benjamin Disraeli più di un secolo prima. Ma nella versione di Blair rimandava allo spirito del 1945, a quel senso di missione comune che aveva spinto il «miglior governo laburista di sempre» a misurarsi con l’obiettivo di ricomporre la nazione attorno a un progetto di rinnovamento. Alla vigilia delle elezioni del 1997 equivaleva alla consapevolezza di avere a che fare con un paese che era certamente più ricco che in passato, ma anche molto più diviso e insicuro al proprio interno di quanto non fosse mai stato: «Siamo nati con il welfare state e il servizio sanitario nazionale e siamo cresciuti nell’economia di mercato dei conti correnti bancari e dei supermarket. Abbiamo avuto in tasca soldi che i nostri genitori non conobbero mai. Abbiamo goduto di migliaia di privilegi in più di qualsiasi altra generazione del passato, eppure soffriamo di un grado di insicurezza interiore e di una condizione di dubbio spirituale mai conosciuti prima».
Quello che serviva alla Gran Bretagna era una nuova stagione di giovinezza: spirituale e culturale, ma soprattutto declinabile in un nuovo primato di tutta la nazione. Economico, produttivo, educativo. Perché oggi erano i laburisti a rivendicare per sé il ruolo di portavoce del «patriottismo del futuro», rivolgendo un messaggio di incitamento e rassicurazione a un paese che rimaneva ossessionato dallo spettro del declino. Quello spettro che gli anni ruggenti del thatcherismo avevano dato l’impressione di poter sconfiggere, salvo farlo riapparire dopo pochi anni sotto forma di una gravissima crisi economica e finanziaria. Il «mercoledì nero» del 1992, con la svalutazione della sterlina e l’esplosione dei tassi di interesse fino al 15%, aveva svelato la natura fittizia delle strategie di crescita liberista perseguite dai tory. La fragilità del «boom and bust» thatcheriano, sotto il quale covava la minaccia della recessione rivelata all’inizio degli anni Novanta. La risposta del New Labour a quella fragilità era in una strategia di crescita che unisse innovazione economica e coesione sociale, mercato e comunità: «I tory hanno fallito» argomentava Blair «perché non capiscono che una nazione, così come una comunità, deve lavorare insieme per permettere agli individui di avere successo … I tory pensano che sia indispensabile scegliere tra l’interesse individuale e l’interesse della società nel suo insieme, ma in realtà l’interesse individuale richiede che la comunità lavori tutta insieme per raggiungere gli obiettivi che non possiamo ottenere da soli».
L’evocazione di un patriottismo coesivo, capace di tenere insieme la valorizzazione dell’interesse nazionale con le virtù della comunità e lo spirito d’iniziativa economia, fu lo strumento fondamentale che permise a Blair e al Partito laburista di dominare il discorso pubblico dal 1994 al 1997. Era una retorica capace di mettere in evidenza le debolezze dell’avversario conservatore senza rinchiudersi in un catastrofismo che avrebbe finito per spaventare ulteriormente un paese già tramortito dalla crisi del 1992. Permetteva a Blair di rivendicare il nucleo vitale della tradizione laburista, quello che aveva presieduto al grande disegno del welfare postbellico e che oggi si ritrovava nell’esigenza di restituire a un paese insicuro e indebolito il senso di una missione condivisa. E allo stesso tempo forniva al New Labour tutto lo spazio necessario per articolare la sua visione dell’innovazione economica, fatta anche di liberalizzazioni e riduzione della pressione fiscale.
All’interno di questa ampia cornice ideale trovarono posto le diverse proposte politiche laburiste. A partire dall’investimento nelle politiche educative, che per Blair doveva rappresentare il criterio principale di ogni strategia di rinascita economica. Per arrivare agli obiettivi di contenimento dell’inflazione, di controllo rigoroso della spesa pubblica (con l’esclusione di prestiti che non fossero rivolti a finanziare gli investimenti), di riforma del servizio sanitario nazionale e del sistema scolastico. Una massa di impegni che avrebbe infine preso la forma di un manifesto elettorale contenente ben 229 punti di programma. Una pletora di promesse che sarebbe servita a poco, se l’argomentazione propriamente politica della leadership laburista non avesse occupato saldamente il campo del confronto pubblico nei tre anni precedenti le elezioni. Mentre i sondaggi dal 1994 in avanti andarono confermando sempre più nettamente il vantaggio laburista, i conservatori si ritrovarono via via costretti in un angolo. Reagendo all’iniziativa laburista con l’appello a una confusa «Britishness» – che avrebbe dovuto rimandare al senso di appartenenza nazionale ma che finì per essere declinata in termini sciovinistici – o con la radicalizzazione della polemica antieuropea.
Quando il 17 marzo 1997 John Major sciolse il Parlamento annunciando che le elezioni politiche si sarebbero tenute il 1° maggio, il Labour era pronto da tempo a far partire la campagna elettorale più disciplinata e meticolosa della sua storia. Con diciotto anni di opposizione alle spalle e tutti i sondaggi per la prima volta a proprio favore, niente poteva e doveva essere lasciato al caso: «Sarebbe un eufemismo descriverci come nevrotici» ha scritto Peter Mandelson rievocando quei giorni. «Nessun particolare era tanto piccolo da non meritare attenzione; nessun giornalista era tanto oscuro da non dover essere corteggiato; nessuna voce dissonante era tanto debole da non suscitare la nostra preoccupazione.»
Il 17 marzo Tony Blair si fece trovare in visita a una scuola, a marcare simbolicamente il punto di partenza del temario politico laburista, da dove rilasciò la prima intervista propriamente elettorale. Dal giorno dopo entrò in piena attività la nuova centrale operativa del partito collocata nella Millbank Tower: una sorta di bunker militare, modellato sulla «War Room» di Little Rock dalla quale nel 1992 era stata coordinata la campagna di Bill Clinton. Un bunker rigorosamente organizzato in dipartimenti operativi e retto autocraticamente da un comitato di indirizzo composto da Philip Gould, Peter Mandelson, Alastair Campbell e da pochi altri colonnelli che si riunivano per fare il punto alle sette del mattino di ogni giorno. Ora per ora il computer «Excalibur» teneva traccia del quadro d’insieme e dei diversi particolari della campagna; giorno e notte la «cellula di reazione rapida» era in grado di predisporre nel giro di poche decine di minuti le linee guida a cui avrebbero dovuto attenersi tutti gli esponenti laburisti nel rispondere a ogni notizia o evento minimamente significativi. Era passato del tempo da quanto il partito di Michael Foot rifiutava di adattarsi alle esigenze della comunicazione televisiva. E quindici anni di campagne elettorali, sempre perdenti ma via via più precise e professionali nell’uso delle tecniche di comunicazione politica, avevano finalmente prodotto un modello di mobilitazione che avrebbe fatto scuola anche fuori dalla Gran Bretagna.
Fu una campagna tanto meticolosa quanto ispirata alla massima cautela. Rassicurare il paese, sopire ogni possibile accusa di inaffidabilità, prevenire qualsiasi colpo di coda dei conservatori che puntasse sul residuo sentimento di diffidenza che una parte della Gran Bretagna covava nei confronti del Labour. La leadership laburista aveva ancora negli occhi l’immagine della prima pagina del «Sun» uscito alla vigilia delle elezioni del 1992: «Se Kinnock vincerà, l’ultimo a uscire dalla Gran Bretagna si ricordi di spegnere la luce». Era stato il colpo di grazia per le speranze della sinistra. Nel 1997 doveva essere eliminato alla radice qualsiasi possibile punto di appoggio per un attacco alla presunta inaffidabilità del Labour. E se il primo triennio da leader di Tony Blair era stato ispirato al massimo radicalismo, le ultime settimane prima della sua elezione a primo ministro furono dominate dalla massima circospezione. Tanto da spingerlo a flirtare con ogni componente dell’opinione pubblica britannica. Compresa quella dell’antieuropeismo irriducibile, al quale si rivolse nel giorno di San Giorgio sostenendo che un altro dragone che il santo patrono inglese avrebbe dovuto trafiggere era quello rappresentato oggi dal «superstato europeo».
Tanta cautela e accortezza ebbero comunque l’effetto di impedire qualsiasi crepa significativa nel blocco di consenso con cui il Partito laburista era arrivato al momento del voto. Il 1° maggio 1997 consegnò al Labour una maggioranza vastissima, di gran lunga superiore a ogni sua precedente vittoria elettorale, con il 44,4% dei suffragi e 419 parlamentari eletti contro i 165 dei conservatori. Che con il 31,5% dei voti erano stati costretti al loro peggior risultato dal 1832, perdendo quasi duecento seggi considerati «sicuri» (compresi quelli di ben sette ministri del governo Major). Gli analisti elettorali avrebbero poi verificato uno spostamento massiccio dell’opinione pubblica, nell’ordine di più del 10% di voti passati dalla destra alla sinistra.
Tony Blair arrivò a Londra molto oltre la fine di quella giornata, trascorsa nel collegio elettorale di Sedgefield insieme alla sua famiglia e a quella di Cherie, quando i dati degli exit poll stavano confermando l’entità sempre più imponente della vittoria. All’alba del 2 maggio raggiunse la festa laburista in corso già da qualche ora a South Bank: «Abbiamo sempre detto che se avessimo avuto il coraggio di cambiare ce l’avremmo fatta. Oggi ce l’abbiamo fatta … Siamo stati eletti come New Labour e governeremo come New Labour».
Stava per compiere quarantaquattro anni e sarebbe stato il più giovane primo ministro britannico dal 1812. Ma soprattutto portava su di sé le aspettative di un partito che era rimasto lontano dal potere di fare per quasi vent’anni, e di un paese che gli aveva affidato un capitale di consenso del tutto inedito. Un carico di attese e speranze che pochissimi prima di lui avevano portato sulle spalle. Quello stesso carico che qualche giorno prima aveva fatto dire a un gruppo di notabili laburisti, riunitisi per una birra alla fine di una lunga giornata di campagna elettorale all’insegna dell’entusiasmo per l’imminente vittoria: «Tutto questo svanirà, finiremo per scontentare tutti. Ci vuole tempo per cambiare e la gente diventerà impaziente. Così vanno le cose».