La pioggia e Zanzotto
Pensieri sul poeta morto venti giorni fa, sul Veneto di Brunetta e Paniz e Ghedini, sulla Liguria delle alluvioni
di Filippomaria Pontani
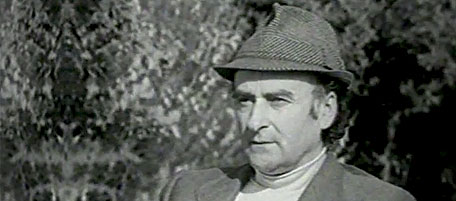
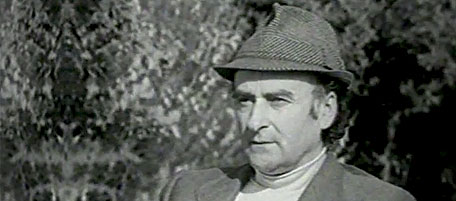 Venti giorni fa è morto a Conegliano Andrea Zanzotto, che con i suoi novant’anni appariva a molti – secondo una formula troppe volte abusata per questo e per quello – “il più grande poeta italiano vivente”. Le commemorazioni sulla stampa hanno per lo più declinato il registro dell’intimo (quante memorie delle visite alla sua casa di Pieve di Soligo) o del critico-criptico (oltranza del significante, arbitrarietà del segno, instabilità del sema, esperienza del logos, e così via). Del resto, almeno a partire dalla raccolta La beltà (1968) la poesia di Zanzotto è stata senz’altro fra le più difficili del nostro tempo.
Venti giorni fa è morto a Conegliano Andrea Zanzotto, che con i suoi novant’anni appariva a molti – secondo una formula troppe volte abusata per questo e per quello – “il più grande poeta italiano vivente”. Le commemorazioni sulla stampa hanno per lo più declinato il registro dell’intimo (quante memorie delle visite alla sua casa di Pieve di Soligo) o del critico-criptico (oltranza del significante, arbitrarietà del segno, instabilità del sema, esperienza del logos, e così via). Del resto, almeno a partire dalla raccolta La beltà (1968) la poesia di Zanzotto è stata senz’altro fra le più difficili del nostro tempo.
Non potendo vantare una conoscenza diretta della sua colta e semplicissima loquela (ritratta mirabilmente da Marco Paolini e Carlo Mazzacurati in un film del 2000), vorrei allineare qui quattro motivi a mio giudizio precipui e attuali che hanno contribuito a determinare la sua fama singolare, il suo status d’eccezione nel panorama locale e nazionale.
a) Zanzotto aveva scelto un angolo della Marca Trevigiana come centro del suo universo, covando la sua trasformazione in metonimia, in antonomasia di una certa esperienza del mondo e della storia. Questa scelta è stata inusuale, pareggiata forse solo da quella di un altro grande Veneto, Luigi Meneghello, il quale pur nell’esilio inglese non ha fatto che gravitare con la sua arte attorno al villaggio vicentino di Malo. In un’epoca in cui gli scrittori (e i rari poeti), anche quando protestano ligia fedeltà alle radici, s’impongono sempre più come cittadini del mondo protesi verso le metropoli e i media e i festival, il movimento centripeto di Zanzotto ha incarnato un paradigma diverso: per lui, ragionare con contiguità fisica sulle foglie, le erbe, le ife del Montello, sulle epigrafi dei municipi e sugli ossari, sulla memoria minuta del popolo e dei luoghi, era un po’ l’unica chiave per stare al mondo, e per cercare di capirlo.
b) Zanzotto, con il suo fare schivo e alieno da ogni proclama, aveva legittimato un certo tipo di identità veneta, anzitutto culturale e linguistica, dandole notorietà e nel contempo rinnovandola, sottoponendola a una critica arguta, talora spietata. Indagatore del dialetto, sia quello “colto” che sperimentò in parte nel Casanova di Fellini sia quello “materno” e talora “infantile” di cui sostanziò le sue liriche più sentite, egli mise in pratica un’accezione dell’idioma natío come “sovrabbondare sorgivo o stagnare ambiguo” (sono parole sue), come “vertigine del passato” oratoria, oracolare e quintessenzialmente orale; un’accezione al contempo progressiva e ancestrale diametralmente opposta rispetto a quella becera e vendicativa di chi sulle radici di presunte storie e di false etimologie ha innestato settarismi e mistificazioni, “bislacche nostalgie e approssimazioni mitologiche”.
c) Anche chi – come la gran parte di noi – non aveva i mezzi culturali e intellettuali per penetrare la ricca allusività dei testi di Zanzotto, sentiva che quello scrivere difficile non era frutto di manierato alessandrinismo o di ludica ironia (come forse avvenne nell’individualismo di alcuni dei Novissimi), bensì di uno scandaglio inesausto e doloroso della lingua e della realtà. Chiunque guardi al leopardismo ancora ermetico di Vocativo (1957) o in parte delle IX Ecloghe (1962) non potrà dubitare della sincerità della svolta espressiva che negli anni seguenti ha portato progressivamente nella poesia di Zanzotto immagini, segni stradali, diagrammi, onomatopee, balbettíi, inserti alloglotti, citazioni peregrine, segni d’inconscio, accanto alle televisioni e ai topinambùr. E sentirà sotto ogni verso, anche il più aspro o inatteso, la tensione etica dell’antico partigiano, vissuto in terre sconvolte da due guerre mondiali fin dentro la geografia e la toponomastica.
d) A partire dalla prima raccolta (Dietro il paesaggio), Zanzotto legò la sua attività poetica e la sua persona pubblica all’osservazione del paesaggio veneto, dei suoi mutamenti, della sua storia e della sua perfezione, delle sue bellezze e infedeltà, denunciando fino all’ultimo dei suoi giorni (e soprattutto negli anni più vicini a noi) “l’erosione fisica del territorio attraverso diverse forme di degradazione macroscopica dell’ambiente”.
Premuto dall’attualità, vorrei indugiare un poco su quest’ultimo punto, perché credo che serva a illustrare un certo concetto (non l’unico, beninteso) di “utilità” della poesia. “In questo progresso scorsoio / non so se vengo ingoiato / o se ingoio” scrisse il poeta in uno dei suoi ultimi epigrammi (che dà il titolo a una conversazione con Marzio Breda, edita da Garzanti nel 2009): senza voler fare di lui un no-global (sebbene echeggino forti i suoi anatemi contro il “fondamentalismo globalista” e le conseguenti “slogature culturali”), ricordo come la sua attenzione spasmodica alla natura comportava l’ipersensibile ostilità verso una certa idea spregiudicata di progresso che trascinava con sé un’ineluttabile desertificazione dei rapporti umani. Non si trattava di ottuso misoneismo, ché anzi Zanzotto s’interessava come pochi (e non di rado tramite letture specialistiche) alle novità della scienza e della tecnica, alle scoperte che influenzavano la nostra vita e il nostro benessere. A lui stava a cuore la pericolosa china del consumismo occidentale, e più in particolare la guida di una terra difficile, dove le polveriere del Montello e le armi nucleari di Aviano trovano un séguito nella base dal Molin di Vicenza, dove lo sfacelo urbanistico e ambientale di Marghera minaccia di coronarsi nella cementificazione di Tessera e della gronda lagunare. L’ambiente e gli uomini, insomma.
Perché il Veneto è una terra che per anni si è lamentata di non avere un’adeguata rappresentanza politica, e ora ha prodotto una classe dirigente folta e rancorosa, per lo più ignara della “bontà” dei Veneti d’antan, e segnata alternativamente da due caratteri sostanziali della venetudine, il servilismo al padrone e la boria incattivita. Da queste terre provengono, per fare gli esempi più ovvi, i favoriti di Paniz, i mavalà di Ghedini, le tetre minacce di Sacconi, i ghigni ringhiosi di Brunetta, le cardinalizie camarille di Galan (per non parlare di fenomeni-limite, anche sul mero piano linguistico, come gli ultimi due sindaci di Treviso). Questa antropologia del potere si può spiegare come emergenza in alto loco di quella che Zanzotto dipingeva come la “mentalità veneta rosea e tabaccosa, che pur sotto questa specie di sonnolenta (o pimpante) bonarietà cela talvolta inflessibili durezze padronali”. Del resto, in tempi non sospetti, il poeta mise in exergo a uno dei suoi testi più potenti un rapido, quasi profetico scambio di battute:
«Ti piace essere venuto a questo mondo?» Bambino: «Sì, perché c’è la STANDA»
(Sì, ancora la neve, in La Beltà, 1968).
Dietro il paesaggio sta l’umanità che lo modella, che lo stravolge, sta un’idea di futuro che troppe volte, qui a Nordest, si è tradotta in mero sfruttamento dell’esistente (lo dicemmo, in occasione delle alluvioni dell’anno scorso, con dovizia di particolari ), e sta quindi la fin troppo facile metafora del “qui viene già tutto”, “siamo immersi nella palude” (“la ne sbandona zó inte’l palù / tuto se scòla, no ghe xé più”: A. Z., Recitativo veneziano, in Filò, 1976). Forse oggi chi conoscesse dall’interno la situazione edilizia e politica della Liguria potrebbe essere tentato dall’applicazione di affini categorie di analisi anche a quella terra, nonostante la storia diversa e la diversa antropologia. Sotto giunte d’ogni colore, i diluvi come carri armati (“sotto i cingoli dei diluvi / spaccate in frane / e crollate qua e là le colline”: A. Z., Conglomerati, Milano 2009, 194). Non più gli epici acquazzoni sull’eterno campo da rugby di Marco Paolini, né “le piogge che a novembre / lavano i cani di gesso / dei villini e le lische delle bisce” (F. Fortini, A un amico di Lerici, 1982). Piuttosto l'”impenetrabile fangore dell’aria” (Cesare Ruffato, La nave per Atene), o quelle “piove sensa requie” che oggi descrive uno dei più attenti studiosi e ammiratori di Zanzotto, Gian Mario Villalta, nel miglior libro di poesia pubblicato quest’anno (“De qua na montana de scuro / e l’è nda’ soto romai la luna e mesi e intiere / staión: sta su el let, la scala, la cusina / co la so luse amara”: da Vanità della mente, Milano 2011, Premio Viareggio).
Alcuni troveranno consolazione nel fatto che le alluvioni, in Italia, ci sono sempre state, che Veneto (1951; 1966) e Liguria (1970), per tacere delle altre, sono regioni d’acque, dove la negoziazione con l’elemento liquido è costante e molteplice (“Quali gradini di prudenza cingevano / Custodivano e iscrivevano il loro patto / Su questa cala, stretto punto d’appoggio / Fra tempesta e sereno”: C. Tomlinson, Vernazza, 1999). Altri invece penseranno – come mi suggerisce l’amico geografo Francesco Vallerani – che la precisa regolazione dei fossi della Serenissima è stata negli anni colpevolmente trascurata, e sostituita al più da interventi puntiformi talvolta addirittura controproducenti quando ignoravano la realtà più ampia del sistema-bacino; o penseranno che – come mi suggeriva anni fa Cesare Garboli – negli ultimi decenni la costa della Versilia e del Levante è stata irreversibilmente deturpata e dissestata dalla cementificazione, da Viareggio al Cinquale, da Sestri a Nervi. Non ci vuole l’Istituto superiore per la Protezione e Ricerca ambientale per sapere che questa è la condizione di buona parte del Paese; e ha qualcosa di osceno il fatto che la denuncino oggi (“forse si è costruito dove non si doveva”) gli stessi baldanzosi autori dei condoni edilizi e dei piani-casa, peraltro pronti domani, sull’onda dei rescritti europei, ad alienare al lìbito dei privati altre migliaia di ettari agricoli.
“E chi per profitto vile / fulmina un pesce, un fiume, / non fatelo cavaliere / del lavoro. L’amore / finisce dove finisce l’erba / e l’acqua muore. Dove / sparendo la foresta / e l’aria verde, chi resta / sospira nel sempre più vasto / paese guasto: «Come / potrebbe tornare a esser bella, / scomparso l’uomo, la terra»” (G. Caproni, Versicoli quasi ecologici, in: Res amissa, 1972-88).
Forse, al di là dei fatti singoli e della retorica, si potrebbe convenire sul fatto che è mancata (o è stata insufficiente) una manutenzione ordinaria, una difesa della norma, anche quando gli studi di tanti istituti e di tante accademie l’avevano definita con precisione, come avvenne con i Piani di assetto idrogeologico del 2005, rimasti per lo più inattuati per mancanza assoluta di risorse. Come se la conservazione di “questa artificiosa terra-carne” (A. Z., Esistere psichicamente, in: Vocativo, 1957) fosse cosa scontata e a sé, non meritevole di investimenti o di progetti; come se con canali e scolmatori non si vincessero le elezioni, mentre fosse più facile spuntarla sbandierando Ponti sullo Stretto o fantomatici Gran Premi: “mentre si mutano segnaletiche / ed etiche di operazioni e disperazioni / ormai fuori portata di furti umani / succhiate in altre risacche, in altri cloni” (A. Z., Sovrimpressioni, Milano 2001, 58). Qui come altrove, è il senso del funzionamento ordinario che si è perso, non beninteso nell’opera dei tanti che tengono in piedi la baracca prodigandosi in esso ogni giorno, ma nella rappresentazione pubblica che non cessa di deprimerlo a vantaggio dell’eccezione, dell’eccezionale, del super. Ma l’importanza del modesto funzionamento ordinario i poeti spesso la conoscono, se è vero che Zanzotto lavorò per anni come maestro di scuola media, così come Caproni insegnò una vita alle elementari, e oggi Villalta (che pure dirige quel complesso evento che è Pordenonelegge) è professore di liceo. Di quella umile Italia…
In fondo forse è per una strana pietas del destino che all’anziano poeta di Soligo è stato risparmiato l’estremo spettacolo della devastazione ligure, il fango che ha travolto prima la culla della poesia italiana del Novecento (la casa dei Doganieri, punta del Mesco, il nido rugginoso di Corniglia, l’accelerato di Monterosso), e poi la sua metropoli (“Genova di piovasco, / follia, Paganini, Magnasco”). Narrano le cronache che dopo i fatti delle Cinque Terre il governatore del Veneto abbia telefonato al suo collega ligure per mettere a disposizione il know-how tecnico-giuridico maturato negli allagamenti di pochi mesi fa. Chissà se i due si saranno scambiati anche qualche indicazione di lettura: il Genovese avrebbe avuto dalla sua almeno i versi dell’altro anziano poeta (scomparso un anno fa: la “vecchia guardia” del Novecento è ormai tutta nei Campi Elisi), che proprio dove ora sono le acque, “sopra l’asfalto dei lungobisagni”, meditava sull’eredità di Pier Paolo Pasolini:
ci guarda con occhio tetro (un occhio stravecchio di vetro), la triste Gaia:
(un occhio di multimammia massaia): (un occhio di menagramoso malocchio, di maligna
matrigna): (un malandatissimo occhio inquinato: un occhio economico, un logico occhio
ecologico): così lei ci guarda, lei noi: gli eliminabili mangiaminestre suoi labili:
(Edoardo Sanguineti, Il gatto lupesco, Milano 2002, 238).



