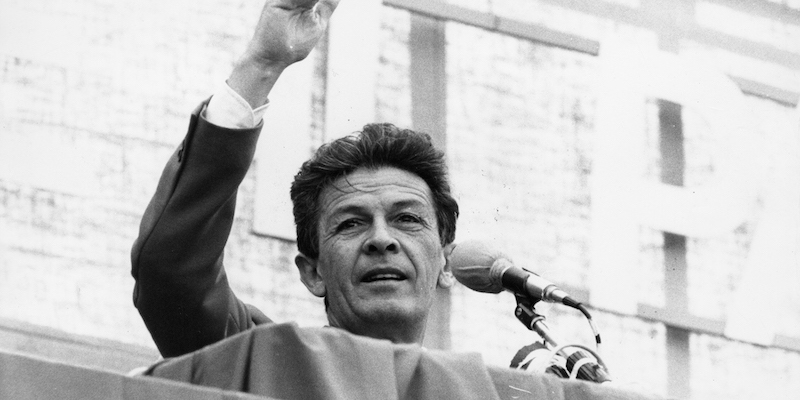Il Veneto causa del suo mal
Quello da cui nascono i disastri geologici dei giorni scorsi ha un nome sociologico: si chiama "privatopia"
di Filippomaria Pontani

Come quando fuori piove. Il film di Monicelli (1999) è ambientato a Cittadella, nel Veneto profondo; e parla di gioco d’azzardo, di lotterie, di ipocrisie, dell’etica declive di questa terra. Nel Veneto profondo è piovuto per quattro giorni, con poche soste. Per qualche ora, se n’è parlato anche sui giornali nazionali; ma lo stesso sig. Zaia paventa ciò che ineluttabilmente avverrà, ovvero la riduzione del cataclisma alle dimensioni dell’allagamento di una cantina; meglio ancora, di una taverna.
Chi abita a Venezia, che non è Veneto profondo, percepisce sul viso il caldo dello scirocco e si spiega d’emblée l’acqua alta di ieri, quelle che verranno: la prima cosa che si racconta ai “foresti” è che l’acqua alta non dipende dalla pioggia, che è invece un fenomeno legato alle maree e a un gran numero di variabili in larga parte non meteorologiche; e infatti capita di sentire la sirena (codice giallo, codice arancio; codice rosso, perfino, come il primo dicembre dell’anno scorso) anche quando fuori c’è un sole a palla.
Dunque al diavolo le foto di Venezia con l’acqua alta. Alta è la temperatura che si sente anche in Laguna, e che ha sciolto le nevi fresche sui monti, e tutta quell’acqua, lassù, aumentata strada facendo dalla pioggia insistente, doveva pure venire giù in qualche modo. Che modi. Vicenza sott’acqua, Padova lambita, le campagne a mollo, gli ospedali evacuati, le strade interrotte. In un paese aduso a Giampilieri, a Sarno, ad Atrani, o alle periodiche esondazioni della Versilia, il fenomeno passa nel taglio basso, come erba da accorpare al fascio degli episodi analoghi (ormai dozzine negli ultimi anni) tra Pordenone, la Marca, il Polesine, il Veronese. E le immancabili geremiadi contro il dissesto idrogeologico vengono lasciate alle immancabili cassandre, ai menagrami che al prossimo giro diranno l’avevamo detto.
Ma forse il caso presente, con gli scantinati del Teatro Olimpico a mollo e le viuzze palladiane fatte canali, può rappresentare un’occasione per ricordare, sobriamente, laicamente, che non siamo soltanto in balìa di Giove Pluvio; che anche lontano dalle trame speculative della camorra, della mafia, delle bande notoriamente irrispettose del terreno (o territorio?) sul quale insistono, anche qui sono stati compiuti negli anni degli errori, nei quali si persevera pervicacemente. Non si può ridurre la questione – come fanno alcune opposizioni – al recente taglio dei fondi nazionali e regionali per il restauro idrogeologico delle aree più a rischio (tra le quali, singolarmente, proprio Vicenza); né denunciare – come pure è doveroso – l’insofferenza di alcuni settori dell’ormai ventennale governo destrorso veneto verso i consorzi di bonifica, che svolgono un’insostituibile anche se non sempre efficace funzione di tutela “sul territorio” (la formula magica).
Gli eventi alluvionali sono legati a uno sviluppo urbanistico e abitativo che nel Nordest ha seguito un modello a un tempo disordinato e preciso, nell’atrofizzazione degli spazi pubblici a vantaggio dell’abitare privato, nella cementificazione di larghi settori della pianura in nome dei capannoni (oggi spesso vuoti), dei concessionari (oggi spesso falliti), delle villette familiari dove si vive come in un bunker e dopo la colazione da Mulino Bianco si esce, rigorosamente col SUV, magari per fruire delle donnine allegre che-infangano-il-nostro-territorio. Tutto questo, tecnicamente, ha un nome dotto, nato dall’indagine sociologica americana: “privatopia”. Ma il Veneto è diventato un pezzo di America, di Los Angeles?
La piena di questi giorni viene a ricordare che qui non stiamo facendo accademia: le denunce di Andrea Zanzotto o di Salvatore Settis non hanno a che fare solo con i restauri filologici dei paesaggi di Giorgione e Cima da Conegliano, con l’atmosfera del galateo in bosco o con la nostalgia per un mondo di piccole virtù: non sono discorsi di intellettuali slegati dal mondo, ma portano (vorrebbero portare) al centro del dibattito pubblico la distruzione delle venule di drenaggio, l’intubazione (proprio così, come con i malati gravi o i neonati prematuri) dei canali di scolo, l’assedio cementizio agli spazi golenali, l’ostinata impermeabilizzazione di superfici con l’asfalto, l’erosione dei suoli fertili per un’agricoltura ormai confinata a inerte memoria del passato; e la negligenza delle oggi invocate “verifiche di compatibilità idraulica”, degli oggi millantati “Piani di assetto idrogeologico”. La campagna che nel 1739 Charles de Brosses riteneva valesse “forse da sola il viaggio in Italia” è oggi impantanata non per una strana nemesi divina, ma perché sono state fatte determinate scelte, lucidamente esposte e denunciate con rigore scientifico e passione in un volume del 2005 di Francesco Vallerani e Mauro Varotto, Il grigio oltre le siepi: Geografie smarrite e racconti del disagio in Veneto. Un volume – è bene precisarlo – che invece di ricevere un premio per il coraggio e l’acutezza dell’analisi ha condotto gli autori a un processo prima in sede civile e poi anche in sede penale, con l’accusa di aver diffamato una zincheria.
L’idrografia padana, come sa qualunque visitatore di Treviso o di Milano (dove per inciso ieri sono di nuovo esondati Seveso e Lambro), è un fatto complesso, che incide sulla percezione “identitaria” dello spazio come sulla vita quotidiana di chi lo abita: non a caso si è parlato per queste terre di una vera e propria “civiltà delle acque” (è il titolo di una raccolta di saggi sulla cultura popolare curata nel 1993 da un linguista, Mario Cortelazzo), e non a caso si indica specificamente nel Veneto un modello interessante a livello mondiale per l’inusitata ricchezza di risorse idriche e per la multiforme sfida rappresentata della loro gestione. Nello spazio antropico ormai drammaticamente mutato, s’imporrebbe la creazione di “corridoi fluviali”, nel senso indicato dallo stesso Vallerani come rispetto delle specificità naturali e invenzione di nuove modalità di utilizzo del suolo: il libro Acque a Nordest (Cierredizioni 2004) è un’indagine su Brenta, Sile, Piave come modelli positivi o negativi di trasformazione dell’identità di un fiume dall’Ottocento ai tempi nostri; lì s’impara anche a suon di esempi quante forze vengano profuse per la salvaguardia e la valorizzazione dei fiumi da comitati e unioni e associazioni a livello locale (penso per es. agli “Amissi del Piovego”, che in Padova si battono per una diversa cultura e coscienza idrografica), talora anche da singole amministrazioni lungimiranti.
*
Ma quello che sembra mancare è una riflessione di sistema, che impegni le autorità regionali (non che quelle nazionali) a indirizzare altrimenti gli investimenti e le attività di controllo. Chi se ne voglia convincere può leggere gli articoli di un uomo che conosceva l’acqua di queste terre come pochi altri: Il respiro delle acque di Renzo Franzin (Nuova dimensione, 2006). S’imporrebbe, se non altro, la meditazione di quanto è drammaticamente accaduto in contesti limitrofi, come quello del Piave, un fiume buono per la retorica patriottarda (e ultimamente xenofoba), ma sfiancato dall’artificializzazione e dal depauperamento inflittigli da un piano idroelettrico insensato, che annovera tra i suoi “danni collaterali” la catastrofe del Vajont. Perché nell’idrografia odierna del Nordest non pesano solo le alluvioni: pesa anche, paradossalmente, la siccità.
Ieri passando in treno sopra il Brenta ho notato che l’acqua del fiume faceva la barba ai binari. Mi è venuto in mente che nell’avvio del XV canto dell’Inferno (quello dei sodomiti) Dante paragona gli argini del Flegetonte a quelli costruiti dai “Padoan lungo la Brenta, per difender lor ville e lor castelli” (vv. 7-8). Verrebbe da chiedersi dove sia finita tanta sapienza costruttiva, se negli ultimi anni attorno alla Cappella degli Scrovegni, che sorge a pochi passi dal Bacchiglione, si è costruito un costosissimo e brutto monumento all’11 settembre proprio in area golenale (“World Trade Center Memorial“, di Daniel Libeskind: mica da ridere), si è lasciato il cenobio degli Eremitani in preda agli allagamenti, si è ventilata l’edificabilità dell’appena smantellata stazione degli autobus (dove invece, nei progetti originari, doveva sorgere un auditorium).
Il Bacchiglione è appunto il fiume esondato ieri. Un dovizioso volume edito dalla Regione del Veneto nel 2005, sotto il titolo Il Veneto e il suo ambiente nel XXI secolo, dedicava un’intera sezione, densa di grafici e di promesse, alla gestione dell’acqua. Per un caso della sorte, le pp. 136-37 presentavano come unico studio di caso proprio la valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale del Bacchiglione, sulla base di rilevazioni condotte dall’Arpav nel 2002 e nel 2003. L’esame, che misurava diversi parametri chimici, fisici e territoriali del fiume, svelava un IFF mediocre per il 55% del corso, scadente per il 42%, buono per il 3%. Non solo, ma dei tre “macrotratti” in cui era diviso il corso del Bacchiglione, si evidenziavano come punti particolarmente critici la periferia sud di Padova e il tratto cittadino di Vicenza. I medesimi posti che ieri – diversi anni dopo, per un caso della sorte – sono finiti sotto.
In questo senso, che Palladio rischi di andare a remengo “sotto i cingoli dei diluvi” (come recita un verso folgorante dei Conglomerati di Zanzotto) è quasi il simbolo di una decisa virata nella direzione di sviluppo di questa terra, il segno di un nuovo modello culturale che sembra lasciare pochi margini di reversibilità. Proprio di Vicenza è uno dei più grandi scrittori nordestini viventi, quel Vitaliano Trevisan che nei Quindicimila passi, ma anche nel più recente Il ponte, documenta fra l’altro il malessere del paesaggio, l’isteria urbanistica e il conseguente ingrigirsi delle menti, l’architettura da karaoke e le ammiccanti “pompeiane” che finiscono a decorare le villette dopo essere state pubblicizzate da testimonials incongruamente discinte, a tarda sera, sulle tivù locali. E la racconta non sotto la specie del saggista o del geografo, ma nell’ottica di chi indaga en homme de lettres il sentimento delle cose e i modi di convivenza e desistenza degli uomini.
Sono andate sott’acqua le taverne, e con esse magari le consolles dei “tavernicoli”, quel singolare stadio dell’evoluzione che Marco Paolini ha ritratto nel Bestiario veneto, sciorinando le insegne e le imprese di un miracolo i cui piedi d’argilla vacillano in tempi di crisi. Viene il sospetto che sia tuto una metonimia per la trasformazione dell’Italia tutta in una lunga taverna, dove fuori (come quando fuori piove) Giove Pluvio porta via il bambino con l’acqua sporca, e dentro, illudendosi d’essere al riparo, gli Eletti fanno battute consone al luogo. Una Taverna del Re?