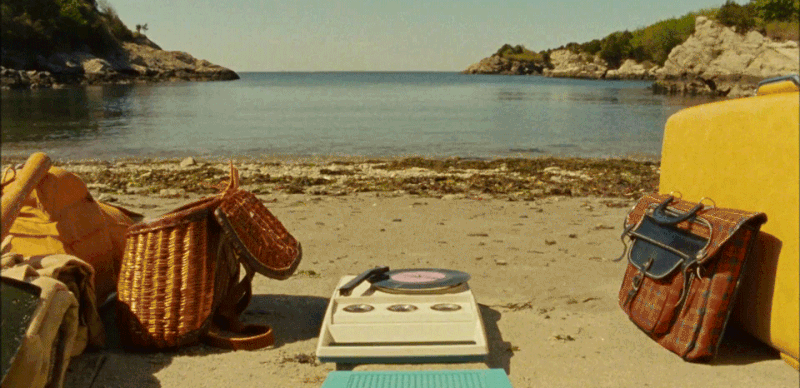Le lunghe liste di attesa negli ospedali, spiegate
Come mai bisogna aspettare mesi per fare una visita specialistica o un esame e quali sono le possibili soluzioni

In molte regioni le donne che cercano di prenotare una mammografia, un esame al seno consigliato dai piani di prevenzione dei tumori per chi ha più di 40 anni, si sentono rispondere che il primo appuntamento è disponibile tra quasi due anni. Per una più semplice ecografia servono fino a 375 giorni, poco più di un anno, e per una visita dermatologica 300 giorni. L’attesa è lunga per molte altre visite specialistiche ed esami, dalle risonanze magnetiche alla visite oculistiche, e spesso la richiesta di priorità serve a poco perché negli ospedali non ci sono posti.
I tempi di attesa citati sono stati rilevati dall’indagine dell’associazione Cittadinanzattiva che ogni anno raccoglie migliaia di dati e segnalazioni relative all’accesso alle cure. È un problema noto e discusso da anni, già molto prima del sensibile peggioramento avvenuto a causa della pandemia. Nonostante il tema sia tra i più dibattuti dalla politica, come testimoniano le promesse dei candidati alle elezioni regionali in Lazio e soprattutto in Lombardia, finora nessuno è riuscito a trovare una soluzione.
Uno dei grossi limiti delle discussioni e delle proposte fatte negli ultimi anni è la scarsa comprensione del fenomeno, a partire da cosa si intende per liste di attesa e tempi di attesa. Inoltre la mancanza di dati affidabili e la gestione affidata alle Regioni, ognuna con diverse politiche, criteri e priorità, rende tutto più complicato e incerto.
La prima cosa da dire è che spesso sui mezzi di informazione e nel dibattito pubblico si discute di due concetti diversi – liste di attesa e tempi di attesa – con la stessa definizione, cioè appunto “liste di attesa”. Con lista di attesa si intende il numero dei pazienti in coda, mentre il tempo di attesa è la durata dell’attesa tra il momento in cui il paziente prenota, quindi entra in lista, e il momento in cui riceve la prestazione, una visita o un esame. I problemi più sentiti dalla popolazione riguardano i tempi di attesa, mentre le liste di attesa preoccupano prevalentemente chi gestisce i servizi sanitari.
Il tempo di attesa si basa su una semplice relazione matematica: è il risultato del rapporto tra i pazienti che hanno richiesto una prestazione e la quantità di prestazioni disponibili in un determinato periodo di tempo. Se la questione fosse così lineare sarebbe molto semplice trovare un rimedio.
La sanità, tuttavia, non è una catena di montaggio. Ci sono una serie di fattori che influiscono sulle liste e sui tempi di attesa: l’offerta sanitaria disomogenea, regionale, poco connessa, la diversa organizzazione degli ospedali, il ruolo delle strutture private e della libera professione nelle strutture pubbliche, il diverso impatto delle prestazioni a seconda del paziente. A tutto questo si aggiungono i piccoli imprevisti e le grosse emergenze: basta poco a bloccare o rallentare il sistema. Insomma, è un fenomeno difficile da osservare e da governare.
I tempi di attesa si allungano quando c’è uno squilibrio tra la domanda e l’offerta, cioè quando il numero di richieste di esami e visite è più alto rispetto alle prestazioni disponibili. Semplificando molto: per incidere sui tempi di attesa bisogna intervenire sulla domanda, quindi sulle prescrizioni di esami e visite fatte dai medici di famiglia o dai medici ospedalieri, oppure sull’offerta, garantendo più prestazioni. Negli ultimi anni il ministero della Salute ha scelto una strategia intermedia attraverso la definizione di alcune classi di priorità nel Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), introdotto nel 2019 e approvato dalle regioni. A parità di offerta, l’idea è che la priorità aiuti a gestire più velocemente pazienti che ne hanno effettivamente bisogno.
Le classi di priorità sono indicate dai medici e sono: U per urgente, B per breve, D per differibile e P per programmata. Ad ogni classe corrisponde un tempo massimo in cui il sistema sanitario deve garantire la visita o l’esame: entro 72 ore se la priorità è urgente, entro 10 giorni se è breve, entro 30 giorni per prestazioni differibili, entro 120 giorni quando sono programmate.
Quando una persona chiama il centro unico di prenotazione (CUP), il personale del sistema di prenotazione gestito dalle regioni o dalle aziende ospedaliere controlla tutte le disponibilità. Qui iniziano le complicazioni perché non in tutte le regioni c’è un centro unico di prenotazione e anche quando il CUP è operativo non riceve le disponibilità di tutte le strutture sanitarie, per cui una persona è costretta a chiamare gli ospedali uno per volta, come accadeva anni fa.
– Leggi anche: Un glossario sul tema delle liste e i tempi di attesa
Se il tempo di attesa rientra nei limiti non ci sono problemi: la visita viene prenotata in ospedale, con il servizio sanitario nazionale. Si può ricorrere anche alle strutture sanitarie private accreditate, cioè quelle che forniscono servizi sanitari per conto del servizio sanitario nazionale che successivamente rimborsa la differenza tra il ticket pagato dal paziente e il costo della visita sulla base di criteri e limiti di spesa decisi dalle regioni.
I privati hanno tempi di attesa più brevi perché spesso hanno organizzazioni più flessibili e a differenza degli ospedali pubblici possono concentrarsi sulle prestazioni più remunerative. Come emerge dai rapporti del Censis sulla sanità pubblica e privata, inoltre, il ruolo del privato non è uguale in tutta Italia: nelle regioni del nord ha quasi sempre una funzione di integrazione del servizio pubblico, cioè garantisce soprattutto esami e visite meno urgenti, mentre al centro-sud colma le lacune della sanità territoriale: gestisce ricoveri o casi urgenti di cui gli ospedali non possono farsi carico perché disorganizzati e con poco personale.
C’è anche la possibilità di accedere all’attività “libero-professionale intramuraria” conosciuta anche come intramoenia, una locuzione latina che significa “tra le mura”. In sostanza, l’intramoenia consente ai medici di esercitare la libera professione all’interno delle strutture pubbliche al termine dei loro turni di lavoro per il servizio sanitario nazionale.
La sanità pubblica mette a disposizione il sistema di prenotazione dei CUP, gli ambulatori e i macchinari. Il costo della visita o degli esami, decisamente superiore rispetto a una visita prenotata con il servizio pubblico, viene ripartito solitamente all’80% ai medici e al 20% all’ospedale, ma è l’ospedale a decidere quanto lasciare ai medici. Le visite in intramoenia furono introdotte nel 1999 secondo il principio costituzionale per cui ogni persona può scegliere da chi farsi visitare. Tra gli obiettivi c’era anche evitare che le persone ricorressero alle cliniche private, ma si affidassero ai privati all’interno di strutture pubbliche. In realtà con il passare degli anni la quota di visite in intramoenia è aumentata molto fino a superare quella delle visite garantite dal servizio sanitario nazionale.
Anche qui ci sono problemi. In base a un decreto legislativo del 1998, quando i tempi di attesa superano le soglie massime, si può chiedere una visita o un esame in intramoenia senza dover pagare la prestazione come privata: si paga soltanto il ticket. Spesso, però, questo diritto non viene garantito, un po’ perché le aziende sanitarie e gli ospedali non lo pubblicizzano, un po’ perché fanno una cosa illegale: chiudono le agende di prenotazione per evitare di dover pagare prestazioni che poi non saranno rimborsate dalle regioni, in quanto fuori dal budget annuale assegnato a ogni struttura sanitaria. Il blocco delle liste di attesa è illegale perché elude il rispetto dei tempi di attesa di visite ed esami e limita l’accesso alla sanità.
La Toscana è una delle regioni che negli ultimi anni hanno bloccato le agende, come ha segnalato la Corte dei Conti in un rapporto pubblicato il 23 gennaio. L’indagine dei magistrati contabili sulle prestazioni fatte tra il 2017 e il 2022 è molto circostanziata: diverse aziende sanitarie toscane hanno bloccato le prenotazioni e soprattutto hanno fatto ricorso eccessivo alla libera professione. In molti ospedali sono state fatte molte più visite in intramoenia che con il servizio sanitario nazionale. La Toscana è soltanto il caso più recente. Negli ultimi anni la stessa situazione è stata segnalata in molte altre regioni.
La chiusura delle agende, cioè l’impossibilità di prenotare gli appuntamenti, spinge moltissime persone verso le cliniche private, in servizio sanitario non accreditato, con notevoli costi a carico dei pazienti. Un’altra conseguenza è l’allungamento delle liste e dei tempi di attesa. Ma quella più grave è la rinuncia alle cure.
Nella recente indagine pubblicata dall’ISTAT sulla qualità dei servizi pubblici emerge che nel 2021 l’11 per cento delle persone che avevano bisogno di visite specialistiche o esami ha dichiarato di aver rinunciato per problemi economici legati alle difficoltà di accesso al servizio, mentre durante un’audizione alla Camera l’economista dell’ISTAT Maurizio Franzini ha detto che il 3,3 per cento della popolazione, circa 2 milioni di persone, ha rinunciato per via dei tempi di attesa.
Una quota così alta di rinunce è preoccupante perché un rinvio di esami e visite porterà a un allungamento delle liste e dei tempi di attesa in futuro e soprattutto a un aumento della cosiddetta mortalità evitabile per esami e visite fatte in ritardo.
Per dare alle persone uno strumento di valutazione del servizio, negli ultimi anni è stato imposto alle regioni di pubblicare in modo chiaro e trasparente i tempi di attesa per le singole prestazioni. «La gestione e la comunicazione delle liste e dei tempi di attesa dovrebbe essere un tema cardine, in realtà c’è pochissima trasparenza da parte delle regioni», dice Isabella Mori, responsabile politiche trasparenza di Cittadinanzattiva.
L’associazione ha segnalato in più occasioni che molte regioni non pubblicano i dati e anche quando esistono sono poco comprensibili. Vengono pubblicati i tempi medi di un periodo ristretto, soltanto quelli di alcune strutture o senza tenere conto dei livelli di priorità. «È molto difficile orientarsi ed è quasi impossibile avere informazioni chiare da parte dei CUP sui tempi di attesa», spiega Mori. «Con il Covid la situazione si è aggravata. Anche il tema delle agende bloccate non può essere più tollerato: noi invitiamo a presentare una segnalazione all’azienda sanitaria, all’assessorato regionale e anche alla nostra associazione».
Una delle soluzioni proposte con più insistenza dalla politica, sia nazionale che regionale, è l’aumento delle prestazioni per ridurre i tempi di attesa. Il principio è che pagando più visite, anche coinvolgendo di più il privato, si possa dare una risposta alle persone in tempi più brevi. In un’intervista alla Stampa, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha spiegato che l’intenzione è alzare l’offerta garantita dalle strutture private e dare un aumento ai medici che si mettono a disposizione per più ore di lavoro: in questo modo si potranno recuperare le visite saltate a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.
Nonostante sia una soluzione apparentemente logica, diversi studi pubblicati negli ultimi anni dicono che una maggiore offerta può aiutare a risolvere periodi molto critici, ma non a cambiare le cose in modo decisivo. Finanziare maggiori disponibilità di visite, anche private, non risolve il problema dei tempi di attesa. «L’offerta traina la domanda: più visite vengono garantite e più richieste arrivano», spiega Milena Vainieri, coordinatrice del laboratorio di management e sanità dell’Istituto della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Uno degli studi più interessanti realizzati dal dipartimento riguarda la domanda relativa alla diagnostica per immagini: negli ultimi anni la domanda di radiografie è aumentata moltissimo, di pari passo con lo sviluppo e la disponibilità di questa tecnologia. Ma un aumento delle radiografie non sembra aver avuto effetti significativi sulla salute delle persone.
Se ne discute pochissimo, forse perché è un tema delicato e scomodo, eppure uno degli interventi consigliati da molti studi sulla gestione dei sistemi sanitari è ridurre la domanda: in sostanza, chiedere ai medici di famiglia e agli specialisti di fare meno prescrizioni favorendo quella che tecnicamente viene chiamata appropriatezza prescrittiva. Evitare, insomma, visite ed esami inutili.
Nella diagnostica per immagini, per esempio, la domanda potrebbe essere ridotta con un maggiore confronto tra medici e radiologi, per indicare quali esami sono opportuni e quali superflui. «Il pallino ce l’hanno le aziende sanitarie», spiega Vainieri. «Sono loro che dovrebbero avere queste funzioni di controllo delle prescrizioni. In tutte le aziende dovrebbe esserci un coordinatore della medicina generale che ha il compito di rapportarsi con i medici di famiglia per governare la domanda e i processi».
Ma il dialogo e il controllo spetta anche agli stessi medici nei confronti dei pazienti, che spesso sollecitano in modo insistente prescrizioni anche quando non servono. Un altro fattore che incentiva l’inappropriatezza prescrittiva è la cosiddetta medicina difensiva, cioè il ricorso a un gran numero di esami e visite per prevenire il rischio di denunce da parte dei pazienti o dei loro parenti. Questo atteggiamento porta inevitabilmente a prescrivere esami senza rispettare i protocolli indicati per gli accertamenti legati a diverse malattie.
Uno dei modi per risolvere questo problema è analizzare in modo sistematico le richieste di visite ed esami per individuare il tasso di prescrizione dei medici di famiglia e degli specialisti a seconda della patologia. Uno studio costante e approfondito con l’utilizzo dei dati a disposizione delle aziende sanitarie potrebbe ridurre sensibilmente le richieste di visite con un beneficio sui tempi di attesa. Non è semplice, tuttavia, introdurre questo tema: sia perché interviene sulla gestione e l’indipendenza dei medici, sia perché una riduzione delle visite viene spesso equiparata erroneamente ai tagli alla spesa sanitaria contro cui da anni si schierano tutte le categorie dei lavoratori della sanità.