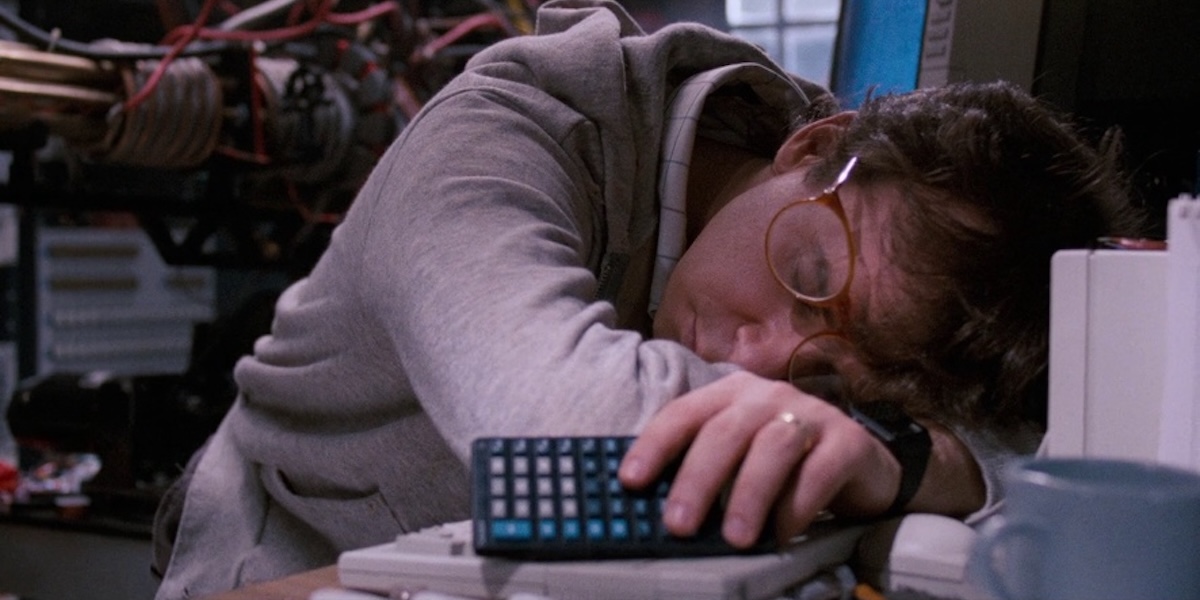Quanto è libero il libero arbitrio?
L'Atlantic ha ripreso un esteso dibattito in corso da decenni tra neuroscienziati e filosofi: esiste un "libero arbitrio", o le nostre scelte sono determinate da fattori genetici e ambientali?
di Antonio Russo – @ilmondosommerso

Un giorno di ottobre del 2005 il neuroscienziato statunitense James Fallon, docente di psichiatria e neurobiologia alla School of Medicine dell’Università della California (UCI), stava osservando una serie di scansioni del cervello di alcuni pazienti ottenute mediante PET (tomografia a emissioni di positroni, un esame molto usato in neurologia e nella diagnostica oncologica). Fallon stava lavorando a uno studio il cui obiettivo era quello di rintracciare eventuali tratti anatomici comuni o particolari alterazioni nel cervello di un gruppo di assassini seriali con comprovate tendenze psicopatiche.
Tra le numerose immagini diagnostiche sparse sulla scrivania, per altre ricerche a cui stava lavorando, Fallon aveva anche le scansioni del suo cervello e di quello dei suoi familiari. In una di quelle immagini notò evidenti caratteristiche comuni alle scansioni del cervello di molti assassini che stava studiando: una ridottissima attività cerebrale in alcune aree del lobo frontale e temporale, aree che numerosi studi di neuroscienze associano all’empatia, all’autocontrollo e all’inibizione dell’impulsività. Considerando che si trattava della sua famiglia, Fallon violò il metodo di lavoro “in cieco” e scoprì subito l’etichetta che nascondeva il codice identificativo della persona a cui apparteneva quella scansione: il cervello era il suo. Non solo: cercando informazioni sulla propria storia familiare, Fallon scoprì di essere un lontano discendente di Lizzie Borden – protagonista di un noto e controverso processo per parricidio nel 1892 – e di avere sette assassini noti tra i suoi antenati da parte di padre. «Questo creerà qualche problema alla prossima festa che diamo», disse a sua moglie revisionando i dati della ricerca.
La storia di Fallon e le sue ricerche sui tratti neurofisiologici ricorrenti e i condizionamenti ambientali negli assassini psicopatici rappresentano, per molti versi, una delle molteplici declinazioni moderne di un dibattito molto radicato nella tradizione filosofica e scientifica: quello sul libero arbitrio e sul rapporto tra natura e cultura. Quanta parte di quello che facciamo è il risultato di una scelta individuale consapevole e volontaria, e quanta parte invece è l’effetto di una serie di predisposizioni e condizionamenti su cui non abbiamo controllo? In un recente articolo intitolato “Non c’è libero arbitrio, ma è meglio che ci crediamo lo stesso”, pubblicato sulla rivista statunitense Atlantic, lo scrittore e ricercatore inglese Stephen Cave ha riassunto le posizioni dominanti all’interno del dibattito e riportato una serie di teorie e risultati sperimentali che tentano di dimostrare come il concetto stesso di “libero arbitrio”, a prescindere da qualsiasi fondamento scientifico, abbia importanti ricadute sul comportamento umano.
Natura e cultura
Per quanto dibattuta e ambigua sia in ambito accademico la nozione di “libero arbitrio”, una gran parte della cultura popolare, della retorica e della politica negli Stati Uniti, fa notare Cave, è incentrata sul valore della libertà di scelta e sullo stereotipo del cosiddetto “sogno americano”, ossia l’idea che chiunque, attraverso l’impegno e il sacrificio, possa raggiungere i propri obiettivi a prescindere dalle condizioni iniziali. Ma fin dalle teorie sull’evoluzione elaborate da Charles Darwin e da altri studiosi, è noto almeno dalla seconda metà del diciannovesimo secolo che le stesse facoltà intellettive alla base delle nostre scelte razionali siano almeno in parte un’eredità biologica e che, allo stesso tempo, il loro sviluppo sia condizionato da molteplici fattori ambientali. A seconda di quale dei due aspetti si consideri prioritario rispetto all’altro, la discussione tra addetti – neuroscienziati, filosofi, neurofisiologi e psichiatri – tende a oscillare tra due poli opposti rappresentati dal concetto di “natura” (l’eredità biologica) e da quello di “cultura” (i condizionamenti ambientali).
Negli ultimi decenni i rapidi progressi compiuti nel campo delle scienze cognitive, della neuroradiologia e delle neuroscienze in genere – le discipline che studiano il sistema nervoso dal punto di vista morfologico e funzionale – hanno ulteriormente arricchito il dibattito mostrando che le reti stesse su cui “viaggiano” gli impulsi nervosi sono determinate sia dal nostro corredo genetico sia dall’ambiente in cui si sviluppano. Sappiamo inoltre che a ogni regolazione dei livelli di certi neurotrasmettitori, enzimi e ormoni può corrispondere un diverso comportamento umano: è un fenomeno facilmente osservabile, per esempio, in caso di assunzione di determinate sostanze (alcolici, stupefacenti, psicofarmaci). Le più recenti tecniche di brain imaging – la visualizzazione del funzionamento e dell’attività del cervello umano – hanno in generale ampliato le nostre conoscenze riguardo le relazioni tra il cervello e il comportamento, sia nei soggetti sani che nei soggetti con danni o alterazioni cerebrali.
La storia di Phineas Gage
Uno dei casi più studiati e citati nella storia della neurologia e delle neuroscienze è quello dell’operaio statunitense Phineas Gage, vissuto tra la prima e la seconda metà del diciannovesimo secolo, e sopravvissuto a un grave incidente sul lavoro nel settembre del 1848, quando aveva 25 anni e stava lavorando alla costruzione di una ferrovia nello stato del Vermont. A causa di un’esplosione imprevista, un’asta di metallo – lunga circa un metro e con un diametro di tre centimetri – perforò la testa di Gage dal basso verso l’alto: come un proiettile, entrò attraverso l’orbita oculare sinistra e fuoriuscì dalla parte superiore della scatola cranica, finendo a una ventina di metri di distanza dall’incidente. Gage perse conoscenza per alcuni istanti e fu immediatamente soccorso, ma dopo un periodo di convalescenza fu in grado di riprendersi quasi del tutto, nel giro di due mesi. Riportò di fatto soltanto la perdita della vista dall’occhio sinistro come conseguenza evidente dell’incidente.
Il medico che curò Gage e ne seguì la guarigione, John Martyn Harlow, riferì tuttavia, negli anni seguenti, di una serie di sorprendenti cambiamenti nel carattere di Gage, dai suoi colleghi ritenuto un efficiente capocantiere fino a prima dell’incidente. Scrisse Harlow:
«L’equilibrio, per così dire, tra le sue facoltà intellettuali e i suoi istinti sembra esser stato distrutto. Gage è umorale, irriverente, indulge a volte in bestemmie (che non era sua abitudine pronunciare), manifesta poco rispetto verso i colleghi; è recalcitrante e impaziente quando qualcosa è in conflitto con i suoi desideri, pertinacemente ostinato, capriccioso e incostante altre volte; elabora molti progetti per il futuro, che poi non realizza e abbandona subito per altri che appaiono più fattibili. […] La sua mente è così radicalmente cambiata che i suoi amici e conoscenti dicono “non è più lui”».
Gage non ottenne indietro il suo lavoro. Si trasferì nel New Hampshire, dai genitori, e per un periodo della sua vita lavorò anche in Cile come cocchiere di diligenze. Morì nel 1860, a 36 anni, per le complicazioni seguite a una serie di crisi epilettiche. Benché si tratti di un caso clinico estremamente controverso e dibattuto, i rapporti di Harlow su Phineas Gage furono nei decenni seguenti largamente citati a sostegno di numerosi studi di fisiologia sul funzionamento del cervello e sulla localizzazione cerebrale delle funzioni cognitive. Nel corso degli anni gli esami postumi effettuati sul cranio di Gage – conservato al Warren Anatomical Museum della Harvard Medical School, a Boston, Massachusetts – hanno permesso di ipotizzare un vasto danno cerebrale limitato alla zona della corteccia prefrontale, specialmente quella sinistra, in seguito all’incidente. Secondo diversi studi recenti di neuroscienze, si tratta di una delle parti del cervello maggiormente coinvolte nella pianificazione e organizzazione dei comportamenti e nella costruzione della personalità.
Nonostante un certo progressivo ridimensionamento recente, la vicenda di Gage – i cui tratti semileggendari, nel tempo, si sono sovrapposti ai pochi dati storici certi – ha contribuito a indebolire il concetto tradizionale di “libero arbitrio” e a rendere più familiare e scientificamente sostenibile l’ipotesi che il cervello funzioni come un sistema fisico – come il cuore, per esempio – su cui non esercitiamo un controllo cosciente, e cioè che non possiamo deliberatamente far funzionare nel modo voluto.
Il caso dell’insegnante di Charlottesville
Il fatto rilevante dei tempi recenti, sostiene Cave sull’Atlantic, è che lo scetticismo riguardo l’esistenza del “libero arbitrio” non è più soltanto una problematica linea di pensiero espressa da alcuni addetti in contesti accademici, ma un’inclinazione diffusa al di là dei laboratori di ricerca e ormai presente anche in una parte dell’opinione pubblica e in ambito forense. Nell’ultimo decennio, per esempio, è notevolmente aumentato il numero di processi penali in cui sono state raccolte e utilizzate prove ottenute tramite le tecniche neuroscientifiche: nella maggior parte dei casi è avvenuto in difesa degli imputati, nel tentativo di sostenere che una particolare condizione patologica o una predisposizione “biologica” fossero alla base dell’azione criminosa.
Piuttosto noto e citato è un caso pubblicato nel 2003 sulla rivista scientifica Archives of Neurology (oggi JAMA Neurology). All’inizio del 2000, un allora quarantenne insegnante scolastico di Charlottesville, in Virginia, sposato in seconde nozze, sviluppò nel giro di pochissimo tempo un crescente interesse per la pedopornografia e cominciò ad assumere atteggiamenti sessualmente molesti nei riguardi della figlia preadolescente di sua moglie. Dopo esser stato scoperto e denunciato, e dopo aver ricevuto una diagnosi di pedofilia (in linea con i criteri del DSM, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), fu allontanato dai suoi familiari. Giudicato colpevole di molestia sessuale, fu poi costretto – in alternativa alla detenzione – a seguire un programma di riabilitazione di un anno, interrotto perché lui continuava a molestare il personale e gli altri pazienti del centro.
Il giorno prima della prevista condanna alla detenzione, l’uomo – la cui storia clinica era fino a quel momento stata priva di disturbi psichiatrici o altre patologie rilevanti – si presentò al pronto soccorso del dipartimento medico dell’Università della Virginia, a Charlottesville, con un forte mal di testa, dicendo di aver perso l’autocontrollo e che avrebbe violentato la sua padrona di casa. Pur sospettando che si trattasse in realtà di una messinscena per evitare la prigione, i medici notarono comunque alcune manifestazioni potenzialmente sintomatiche: aveva problemi di equilibrio e una certa rigidità a un braccio, e dall’esame neurologico emerse una marcata aprassia costruttiva – l’incapacità di disporre nello spazio le diverse parti di un oggetto – e una difficoltà a individuare bene gli oggetti alla sua sinistra. Una risonanza magnetica al cervello mostrò la presenza di una massa tumorale della grandezza di un uovo, nella fossa cranica anteriore, che premeva contro la corteccia orbitofrontale.
Alla corteccia orbitofrontale molte recenti ricerche neuroscientifiche attribuiscono generalmente le capacità di attenzione, di programmazione e di iniziativa, e anche quelle di autocontrollo e di inibizione delle informazioni e degli stimoli non rilevanti per lo svolgimento di un determinato compito. Durante l’esame neurologico, e per tutto il periodo di ospedalizzazione prima della rimozione del tumore, l’uomo continuò a molestare il personale medico femminile e a essere incontinente (se la faceva addosso, ridendone in modo irrefrenabile). Dopo la rimozione del tumore (un emangiopericitoma), l’incontinenza regredì progressivamente così come i comportamenti molesti, e i risultati dei testi neurologici migliorarono nettamente. Riammesso al programma di riabilitazione, l’uomo tornò a vivere con la sua famiglia. Nell’ottobre del 2001 ricominciò ad avere dei mal di testa e di nuovo a collezionare materiale pornografico: una nuova risonanza magnetica mostrò la ricrescita del tumore, per cui si rese necessario un nuovo intervento di rimozione chirurgica nel febbraio 2002.
L’ipotesi di Jeffrey Burns e Russell Swerdlow, i due medici che seguirono questo caso fin dall’inizio, è che il tumore possa aver aggravato un preesistente interesse per la pornografia e favorito l’insorgenza dei disturbi psicosessuali. “Una delle cose interessanti dei danni al lobo frontale è che, prendete quest’uomo, lui sapeva che quello che faceva era sbagliato ma pensava non ci fosse niente di sbagliato in lui, e ciononostante non riusciva a fermarsi”, disse Swerdlow.
Brian Dugan
In una recente serie di documentari curati da National Geographic, l’attore statunitense Morgan Freeman ha intervistato Brian Dugan, un uomo statunitense di sessant’anni che sta scontando in una prigione di massima sicurezza in Illinois una condanna al carcere a vita: nel giro di due anni commise tre omicidi – tra cui quello di una bambina di sette anni, nel 1985 – e una serie di violenze sessuali su persone minorenni. Freeman ha anche parlato con Kent Kiehl, un neuroscienziato chiamato dall’avvocato difensore di Dugan, nel 2009, a fornire un referto degli esami dell’attività cerebrale di Dugan.
Nel tentativo di evitargli la pena di morte fornendo delle attenuanti, il difensore di Dugan cercò di dimostrare i disturbi mentali del suo cliente, che tuttavia fu ritenuto colpevole e condannato a morte lo stesso. Due anni più tardi, nel 2011, la pena gli fu commutata nell’ergastolo in seguito all’abolizione della pena di morte nello stato dell’Illinois. Nell’intervista con Freeman, Dugan ha detto di ritenersi ancora pericoloso, di non sentire alcun rimorso per i suoi crimini e di aver agito sotto l’azione di impulsi che era incapace di controllare.
Kent Kiehl, il neuroscienziato chiamato a testimoniare nel processo contro Dugan, ha compiuto una serie di studi sugli esami del cervello degli assassini psicopatici, e – come molti altri suoi colleghi impegnati in questo genere di ricerche – sostiene che il quadro clinico di queste persone sia spesso caratterizzato dall’assenza di attività cerebrale nelle aree comunemente associate all’autocontrollo e all’empatia. La speranza di Kiehl, come da lui spiegato a Freeman, è che un giorno le tecniche neuroscientifiche possano contribuire a prevedere quali persone rispetto ad altre siano potenzialmente più esposte al rischio di commettere crimini brutali.
Secondo Colin Blakemore, insegnante di neuroscienze all’Università di Oxford, l’aumento di storie e casi come quello dell’insegnante di Charlottesville o di Brian Dugan comporta il pericolo “che il diritto, o se non altro qualche giudice, possa sentirsi talmente dominato dalla tecnologia da cominciare sostanzialmente a delegare il giudizio di colpevolezza al risultato di un determinato esame”. Gli esperti sono generalmente d’accordo nel ritenere che alterazioni come la psicopatia e la pedofilia possano difficilmente essere “curate”, eppure il caso particolare dell’insegnante di Charlottesville – che dopo la rimozione del tumore riacquisì l’abilità di inibire i suoi impulsi – rappresenta, pur volendo “salvare” una nozione di libero arbitrio, un caso di riduzione o limitazione biologica di tale facoltà.
I rischi di non credere nel libero arbitrio
La crescente diffusione di un atteggiamento diffidente verso la nozione di libero arbitrio, secondo Cave nel suo articolo sull’Atlantic, sta generando una conseguente crescita di popolarità delle visioni meccanicistiche della realtà, e del determinismo in genere. Viene tradizionalmente legato alla teoria del determinismo qualsiasi approccio conoscitivo che – in misure e forme differenti – tenda a credere necessaria e inevitabile una concatenazione tra tutti i fatti e tutti gli eventi. In altre parole, data l’esistenza di un certo fenomeno non potrà che prodursi inevitabilmente un secondo fenomeno come effetto necessario di quel primo fenomeno: in questo senso, non solo non esisterebbe niente di variabile o di casuale, ma non ci sarebbe neppure un fine da poter liberamente perseguire o non perseguire.
E quindi “se la responsabilità morale dipende dalla fiducia nel nostro agire, diventeremo forse moralmente irresponsabili intanto che si diffonderà la fiducia nel determinismo?”, si chiede Cave, introducendo un esperimento compiuto da due psicologi americani, Jonathan Schooler, dell’Università di Pittsburg, e Kathleen Vohs, all’epoca all’Università dello Utah. Nel 2008 Vohs e Schooler chiesero a uno dei due gruppi di partecipanti all’esperimento di leggere un testo in cui il libero arbitrio era trattato come un’illusione, e all’altro gruppo di leggere un testo che non assumeva una posizione specifica su questo argomento. A ciascun partecipante chiesero poi di risolvere alcuni problemi di matematica e test cognitivi rendendo teoricamente molto semplice la possibilità di “barare”, se qualcuno avesse voluto farlo. Dai risultati emerse che i membri del primo gruppo – quelli del testo sul determinismo e contro il libero arbitrio – avevano una maggiore inclinazione a barare rispetto a quelli del primo gruppo.
“Le persone portate a credere meno al libero arbitrio hanno maggiore probabilità di comportarsi immoralmente”, sostiene Vohs, convinta che questa tendenza sia rilevabile anche in contesti non sperimentali. (Quei risultati, tuttavia, furono successivamente messi in discussione da un tentativo fallito di ottenere gli stessi esiti replicando l’esperimento). In un certo senso, è come se le persone private della convinzione della propria autodeterminazione smettessero allo stesso tempo di sentirsi responsabili delle proprie azioni. Un’altra serie di esperimenti condotti da Vohs e da altri colleghi mostrò anche che una maggiore fiducia nel libero arbitrio tende a coincidere con maggiori capacità e puntualità sul lavoro.
Altri studi, come quelli compiuti dallo psicologo Roy Baumeister dell’Università statale della Florida, mostrano inoltre che una scarsa fiducia nel libero arbitrio, stando a una serie di risultati sperimentali, tende a rendere le persone meno inclini ad aiutare gli altri e meno socievoli, più scontrose e infelici, e più portate ad assumere atteggiamenti conformisti. “Sotto ogni aspetto, a quanto pare, quanto più accogliamo il determinismo tanto più cediamo al nostro lato oscuro”, sintetizza Cave.
L’illusione del libero arbitrio
Pur essendo ragionevolmente convinto che il libero arbitrio, inteso in senso tradizionale, sia un concetto infondato, Saul Smilansky, docente di filosofia all’Università di Haifa, in Israele, sostiene che sia meglio vivere con l’“illusione” che esista qualcosa di simile, piuttosto che favorire la diffusione del determinismo. Secondo Smilansky, l’idea che ciascun individuo non abbia possibilità di autodeterminarsi non soltanto potrebbe creare i presupposti di una tendenza alla deresponsabilizzazione, ma annullerebbe automaticamente anche qualsiasi idea di merito individuale. Scrive Cave:
Immaginiamo che io rischi la mia vita paracadutandomi in territorio nemico per portare a termine una coraggiosa missione. In seguito la gente dirà che non ho avuto scelta, che la mia impresa, per dirla come Smilansky, è stata soltanto “il dispiegamento di un dato di fatto”, e perciò difficilmente encomiabile. E così come l’eliminazione delle responsabilità eliminerebbe un ostacolo ad agire malvagiamente, l’eliminazione degli elogi eliminerebbe un incentivo a fare le cose bene.
Secondo i sostenitori di questa forma di “illusionismo” filosofico, peraltro piuttosto minoritario in ambito accademico, la fiducia nel libero arbitrio potrebbe spronarci a tirare fuori il meglio da noi stessi. E Smilansky, che ritiene questa fiducia del tutto connaturata nell’essere umano, crede che le istituzioni fondate sul presupposto stesso del libero arbitrio – tutte quelle che amministrano la giustizia, per esempio – siano assolutamente necessarie per evitare di finire nell’estrema barbarie.
Quelli che è meglio senza
Altri studiosi, al contrario di Smilansky, non credono che abbandonare il concetto di libero arbitrio possa realisticamente avere effetti nocivi sul grado di civiltà di una società. Il neuroscienziato e scrittore Sam Harris, anzi, crede che sarebbe molto meglio farne a meno, dell’illusione del libero arbitrio, e che le nostre credenze debbano sempre seguire ciò che si dimostra essere vero. “Come società, dovremmo conoscere quali sono le leve da azionare per incoraggiare le persone a essere le migliori versioni di sé che possono essere”, dice Harris. Secondo lui, se accettassimo che “il comportamento umano emerge dalla neurofisiologia” potremmo più facilmente comprendere cosa davvero spinge le persone a compiere azioni dannose e provare a impedire che questo accada, piuttosto che usare punizioni come il carcere come mezzo deterrente.
In un certo senso profondo, secondo Harris, anche nel caso dei peggiori criminali (per esempio gli assassini psicopatici) non è corretto dire che sia colpa loro: “non hanno scelto né i loro geni né i loro genitori, e non hanno creato loro il loro cervello, eppure è il loro cervello la causa delle loro intenzioni e azioni”, non un “etereo” libero arbitrio. Prenderne coscienza in modo spassionato e libero da pregiudizi aiuterebbe a proteggere la società, a gestire meglio i trasgressori, riabilitandoli, e a ridurre le possibilità di future trasgressioni. Una probabile implicazione morale del determinismo, inoltre, sarebbe secondo Harris quella di ridurre o eliminare del tutto l’odio e il desiderio di vendetta nei confronti dei responsabili di azioni criminose. Per comprenderne i benefici, prosegue Harris, basta confrontare due catastrofi di scala molto simile avvenute negli Stati Uniti: le reazioni alle morti causate dall’uragano Katrina furono molto diverse dalle reazioni alle morti causate dall’11 settembre. Nel primo caso, nessuno se la prese con le tempeste tropicali o dichiarò una Guerra al Clima, e la risposta collettiva all’uragano poté concentrarsi sulla ricostruzione e sulla prevenzione. Nel secondo caso, l’ottenebramento generato dal desiderio di vendetta portò a un’ulteriore, non necessaria, perdita di innumerevoli vite.
La differenza tra determinismo e fatalismo
Uno dei più ricorrenti equivoci quando si parla di determinismo, dice Harris, è confonderlo con il fatalismo: credere che anche le nostre decisioni facciano parte di una complessa concatenazione di cause ed effetti non equivale a credere che le nostre decisioni non siano rilevanti e che qualsiasi cosa destinata ad accadere accadrà comunque. Il determinismo non implica che “la consapevolezza cosciente e la facoltà di pensiero deliberativo non abbiano senso”: esistono tipi di azioni per le quali sono necessariamente richieste la consapevolezza delle proprie scelte e la facoltà di soppesare le diverse ipotesi. Ciò non toglie che, stando alla versione deterministica di Harris, se fossimo posti di fronte a una stessa situazione ancora una volta, a parità di stimoli ricevuti, cento volte su cento riprenderemmo la stessa decisione (“come se riavvolgessimo un film e lo facessimo ripartire”).
Bruce Waller, docente di filosofia alla Youngstown State University, in Ohio, è tra gli studiosi che, nonostante le significative incompatibilità tra i due modelli, ritengono esista un modo di far stare insieme determinismo e libero arbitrio a patto di intendere la nostra libertà di scelta come la facoltà umana di tracciare una vasta gamma di risposte possibili di fronte a ciascun determinato stimolo in un ambiente costantemente mutevole. Che poi questi processi siano sostenuti da una serie di connessioni sinaptiche, per Waller, non è importante: è soltanto una descrizione del comportamento umano su un piano differente rispetto a quella che include la nozione di libero arbitrio.
A Stephen Cave, autore dell’articolo dell’Atlantic, Waller ha detto di condividere pienamente il senso di un noto discorso tenuto da Barack Obama nel 2012 (e ripreso a sua volta da alcune apprezzate parole pronunciate in campagna elettorale dalla senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren, a lungo tempo ritenuta una delle possibili candidate vicepresidente di Hillary Clinton). Il senso di quel discorso, ancora molto citato (e ferocemente contestato dai Repubblicani), è che nessuno ottiene il successo da solo, e chi lo ottiene – anche chi lo ritenga esclusivamente frutto del proprio talento e delle proprie scelte individuali – deve una parte del merito a un articolato sistema di tutele, infrastrutture e garanzie che si dà a volte per scontato ma che tutti contribuiscono ogni giorno a tenere in piedi. Secondo Waller dovremmo accettare che i risultati nella vita siano determinati da disparità naturali e culturali, “in modo da poter prendere contromisure concrete per porre rimedio alle sfortune e aiutare tutti a sviluppare il loro potenziale”.
Come l’ha risolta James Fallon
Jim Fallon, il neuroscienziato che nel 2005 scoprì casualmente, durante le sue ricerche, di avere un cervello con alcune caratteristiche comuni ai cervelli di diversi assassini seriali psicopatici, ha trascorso parte della sua carriera accademica studiando i tratti genetici che potrebbero essere all’origine della violenza di queste persone. Compiendo queste ricerche anche su sé stesso, Fallon ha scoperto di possedere una particolare variante di un gene a cui è associata una minore produzione dell’enzima MAO-A (monoammino ossidasi-A), ritenuto responsabile della regolazione della serotonina che risiede nel cervello. Avendo a sua volta la serotonina, tra le altre cose, una rilevante funzione di regolazione dell’umore nel sistema nervoso centrale, l’inibizione della serotonina dovuta alla presenza di questa variante del gene tenderebbe a produrre bassi livelli di empatia e frequenti comportamenti antisociali e violenti.
Fallon sostiene di ritenersi a tutti gli effetti uno psicopatico, ma di un genere relativamente poco pericoloso, che lui e altri studiosi definiscono “prosociale”: si tratta di persone che hanno difficoltà a provare sentimenti di vera empatia verso gli altri ma i cui comportamenti restano comunque all’interno dei confini socialmente tollerati. Il caso particolare di Fallon mostra come una persona con predisposizione genetica e caratteristiche cerebrali ricollegabili alla psicopatia possa alla fine diventare un apprezzato studioso e un uomo dai comportamenti non violenti. E ciò non toglie, dice Fallon, che una sorta di tendenze psicopatiche siano comunque rintracciabili nei suoi comportamenti: “sono insopportabilmente competitivo, per esempio. Non lascio vincere le partite ai miei nipoti. Sono abbastanza uno stronzo, e faccio il genere di cose stupide che fanno girare le palle alle persone. Ma in questo modo la mia aggressività è sublimata. Preferisco battere qualcuno in una discussione piuttosto che pestarlo”.
Alla luce dei dati emersi dalle ricerche sul suo cervello, Fallon dice di aver compiuto, nel corso degli anni, molti sforzi per cercare di cambiare il suo comportamento: “Ho fatto in modo più consapevole le cose che le persone ritengono generalmente essere le cose giuste da fare, e ho pensato molto di più ai sentimenti degli altri. E non lo faccio perché sono di colpo diventato simpatico, ma per orgoglio, per mostrare a tutti e a me stesso che sono in grado di riuscirci”.
Fallon, che nei primi anni della sua attività di ricerca si definiva un convinto “determinista genetico”, ha in seguito parzialmente abbandonato le sue posizioni più radicali e ritiene oggi che le cure e attenzioni ricevute durante la sua infanzia – e la fortuna di non aver dovuto subire grandi traumi – lo abbiano tenuto lontano da un percorso potenzialmente spaventoso. I comportamenti violenti, secondo lui e secondo altri studiosi, emergono quando co-occorrono più fattori contemporaneamente, “naturali” e “culturali”: predisposizione genetica; danni ad alcune aree cerebrali; esposizione a traumi violenti o abusi in età infantile, o scarse attenzioni da parte dei genitori.