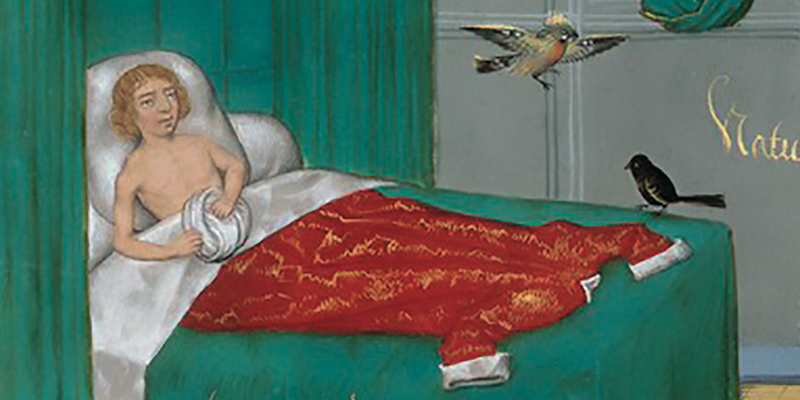Un paese ben coltivato
Giorgio Boatti è andato in giro per campagne italiane, raccontando in un libro storie di un paese agricolo contemporaneo

L’editore Laterza ha pubblicato Un paese ben coltivato. Viaggio nell’Italia che torna alla terra e, forse, a se stessa, di Giorgio Boatti, giornalista e scrittore, autore di diversi libri dedicati alla storia contemporanea italiana. Nel libro Boatti racconta il suo viaggio da sud a nord in ricognizione nel mondo contadino in Italia, viaggio condotto visitando i posti dove le persone più diverse con le storie e le motivazioni più diverse hanno ridato vita a cascine e masserie, rilanciando aziende e conservando un pezzo di storia economica e sociale italiana in nuovi modi.
***
Stamattina presto la radio ha detto che le nevicate si stanno spostando. Già dalla notte hanno cominciato a scendere lungo la dorsale dell’Appennino. Si spingeranno – dicono le previsioni meteo – sempre più a sud, sino alla Calabria.
Sto preparando la sacca perché a mezzogiorno, da Linate, parto anch’io per la Calabria. Chissà chi arriva prima, se io o la neve.
Nel dubbio aggiungo una felpa in più al bagaglio e mi tengo ai piedi gli scarponcini messi per un ultimo giro fatto sul sentiero attorno alla cascina dove ho casa da pochi anni.
La cascina è grande. Ha una pianta quadrata, a settentrione ci sono le stalle, ormai vuote, e sopra stanno i portici, sorretti da nove imponenti archi. Li vedo dal mio tavolo di lavoro, dalla stanza proprio sopra il portone d’ingresso. È un bel colpo d’occhio: assomiglia alla navata di una chiesa gotica aperta sul cortile che, al centro, ha sette imponenti platani centenari. Ognuno di questi alberi se ne sta lì in piedi, da quasi tre secoli, a guardare quello che succede attorno. Un tempo, in cascina, abitavano più di cento persone. E ora? Non ho mai fatto il calcolo esatto ma lungo gli edifici a un piano che compongono l’intero perimetro si aprono una ventina di porte. A ogni porta un’abitazione, e dunque, a occhio e croce, una ventina di nuclei famigliari. Ma ora niente famiglie patriarcali, anzi. Adesso dietro quella porta c’è spesso una sola persona, un single o una single, perché, come qualcuno mi ha spiegato quando sono arrivato qui per abitarci, “in questa cascina, negli ultimi anni, si arriva pari e si rimane dispari”. Non si sbagliava: funziona proprio così.
Il fico sul platano
Ai platani tutto questo non pare importare molto. Stanno lì, raggruppati e austeri, ciascuno con un cartellino – pare un biglietto da visita – ben esibito ad altezza d’uomo: riporta il numero d’inventario, perché anche loro, come tutta la cascina, sono sotto tutela della Soprintendenza. Sono, pur non essendone consapevoli, beni monumentali.
Capisco che la numerazione semplifichi le cose (anche nei film sulle carceri, o nei lager, si numera alla grande) ma a me piacerebbe che, invece di chiamarsi platano 374 o platano 379, ognuno di questi giganti avesse un suo nome. Perché ciascun albero ha una propria connotazione, un carattere maturato nel corso del tempo.
C’è, ad esempio, quello tutto bitorzoluto e un po’ infido che nel tronco, appena gli giri attorno, nasconde una trappola. È una fenditura larga due spanne: lì, se ci finisce dentro una palla – lo dico per esperienza diretta – non la recuperi più. La riavrà chi, tra un anno o un secolo, lo vedrà schiantarsi per una tromba d’aria o un fulmine.
Invece il 378 ha un nome e gliel’ho dato io: è il Platafico perché tra la forcella dei grossi rami alla base della chioma sta crescendo una pianticella di fico. Come sarà successo? Semplice: un uccellino che passava da quelle parti ha espulso dei semi ed eccolo lì, il fico cresciuto sull’albero, su un pugno di terra che gli ha fatto da culla tra un ramo e l’altro.
La cascina ha tre entrate e, ovviamente, tre uscite. C’è quella che dà sulla villa settecentesca dei conti – vale a dire i due fratelli, discendenti da una famiglia di antica nobiltà, conti per davvero – miei padroni di casa. Sono anche i proprietari di tutte le terre che stanno da questa parte del fiume: boschi e campi che coltivano direttamente. Di tanto in tanto tra le coltivazioni ci sono dei gruppi di case. Sono le frazioni abitate che compongono la Contea: così chiamo tra me e me la minuscola patria che da qualche anno mi ha accolto. Vicina alla metropoli eppure appartata, quasi fosse un po’ sospesa in un suo tempo tutto da definire.
A far da perno e centro dell’intera Contea è la piazzetta. Anzi sarebbe più giusto dire che la piazzetta è il palcoscenico della Contea. Da casa mia ci arrivo dal cortile, passando per una vecchia porticina verde chiusa a chiave. Prendi la chiave, apri la porticina ed entri in paese. Sulla piazzetta ci sono la chiesa, il municipio e la farmacia, la posta e la trattoria dei Trapper (sì, quella delle prime canzoni di Max Pezzali e degli 883) con i due lunghi tavoli di legno all’aperto. E, per concludere, anche due negozi dove si trova di tutto, purché sia buono e genuino. Perché gli abitanti della Contea sono abituati a trattarsi bene, almeno a tavola.
La terza e ultima uscita della cascina è il portone sotto la mia finestra: dà sulla strada verso il fiume, quella che ho percorso stamattina appena dopo aver preparato la sacca da viaggio.
I campi sono tutti bianchi. La pianura tra il Po e il Ticino è coperta da uno spesso strato di neve e fa cric e crac a ogni passo. Non ho molto tempo a disposizione, perché il traffico sulla tangenziale potrebbe regalare qualche sorpresa e non posso certo arrivare in ritardo al check-in, visto che voglio accaparrarmi il posto in settima fila, che sia C o D non importa. Basta che dia sul corridoio dell’aereo e a me va benissimo.
Anche se ho i minuti contati è da ieri sera, da quando lo strato di neve ha coperto tutto, che ho un’idea fissa con cui devo fare i conti. Anzi sono quattro parole, quelle di un proverbio che sentivo dai miei quando ero piccolo e abitavo in campagna (un’altra campagna, al di là del fiume), che voglio andare a verificare. Diceva il proverbio: “Sotto la neve, pane”. Sarà vero?
Non che mi aspetti davvero di trovare sotto i venti centimetri di neve una bella michetta fragrante di forno come quella che compero ogni giorno da Elvira, al negozietto dove si vende di tutto. Voglio semplicemente controllare se il frumento che ho visto seminare è sopravvissuto alle piogge torrenziali di novembre, alle gelate successive e ora all’ennesima nevicata.
Di solito le coltivazioni che ho attorno a casa si estendono a vista d’occhio: ettari ed ettari di riso, di mais, di frumento e, negli ultimi tempi, di soia. Il grano seminato dopo la fine dell’estate sta invece in un campetto minuscolo, tre pertiche in tutto, vale a dire un quinto di ettaro. Come raccolto, se tutto va per il meglio, ne esce qualche quintale di grano. Qualcosa di irrilevante rispetto alle migliaia di quintali di riso, o di mais, prodotti nei campi che stanno qui attorno.
Quello che stavolta è in ballo non è la quantità ma qualcosa di diverso, più sostanziale o, meglio, sostanzioso. Da quel campo il conte jr., il minore dei due fratelli padroni della cascina, dopo aver provveduto di persona a tutto – ad arare il campo e a passarlo con l’erpice, a concimarlo e a seminarlo – vuole tirarci fuori quanto grano basta a farsi il pane in casa per un anno. Mi ha spiegato che da qualche tempo ha la passione di farsi il pane, con la farina che finora ha comprato da un mulino non molto distante da qui. Sempre con quell’aria disarmante, da ragazzino cinquantenne che non ha smesso di andare in giro con la fionda a cercare bersagli, mentre in realtà si sobbarca tutte le corvée che gli spettano nel lavoro della cascina, ha pianificato ogni cosa: ha cercato un ritaglio di terra a lato della proprietà e ne ha fatto il luogo del suo esperimento.
Sapere, per caso, di questa sua decisione e vederlo all’opera per realizzarla è stato come aprire gli occhi. Ho cominciato a vedere quello che mi stava attorno e che non avevo mai guardato con attenzione: non era più solamente la campagna davanti alle mie finestre, i sentieri e i boschi che attraversavo con le mie camminate. Erano i campi e quello che nei campi succedeva. Era la complicata faccenda, quanto mai antica e tuttavia sempre piena di novità e di imprevisti, che consiste nel coltivare la terra. E trarne buona parte di quel che ogni giorno ci arriva nel piatto.
Se si vuol parlare della prima semina dalla quale è spuntato questo libro, allora è da quel campo che bisogna partire. E dalla domanda che ho cominciato a pormi – già, sorrido, proprio la stessa di una vecchia canzone di Battisti. Qualcuno se la ricorda? – “Che ne sai tu di un campo di grano?”…
Sotto la neve, pane
Un rettangolo sul bordo estremo dei campi, accanto al sentiero che scende al fiume. Spiccava subito agli occhi la differenza tra questo pezzetto di terra rivoltata dall’aratro e la distesa a perdita d’occhio dei campi di riso appena mietuti, con le stoppie gialle ben secche, visto che c’era stata l’estate più asciutta e calda degli ultimi anni.
La gigantesca mietitrebbia aveva appena finito il lavoro e già il giorno dopo, all’alba, quel campo l’ho trovato arato dal primo trattore che, come tutte le mattine, ho sentito avviarsi, scaldando il motore, nel cortile degli attrezzi, la spianata che sta al di là dei portici, dalla parte opposta del cortile dei platani.
Prima che iniziasse il nuovo mese il terreno era stato seminato. L’ho capito vedendo che da sotto i portici erano spariti i sacchi con la semente Frumento Bologna, diceva la scritta. Ho scoperto poi che è la specie di frumento tenero vernino – ovvero che sopporta la stagione fredda – più coltivata in Italia.
Se qualcuno avesse avuto la voglia di andare a vedere che cosa stava succedendo da quelle parti avrebbe visto, passando, solo un riquadro di terra scura, così intrisa d’acqua da sembrare argilla. Del frumento che stava là sotto nessun segno. Avevo cominciato a lavorare attorno all’idea di questo libro ma mi è successo di dimenticare proprio l’elemento che mi aveva spinto a muovere i primi passi. Del frumento mi sono ricordato esattamente al cadere della neve. Era la volta di andare a verificare.
Per questo non ho saputo resistere e, dopo il caffè e fatti i bagagli, ho preso per il sentiero. Sono arrivato al bordo del campo e mi sono chinato a smuovere la neve, giusto quanto bastava per vedere se sotto c’era qualcosa e non solo la terra. Li ho visti subito: steli come fili d’erba, disposti in fila, lungo una riga regolare. Dritti, pochi centimetri di altezza, a ciuffetti accostati gli uni agli altri. Mi hanno spiegato che il frumento dopo la semina impiega una ventina di giorni a germinare, poi cresce giusto quei pochi centimetri che ho visto. E resta così per tutto l’inverno, non rischiando mai di alzarsi ulteriormente, oltre la distesa protettiva del terreno.
Resiste all’inverno perché è piccolo e sta coi piedi per terra. “Sotto la neve, pane”? Sì, è vero, ma bisogna dar tempo al tempo. Per quelle pianticine, e anche per il cammino che mi riguarda, la strada da fare è molta. Chiudo la porta di casa, metto la sacca in macchina e saluto la cascina. Tra un’ora apre il check-in del volo per Reggio Calabria.
Funziona sempre così: chiedo il posto sul corridoio e poi mi torco il collo verso il finestrino per non perdere neppure per un istante la visione che sta là sotto. Mi piace guardare la Terra dall’alto. Riconoscere le città che l’aereo sta sorvolando. Dare un nome ai luoghi che intravedo e collegarli l’uno all’altro, il più velocemente possibile, così da star dietro al procedere del volo.
Mi piace, soprattutto, guardare l’Italia dall’alto perché, conoscendola un pochino, lo zampillare di immagini mette all’opera testa e cuore, accende curiosità, riporta a galla ricordi smarriti. Spesso si tratta di momenti che ho vissuto in quel certo posto che intravedo per una manciata di secondi prima che sparisca e arrivino altri luoghi e, dunque, altri pensieri.
A volte invece l’io ingombrante che mi accompagna si ritrae. Lascia che qualche altra parte di me, abituata a stare dietro le quinte, osservi tutto con un’attenzione distaccata che ogni volta mi stupisce. Dall’oblò scruta il paesaggio sottostante. Lo fa senza emozione, applicandosi a decifrare i segni tracciati sul tratto che stiamo sorvolando: li legge come fossero parole un po’ sfuocate scritte su pagine che hanno la forma di montagne e colline, vallate e fiumi.
Certo che la fitta trama del lavoro umano ha lasciato il suo segno ovunque, trasformando tutto. Mi viene in mente una pagina in cui Leopardi spiega che tutto quanto cade sotto i nostri occhi e che chiamiamo naturale in realtà di naturale ha ben poco, poiché quasi tutto è opera del lavoro umano, dai campi ai boschi allo scorrere dei fiumi. Un rimando che mi porta lontano, a libri letti tanto tempo fa.
Forse all’inizio di questo viaggio non c’è solo quel campo di grano, seminato accanto a casa mia. C’è anche qualche libro: come ad esempio la Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni che aveva proprio quel pensiero di Leopardi come citazione iniziale.
Di Sereni ho un’immagine imprecisa, per i tanti anni trascorsi. È lui che fa lezione in un’aula della Scuola Quadri dei giovani comunisti alle Frattocchie, vicino Roma, dove, poco più che ragazzino, sono capitato. Non ricordo l’argomento, però la sua Storia doveva essere uscita da qualche anno, anche se l’ho letta molto più tardi.
Vuoi vedere – mi chiedo mentre tasselli d’Italia appaiono dal finestrino dell’aereo e scompaiono sotto la trama delle nuvole – che anche in questo viaggio stanno scivolando dentro i più imprevisti e sommersi rivoli?
Forse non sono affatto un viaggiatore solitario come potrei apparire a chi mi ha visto salire, zainetto in spalla, sul volo partito da Linate e che tra poco più di un’ora atterra all’aeroporto di Reggio Calabria.
Forse, nella moltitudine che mi abita, sto portando in giro, invisibile a tutti ma non più a me stesso, anche quel ragazzino che sono stato e che forse sono ancora. È lui – il cuore aperto allo stupore, gli occhi pieni di domande – che mi rimette in cammino anche quando la stanchezza è troppa. Quando la strada da seguire sembra tutt’altro che chiara.
La pianura compare di tanto in tanto sotto le nuvole: ecco la riga dritta con cui linea ferroviaria e autostrada infilano le città dell’Emilia. Poi, appena superata Parma, appaiono le montagne e le vallate dell’Appennino, che scompaiono quasi subito, appena l’aereo sale di quota.
È dopo l’Elba che, procedendo sul mare, si rivede uno sprazzo di sole: ho fatto in tempo per un istante a scorgere la Capraia, e forse ho visto persino quell’alberghetto davanti al Castello dove sono stato una vita fa e la strada che dalla sommità scende sino al porto.
Sino a Ponza l’aereo viaggia sul mare: poco da vedere. Ne approfitto per riordinare un po’ di carte che ho stampato e portato con me. Sono la cornice generale dentro cui andrò a piazzare i frammenti e le tappe di questa mia esplorazione sul coltivare italiano. Mi piace scorrere i dati riassuntivi da quassù, come se davvero avessi sotto gli occhi quel tutto che, per assaggi ed esempi, andrò a tentare di conoscere.
Un flipper impazzito
Quello che si vede dall’alto è un’Italia semplice. Salta agli occhi la netta suddivisione tra la superficie occupata da costruzioni e opere umane e la terra, che seppure nelle forme più varie – roccia o bosco, giardino, campo coltivato o radura abbandonata – sta ancora libera sotto il cielo. Non ancora coperta dal cemento e dall’asfalto.
Questa parte della penisola viene incontro soprattutto quando si vola sopra la dorsale appenninica: di giorno è un mantello verde, interrotto ai lembi, verso i due versanti tirrenico e adriatico, da aree frastagliate e stinte. Qui le costruzioni si addensano progressivamente attorno alle grandi città, in quello che gli urbanisti definiscono “sprawl urbanistico”, cioè l’espandersi della metropoli che, facendosi via via sempre più periferia, perde ogni pianificazione razionale. Si trasforma in una colata di caotiche costruzioni. È una massa inarrestabile che ricorda l’avanzata dell’invasione gelatinosa che appare nella sigla di Blob.
La pianura del Po è quella che è stata investita più massicciamente dal Blob, e questo lo si capisce bene arrivando su Milano di notte. Visti dall’alto, buio e zone illuminate raccontano la stessa semplice e contrapposta divisione della penisola: l’Appennino è una macchia scura, interrotta di tanto in tanto da luci tremolanti, mentre la pianura, appena l’aereo comincia a scendere, si presenta come un fitto reticolo luminoso che pulsa come un flipper impazzito.
In Italia, ogni giorno, cento ettari di terreno agricolo vengono persi per sempre, divorati dalle costruzioni.
Questo spiega perché dal boom economico a oggi la superficie agricola è scesa da 18 a 13 milioni di ettari. Si riducono i campi coltivati e l’Italia, che aveva raggiunto la piena autonomia alimentare, sta dipendendo sempre più dagli altri. Persino per il pane non siamo più autosufficienti: il 60 per cento del frumento tenero lo importiamo dagli Stati Uniti e dall’Ucraina, dalla Francia, dalla Germania e perfino dall’Austria.
Il Paese ben coltivato, amato dal sole e prediletto dal clima, quello che forniva il meglio dei cereali, della frutta e della verdura a tutti gli altri Paesi d’Europa, riuscirà a cambiare rotta?
E chi saranno i protagonisti di questo cambiamento? Cosa li potrà sostenere in questa sfida che non coinvolge solo il Pil e l’export, la tradizione e l’innovazione, il lavoro e la qualità (anche dell’ambiente), ma riassume qualcosa di più rilevante e duraturo che ci riguarda tutti?
Un viaggio alla scoperta del Paese ben coltivato deve fare i conti con le nostre radici e con la terra su cui posiamo i piedi ma anche con gli orizzonti interiori che ognuno dà alle proprie giornate. Cominciando da quel rito antico del nutrirsi e del condividere il cibo, lo spezzare insieme il pane, si diceva un tempo, ormai banalizzato da consumi e abbondanza.
Questo viaggio non procede lungo il filo di un percorso lineare, pianificato a tavolino, dove ogni tessera del puzzle, una mossa dopo l’altra, va ordinatamente a prendere posto.
È un mosaico: procede per tentativi. Per intuizioni e verifiche. Per incontri che confermano e per passi a vuoto che talvolta smentiscono luoghi comuni o fanno emergere impreviste verità.
È un viaggio dove si saltella – come si faceva da bambini sui riquadri del “gioco del Mondo” – su una terra a cui si va per raccogliere storie che hanno volti diversi e altrettante voci. Accanto a queste voci c’è il sommesso fruscio dei fogli del calendario. Filano via veloci come le stagioni che sto per attraversare.