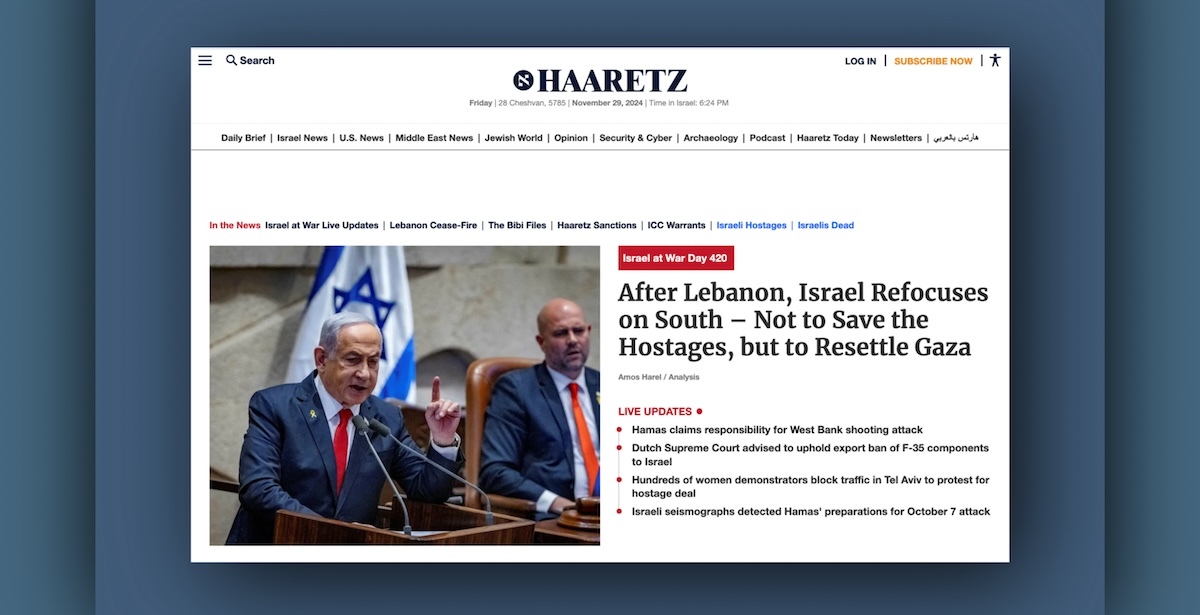Come stanno i giornali italiani
Testata per testata, il punto della situazione su crisi, licenziamenti, cassa integrazione, prepensionamenti e assunzioni (pochissime) nei quotidiani
di Francesco Marinelli – @frankmarinelli

Nell’ambito della grande e globale crisi dei giornali cartacei – in questo articolo parleremo dei quotidiani, ma il problema riguarda notoriamente anche le riviste – anche per la stampa italiana il 2012 è stato un anno molto difficile. Si è ridotta la quota dei finanziamenti pubblici, che rappresenta per molte testate una significativa fonte di introiti, ma soprattutto sono continuati a diminuire i guadagni dalla pubblicità. Nei primi nove mesi del 2012 il mercato pubblicitario del settore dell’informazione, nell’insieme, è arretrato del 10,5 per cento, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La tendenza va avanti così da anni e porta con sé conseguenze sulle redazioni e, alla fine della fiera, sul prodotto finale, quello che arriva nelle mani dei lettori (anche questi sempre di meno, con poche eccezioni).
Per i quotidiani nel 2012 la raccolta pubblicitaria è diminuita del 13,9 per cento, mentre per i periodici del 16,2 per cento. Nelle redazioni ci sono stati e ci saranno piani di riorganizzazione e ristrutturazione, con lo scopo principale di tagliare i costi sul lavoro, cioè giornalisti e poligrafici. I poligrafici sono i dipendenti di un giornale che non sono giornalisti, principalmente i tipografi e gli impiegati amministrativi, ma non i dirigenti (come il direttore marketing o il direttore editoriale). Secondo i dati dell’INPGI, l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, le aziende che nell’ultimo anno hanno fatto ricorso allo “stato di crisi” sono state 58.
Per “stato di crisi” si possono intendere diverse cose, ma parliamo in sostanza di ammortizzatori sociali: prepensionamenti, cassa integrazione, contratti di solidarietà. I giornalisti coinvolti, sempre secondo l’INPGI, sono almeno 1.139. Qui bisogna aprire una parentesi: quando si parla di “giornalisti”, come nei dati forniti dall’INPGI, si fa riferimento alle persone iscritte all’Ordine dei Giornalisti come praticanti o come professionisti. Questo perché in Italia la legge – la legge 69 del 1963 – stabilisce che chi vuole esercitare la professione giornalistica debba obbligatoriamente iscriversi all’Ordine dei Giornalisti e sostenere un esame di Stato, al termine di un periodo di praticantato. Questo non ha evitato, però, che moltissime persone oggi svolgano professioni giornalistiche all’interno di redazioni giornalistiche senza un contratto giornalistico, ma con contratti di varia altra natura (e molto minori retribuzioni e tutele): dai co.co.co ai co.co.pro. alle partite IVA. E poi ci sono i freelance: collaboratori che vengono pagati ad articolo ma che non fanno parte degli organici redazionali. Nella maggior parte dei casi le collaborazioni sono tra le prime cose a essere tagliate, e a volte il punto di partenza delle trattative sindacali, allo scopo di tutelare i giornalisti della redazione, è proprio il taglio radicale dei contratti di collaborazione.
Ma dicevamo della crisi dei giornali italiani. In alcuni casi, pochi, la situazione sembra stabile, grazie al fatto di non aver risentito molto del calo dei ricavi pubblicitari: su tutti il Fatto Quotidiano (ma ne parleremo più avanti). In altri ancora i piani di riorganizzazione prevedono anche nuovi investimenti, per esempio nella tecnologia, con sviluppi di nuovi sistemi di impaginazione e un rafforzamento della “forza lavoro”, per quanto riguarda le redazioni online dei giornali. La tendenza, a maggioranza, non prevede comunque nuove assunzioni né la regolarizzazione dei precari, ma soltanto una redistribuzione interna delle forze.
Questa “fotografia” sullo stato dei quotidiani e dei giornalisti si concentra in particolare su quanto sta accadendo nei maggiori quotidiani nazionali, anche in base alle informazioni raccolte parlando con i vari rappresentanti dei comitati di redazione (CDR), cioè gli organi di rappresentanza sindacale dei giornalisti. La situazione appare complessa e in generale negativa: e in alcuni casi non è stato possibile raccogliere informazioni per via delle trattative in corso, come nel caso della Stampa. Prima di descrivere qual è la situazione testata per testata, però, è bene spiegare cosa comporta per un giornalista, anche in termini di retribuzione, andare in prepensionamento o l’applicazione di un cosiddetto “contratto di solidarietà”.
I prepensionamenti
Nel 2009 tre diversi provvedimenti hanno modificato la legge quadro sulle imprese editrici 416 del 1981: la legge 2/2009, la 14/2009 e la 33/2009, che regolano la cassa integrazione e i prepensionamenti nel settore dell’informazione. L’onere dei prepensionamenti è ora a carico dello Stato, che ha istituito un Fondo statale per i prepensionamenti dei giornalisti, con una dotazione di 20 milioni di euro all’anno. Questo significa che a pagare l’assegno per la pensione, fino al raggiungimento dei requisiti standard, sarà lo Stato e non più l’INPGI.
Se questo fondo di 20 milioni di euro non dovesse essere sufficiente, per coprire il costo dei prepensionamenti, è previsto un contributo aggiuntivo, da parte degli editori, pari al 30 per cento del trattamento di fine rapporto, per ogni singolo prepensionamento richiesto. Le imprese editoriali che vogliono utilizzare questo tipo di ammortizzatore sociale devono fare innanzitutto richiesta di attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), per ristrutturazione o riorganizzazione, a partire da una crisi aziendale. La richiesta di prepensionamento è volontaria e può riguardare soltanto i giornalisti professionisti “dipendenti” dell’azienda.
Gli anni di “scivolo”
Rispetto alle norme che regolano la pensione di vecchiaia, il giornalista che va in prepensionamento può ritirarsi dal lavoro con un massimo di sette anni di anticipo. In caso di prepensionamento, comunque, l’assegno mensile è ridotto, rispetto a quello che si sarebbe preso una volta raggiunti i 65 o i 60 anni di età. La prima riduzione è provvisoria ed è legata agli anni che mancano alla pensione di anzianità, la seconda riduzione rappresenta un vero e proprio “abbattimento” definitivo dello 0,5 per cento, per ogni anno di scivolo.
La cassa integrazione
A differenza del prepensionamento la cassa integrazione non è volontaria, ma dipende dal programma dell’azienda, in base all’organizzazione del lavoro decisa dal direttore e contrattata poi a livello sindacale. Le aziende editoriali possono richiederla per rilevanza sociale, per ristrutturazione e riorganizzazione, nei casi di fallimento, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa. La CIGS ha una durata massima di 12 mesi per i casi di crisi aziendali, di 18 mesi per le procedure giudiziali, di 24 mesi per riorganizzazione e ristrutturazione. E comunque, un’azienda non può superare i 36 mesi di intervento della CIGS, nell’arco di cinque anni.
Anche in questo caso il trattamento di cassa integrazione riguarda soltanto i giornalisti dipendenti: per i collaboratori non regolarizzati non è prevista nessuna tutela. Nel periodo di cassa integrazione, a meno che non ci siano accordi volontari di spontanea decurtazione della retribuzione (è stato per esempio il caso di Liberazione, anche se la proposta non è stata accettata), lo stipendio dei giornalisti è pari all’80 per cento della propria retribuzione, con un tetto massimo stabilito annualmente per tutti i lavoratori. Questo assegno è a carico dell’INPGI, anche se in alcuni casi può essere anticipato dall’azienda. Se alla fine del periodo di cassa integrazione le difficoltà aziendali non sono state superate, il datore di lavoro può decidere di fare dei licenziamenti collettivi.
I contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà prevedono una riduzione della retribuzione proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro: per esempio, per una “solidarietà” al 10 per cento, lo stipendio del giornalista viene ridotto del 4 per cento, per una “solidarietà” al 20 per cento, lo stipendio del giornalista viene ridotto dell’8 per cento, e così via. Questo tipo di contratto può durare tra i 12 e i 24 mesi, rinnovabile per altri 24 mesi (in accordo tra le parti).
Questo dunque è il quadro normativo che è stato utilizzato dalla maggior parte delle aziende editoriali italiane nell’ultimo anno, con alcune eccezioni: in alcuni casi, infatti, non si può ricorrere ai prepensionamenti, per il semplice fatto di avere nelle redazioni giornalisti che non arrivano, né si avvicinano, alla soglia dei 56-58 anni. Al di là della riorganizzazione delle redazioni, abbiamo anche cercato di capire come si stanno ristrutturando i giornali, a livello di prodotto editoriale. Ci sono due tendenze generali: quella che prevede l’anticipo della chiusura del giornale e quella della riorganizzazione delle mansioni, per i giornalisti, che sono sempre più integrate tra il giornale di carta e il sito Internet del quotidiano.
Nella prossima pagina: come stanno Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Repubblica, Stampa, Sole 24 Ore, Avvenire, Europa, il Foglio, il Fatto, Milano Finanza.
Corriere della Sera
Il gruppo editoriale sta discutendo il piano che il nuovo amministratore delegato di RCS, Pietro Scott Jovane, ha presentato agli azionisti. Intanto, da dicembre, la redazione ha adottato un nuovo sistema editoriale, che è lo stesso per la carta e per il sito. Il sistema editoriale è il software, l’infrastruttura tecnologica, che permette di “comporre” il giornale. Dai prossimi mesi il giornale sarà chiuso alle 22.30. Si era già parlato del possibile taglio di circa 100 redattori, qualche mese fa (la metà in prepensionamento), ma la richiesta non è ancora stata presentata ufficialmente. Non sono invece stati richiesti contratti di solidarietà, e comunque ogni tipo di operazione e richiesta non arriverà prima della pubblicazione della prossima trimestrale. La redazione del Corriere della Sera è composta da 360 giornalisti per il giornale di carta e da 35 giornalisti per la redazione online.
La Gazzetta dello Sport
Oltre a un nuovo sistema editoriale, ci saranno anche investimenti per alcune nuove funzioni sui tablet. L’azienda sta lavorando da tempo a un nuovo piano triennale di riorganizzazione che doveva essere presentato il 19 dicembre 2012 ma che, spiegano i rappresentanti dei giornalisti, “è apparso vuoto”. Nonostante il calo dei ricavi pubblicitari il bilancio del 2012 è stato comunque positivo. L’azienda aveva aperto uno stato di crisi nel 2009, che è durato fino al 2011: in questo arco di tempo ci sono stati 25 prepensionamenti ma sono stati anche assunti 15 giornalisti precari.
Il gruppo RCS
Le banche d’affari che dovrebbero costituire il consorzio di garanzia per un aumento di capitale da circa 400 milioni di euro starebbero aspettando di verificare il piano industriale, che sarà presentato dall’amministratore delegato Pietro Scott Jovane. A fine settembre l’indebitamento del gruppo era di 875,6 milioni di euro. Secondo le disposizioni di legge, comunque, il gruppo RCS avrebbe ancora un anno di tempo per decidere sulla ricostituzione del capitale. Il piano industriale, le cui linee guida sono state presentate a dicembre, dovrebbe essere pronto per il consiglio di bilancio in programma tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.
Repubblica
Il CDR di Repubblica ha spiegato che dal 2012 la situazione non è cambiata: non ci sono stati e non saranno annunciati stati di crisi. Il gruppo editoriale L’Espresso, hanno detto, è in attivo, a differenza di molti altri gruppi editoriali, anche se risente della situazione generale di crisi degli investimenti pubblicitari.
La Stampa
Alla Stampa il CDR è in trattative con l’editore e non ci saranno novità né comunicazioni ufficiali prima della metà di febbraio.
Il Sole 24 Ore
Il bilancio corrente del giornale è negativo da qualche anno: il Gruppo del Sole 24 Ore ha chiuso i primi nove mesi del 2012 con una perdita di 35 milioni di euro. Dal 1 febbraio 2012 è stato attivato il contratto di solidarietà, che durerà fino al 31 gennaio 2014, con una riduzione dello stipendio del 14 per cento (e quindi anche, in proporzione percentuale, una riduzione dell’orario di lavoro dei giornalisti): in sostanza, tre giorni di “riposo” in più al mese. Questo per quanto riguarda la riduzione dei costi dell’editore: lo stipendio dei giornalisti, integrato per il 20 per cento dal fondo statale e per il 60 per cento dall’INPGI, è diminuito in realtà del 2,5 per cento.
Per accettare il contratto di solidarietà è stato fatto un referendum interno alla redazione, a cui ha risposto favorevolmente l’80 per cento dei giornalisti (in tutto sono 256). L’accordo con l’editore ha previsto anche un piano di rilancio multimediale: dal 20 gennaio è online una nuova versione del sito e sono stati lanciati dei nuovi piani di abbonamento per i lettori, per aumentare le vendite del giornale in formato digitale. Ci sono state anche riorganizzazioni nel lavoro, con un frazionamento dei turni e una serie di riunioni (3-4 al giorno) che coinvolgono tutte le redazioni, sia della carta che del sito.
Avvenire
Nel 2012 non ci sono stati cambiamenti, nonostante la raccolta pubblicitaria sia stata – dicono – un “disastro”. Nei prossimi mesi verrà aperto lo stato di crisi e sono previsti una decina di prepensionamenti, con una riorganizzazione della redazione.
Europa
Il 1 novembre 2012 è stato attivato, per due anni, il contratto di solidarietà al 30 per cento: in sostanza, 6 giorni di “riposo” in più al mese. Sono stati chiusi due centri di stampa ed è stata ridotta la foliazione del giornale, da 6 a 4 pagine. Da una parte sono stati quindi ridotti i costi strutturali, mentre dall’altra sono stati fatti investimenti sul sito. I redattori sono gli stessi e, con alternanza nei turni e degli orari di lavoro, produrranno materiali anche per il sito. Non ci sono stati e non sono previsti prepensionamenti, ma le assunzioni sono state bloccate ed è stato ridotto il budget per le collaborazioni.
Il Foglio
Non ci sono stati prepensionamenti nell’ultimo anno né sono state fatte richieste per il 2013. E non c’è neanche, in prospettiva, la possibilità che venga richiesto lo stato di crisi. È stato invece attivato il contratto di solidarietà al 31 per cento. La foliazione del giornale non subirà cambiamenti, mentre saranno adottati alcuni progetti di sviluppo per il sito.
Il Fatto Quotidiano
È il giornale che sembra essere nella situazione migliore, sia per quanto riguarda il quotidiano cartaceo, sia per quanto riguarda il sito: non ci sono situazioni a rischio. Il 2012 è stato chiuso con l’attivo di bilancio (per il quarto esercizio consecutivo), non sono stati aperti stati di crisi né fatti prepensionamenti. Il giornale, anche nella redazione online, ha aumentato il numero dei giornalisti. Inoltre si sta investendo sulla web tv: nel 2012 sono stati allestiti due studi televisivi per le dirette streaming. Anche sul giornale di carta ci saranno delle novità, con un rafforzamento della seconda parte, soprattutto nella sezione culturale (l’inserto Saturno, diretto da Riccardo Chiaberge, era stato chiuso dopo un periodo travagliato).
Milano Finanza
L’ultima trimestrale del gruppo è stata in perdita e da marzo del 2012 è stato attivato il contratto di solidarietà, che durerà fino a febbraio 2013 e probabilmente sarà rinnovato. Per quanto riguarda il settore dei periodici del gruppo, alcuni giornalisti potrebbero andare in cassa integrazione.
Nella prossima pagina: come stanno Italia Oggi, il Messaggero, il Tempo, il Manifesto, l’Unità, Liberazione, Pubblico, il Giornale, il gruppo Quotidiano Nazionale e il Corriere dello Sport.
Italia Oggi
A marzo 2012 è stato firmato un accordo di cooperazione e solidarietà che durerà fino a febbraio 2013: si tratta di una riduzione dello stipendio concordata – non dell’attivazione di un contratto di solidarietà – con lo scopo di “lavorare meno, ma lavorare tutti”. L’azienda ha risparmiato il 10 per cento lordo sul costo del lavoro, che per i trenta giornalisti della redazione ha significato l’8 per cento in meno (netto) di stipendio. In cambio della riduzione dello stipendio, l’accordo prevede l’impegno dell’azienda a non fare licenziamenti. Non ci sono stati prepensionamenti e non sono previste assunzioni.
Il Messaggero
A maggio 2012 è iniziato lo stato di crisi, che durerà fino ad aprile 2014, ma non sono stati attivati contratti di solidarietà. Sono previsti circa venti prepensionamenti e un certo numero di assunzioni, non precisato, “per un saldo minimo”.
Il Tempo
Lo stato di crisi del giornale è stato avviato a marzo 2012, per un anno. Ci sono stati cinque prepensionamenti. L’azienda sta invece investendo per potenziare il sito Internet, anche a livello tecnologico.
Il Manifesto
Dall’inizio dell’anno il Manifesto è tornato in edicola, salvando per il momento “la maggior parte dei posti di lavoro”. Si è conclusa la fase della liquidazione coatta amministrativa ed è nata una nuova cooperativa. Anche all’interno della redazione ci sono stati molti cambiamenti, con l’abbandono di alcuni dei fondatori e di altri giornalisti. Il 15 febbraio, di fatto, è stata avviata la liquidazione della cooperativa editrice “manifesto spa”. A giugno 2012 è stato trovato un accordo con il ministero del Welfare per i 68 dipendenti che erano rimasti: è stata avviata una cassa integrazione a rotazione che ha dimezzato l’organico, lasciando al lavoro 36 giornalisti per turno e 34 in cassa integrazione a rotazione.
L’Unità
A luglio 2012 è stato attivato il contratto di solidarietà per i giornalisti (l’ultimo di una serie), che si chiuderà a fine 2013. Cinque giornalisti sono andati in prepensionamento a fine 2011. Si parla anche di investimenti sul sito a livello tecnologico, non meglio definiti.
Liberazione
Il caso di Liberazione è stato tra quelli più complicati. Il giornale non esce più dal primo gennaio 2012. I giornalisti hanno occupato la redazione per tre mesi. Durante i tre mesi di occupazione il giornale è stato pubblicato in formato pdf. Nei due anni precedenti era stato applicato il contratto di solidarietà al 50 per cento. I giornalisti avevano poi proposto di ridursi ancor di più lo stipendio, per un periodo limitato, pur di continuare a lavorare, e investire quei soldi nel giornale. La proposta è stata rifiutata e l’editore ha deciso di sospendere anche la pubblicazione del giornale in pdf. Da gennaio 2013 il giornale è pubblicato soltanto online: il sito è aggiornato per sette ore al giorno e per cinque giorni alla settimana. Tutti i giornalisti, circa trenta, sono in cassa integrazione: insieme a loro anche venti poligrafici. Oggi al sito lavorano quattro persone: il direttore e il vicedirettore, che sono fissi, e due giornalisti, a turno, tra tutti quelli in cassa integrazione: nel mese di gennaio i due giornalisti hanno lavorato per un mese, da febbraio si lavorerà due alla volta per tre settimane ciascuno.
Pubblico
Il giornale diretto da Luca Telese è stato fondato nel settembre 2012 ma ha chiuso soltanto tre mesi dopo, il 31 dicembre 2012. La redazione di Pubblico era formata da circa venticinque giornalisti. Il giornale ha chiuso per aver mancato il punto di pareggio delle copie vendute, in base a quello che era il piano di business previsto. Con una lettera, i giornalisti della redazione, che non sanno se andranno in cassa integrazione, avevano criticato il piano imprenditoriale e nelle ultime settimane è uscito sulla stampa qualche nome riguardo a possibili nuovi investitori, per esempio il finanziere Alessandro Proto, la cui offerta è stata però rifiutata da Luca Telese: l’offerta sarebbe stata di 2 milioni di euro e il rifiuto sarebbe stato deciso per motivi editoriali e non economici. Si è detto – ma non sono arrivate conferme – che Alessandro Proto, dopo il rifiuto di Pubblico, abbia fatto un’offerta di 4,5 milioni di euro per rilevare una quota del 16,26 per cento del Fatto Quotidiano. Di Proto si è parlato anche per via di una sua rapida candidatura alle primarie del PdL e per via di un’indagine per truffa e aggiotaggio ai suoi danni.
Libero
A maggio 2012 è stato firmato un contratto di solidarietà per due anni. Le assunzioni sono bloccate ma non sono previsti dei prepensionamenti, anche perché i redattori hanno un’età media piuttosto bassa. Da poco la proprietà ha cambiato la concessionaria pubblicitaria. Il sito Internet sta ottenendo dei buoni risultati e per questo si parla della possibilità che nei prossimi mesi si facciano degli investimenti sul versante online.
Il Giornale
L’ultimo stato di crisi è stato attivato due anni fa, per 24 mesi, durante il quale ci sono stati 12 prepensionamenti. Nel 2012 non sono stati richiesti stati di crisi né se ne prevedono. Dopo una riduzione del personale negli ultimi anni, nel 2012 sono stati assunti tre giornalisti: dopo alcune ristrutturazioni nella redazione, la situazione si è momentaneamente stabilizzata. Anche il Giornale avvierà la chiusura giornaliera anticipata, con riduzioni graduali fino al 2014.
Quotidiano Nazionale
A giugno 2012 è stato attivato il contratto di solidarietà, che durerà fino a maggio 2014, per un totale di tre giorni di lavoro in meno al mese e la ritenuta corrispettiva in percentuale sullo stipendio. Sono stati fatti diciannove prepensionamenti e potenzialmente ce ne potrebbero essere altri quindici, in base ai requisiti dei redattori.
Il Gruppo QN
L’accordo sullo stato di crisi, oltre al Quotidiano nazionale, riguarda anche le altre testate della Poligrafici Editoriale, cioè il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Quotidiano.net. Lo stato di crisi è iniziato il 1 giugno 2012 e finirà il 31 maggio 2014: sono stati previsti, nell’intero gruppo, 55 esuberi, attraverso la cassa integrazione straordinaria finalizzata ai prepensionamenti (su base volontaria) e il contratto di solidarietà con una percentuale del 14 per cento. Il governo ha detto che, rispetto alla richiesta di 33 prepensionamenti, se ne potranno attivare per il momento soltanto quattro, distribuiti uno per ogni testata, escluso Quotidiano.net. Per i giornalisti coinvolti nel contratto di solidarietà la percentuale iniziale sarà del 14 per cento, che si abbasserà poi nei successivi due anni. In tutto sono coinvolti ben 364 giornalisti.
Corriere dello Sport-Stadio
Il bilancio d’esercizio del 2012 si chiuderà molto probabilmente in forte perdita. Un piano di riorganizzazione prevede l’unificazione delle redazioni tra i giornalisti del giornale e quelli del sito. Sono previsti tagli dei costi che riguardano i giornalisti: dovrebbero essere prepensionati 12 giornalisti, circa il 20 per cento dell’attuale redazione. Sempre riguardo al taglio dei costi, il giornale dovrebbe rinunciare a seguire gli eventi della Formula Uno e del Motomondiale. Si sta pensando di aprire una web-radio e una web-tv.
Che cosa dice l’INPGI
Paolo Serventi Longhi, vicepresidente dell’INPGI, ha detto che nel 2012 l’istituto di previdenza dei giornalisti ha pagato, in ammortizzatori sociali, 29 milioni di euro, mentre nel 2011 erano stati 18 milioni. Per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, dal 2011 al 2012 c’è stato un aumento dal 4 per cento al 7 per cento. La CIGS negli ultimi tre anni è aumentata del 400 per cento, mentre il numero dei contratti di solidarietà del 450 per cento. «Le prospettive sono pesanti», ha spiegato, «quasi tutti stanno portando avanti piani di riorganizzazione e ristrutturazione». Paolo Serventi Longhi ha comunque rassicurato sulla capacità dell’INPGI di poter far fronte a questa situazione: i conti dell’istituto sono in attivo per alcuni milioni di euro, anche grazie agli investimenti fatti sul patrimonio immobiliare. In sostanza, ha detto Paolo Serventi Longhi, l’INPGI «è in grado di garantire il suo ruolo per altri cinquant’anni di sostenibilità del nuovo sistema».
I contributi all’editoria
Il 12 luglio 2012 è stato approvato il decreto legge sul riordino dei contributi all’editoria che contiene una disciplina transitoria, in attesa di un disegno di legge che dovrà varare il governo (entro 12 mesi dall’approvazione del decreto), per definire i nuovi criteri d’assegnazione dei contributi pubblici alla stampa di partito, alle cooperative giornalistiche, e in generale in proporzione alle vendite di quotidiani e periodici.
In sostanza i criteri sono più selettivi, rispetto a quelli della legge precedente: l’obiettivo è razionalizzare e rendere più trasparenti i contributi, che saranno concessi in base alle vendite effettive e non più in proporzione alla tiratura. È stata cioè alzata la percentuale di vendita: deve essere pari, rispetto alle copie distribuite, ad almeno il 25 per cento per le testate nazionali e ad almeno il 35 per cento per le testate locali. Questa quota, comunque, non potrà superare quella distribuita nel 2010, come punto di riferimento. Inoltre il provvedimento ha eliminato il tetto massimo per le entrate pubblicitarie.
foto: GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images