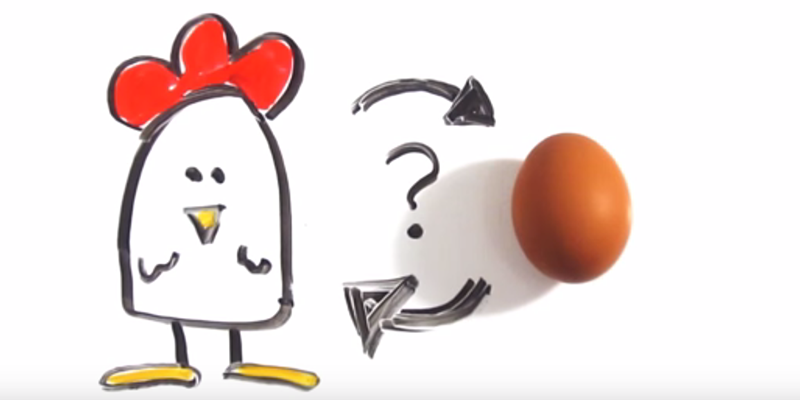C’è un motivo se Fratelli d’Italia insiste sulla legge elettorale
La vuole cambiare in fretta per non correre rischi in vista del voto nel 2027: e qualche rischio in effetti c'è

Poche ore dopo la chiusura dei seggi in Puglia, Campania e Veneto, quando ancora il risultato definitivo si andava delineando, l’importante dirigente di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ha detto che bisogna cambiare in tempi rapidi la legge elettorale nazionale. Donzelli ha ribadito che questi tre anni di governo hanno dimostrato il valore della stabilità, che però in questo caso è stata ottenuta solo perché il centrosinistra, alle elezioni politiche del 2022, si era presentato diviso, dando un enorme vantaggio alla coalizione guidata da Meloni; se però, come è avvenuto nelle ultime elezioni regionali, le opposizioni si ricompattassero, l’esito delle elezioni nazionali sarebbe probabilmente un sostanziale pareggio, e questo non renderebbe possibile formare alcuna maggioranza parlamentare solida.
– Leggi anche: I risultati delle elezioni regionali in sette grafici
Il ragionamento di Donzelli ha un suo fondamento, ma ha almeno due difetti. Il primo riguarda il fatto che architettare un sistema elettorale prendendo spunto dalla situazione politica del momento rischia di produrre, nel migliore dei casi, una legge elettorale che è utile solo fintantoché la fase politica non muta, e in Italia muta piuttosto spesso. Il secondo, complementare al primo, è che dietro alla teoria generale c’è un interesse molto particolare di Meloni: cambiare la legge elettorale serve ad aumentare le sue possibilità di rivincere nel 2027.
La furbizia insita nel discorso di Donzelli è simile a quella di altri politici del passato: si spiega così l’anomala proliferazione di leggi elettorali in Italia. Negli ultimi 40 anni, nessun altro paese occidentale ha cambiato le leggi elettorali con tanta frequenza, fondamentalmente perché ogni governo ha provato a indirizzare il voto a proprio favore modificando le regole del gioco a ridosso delle elezioni (senza peraltro mai riuscire nel proprio intento).

Il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli, della Lega, alla Camera, il 15 ottobre 2025 (Mauro Scrobogna/LaPresse)
Sta di fatto che dalla scorsa estate i partiti di maggioranza hanno iniziato a lavorare a una riforma elettorale: dapprima con grande discrezione, poi con un tramestio sempre più evidente. E da lunedì ne hanno parlato pubblicamente. Al momento è una discussione tutta interna alla destra: le trattative sono condotte dallo stesso Donzelli per FdI, da Stefano Benigni per Forza Italia, e dai leghisti Andrea Paganella e Roberto Calderoli. Ma anche i leader ne hanno parlato, saltuariamente. Si sa abbastanza bene qual è lo schema su cui stanno ragionando: un proporzionale puro (tanti voti prendi, tanti parlamentari fai eleggere, in proporzione appunto) ma con un robusto premio di maggioranza, ovvero un bonus che consente alla coalizione che arriva prima di assicurarsi una maggioranza sufficientemente ampia di deputati e senatori.
Le ragioni per cui Meloni vuole cambiare la legge elettorale sono varie. Innanzitutto per eliminare i collegi uninominali. L’attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, prevede infatti che circa due terzi dei seggi parlamentari siano attribuiti su base proporzionale, e circa un terzo sulla base degli scontri diretti nei collegi uninominali, quelli dove ogni coalizione presenta un proprio candidato, e chi prende più voti degli altri ottiene l’elezione (questo sistema è detto invece maggioritario). Ciò per Meloni costituisce un doppio problema. Da un lato, essendo il partito egemone della coalizione, lei è di fatto obbligata a cedere agli alleati più seggi di quelli che spetterebbero loro. Per esempio è per questo che oggi la Lega, pur avendo ottenuto un terzo dei voti di FdI (l’8,8 contro il 26 per cento), ha una rappresentanza parlamentare che è più della metà di quella di FdI (65 contro 116 alla Camera; 29 contro 63 al Senato).
Dall’altro lato, coi collegi uninominali conta molto di più la distribuzione del voto nelle varie aree d’Italia, soprattutto per quel che riguarda il Senato. Cioè, in grande sintesi, con i collegi uninominali non è tanto importante vincere di molto in pochi collegi, ma vincere anche di poco in molti collegi: perché significa ottenere più seggi di conseguenza, pur avendo meno voti complessivi. E questo darebbe un implicito vantaggio al centrosinistra, se si presentasse al voto unito com’è oggi. Secondo alcune simulazioni che proiettano sul voto del 2022 una sfida bipolare, dunque con la coalizione progressista compatta e non divisa in tre diversi fronti come fu allora, Meloni potrebbe contare su almeno una ventina di senatori in meno, e dunque in sostanza senza una maggioranza al Senato.
Nel dettaglio, stando a queste simulazioni, il centrosinistra guadagnerebbe 1 senatore in Piemonte, 1 in Lombardia, 2 in Liguria, 3 in Emilia-Romagna, 3 in Toscana, 1 nelle Marche, 3 nel Lazio, 3 in Campania, 5 in Puglia, almeno 1 in Sicilia e 1 in Sardegna. Vari altri vinti agevolmente dal centrodestra nel 2022 sarebbero inoltre in bilico. Si tratta di proiezioni molto discutibili, nel senso che non tengono conto di tutte le variabili che potranno esserci da qui fino alle elezioni del 2027, e di eventuali ricomposizioni del quadro politico. Ma in definitiva, è sulla base di questi calcoli che nel centrodestra si sono convinti della necessità di cambiare la legge elettorale.
L’altra pretesa di Meloni consiste nell’indicare sulla scheda elettorale il nome del candidato presidente del Consiglio della coalizione. Verrebbe così introdotta, surrettiziamente, quella stessa modifica che FdI avrebbe voluto adottare con la riforma costituzionale del cosiddetto premierato, la cui approvazione si è rivelata però più lunga e complicata del previsto. Per una sorta di effetto trascinamento, il partito che esprime il candidato a guidare il governo ne avrebbe un beneficio consistente, e questo spiega perché né Matteo Salvini né Antonio Tajani sono entusiasti di questa proposta: l’unica a guadagnarci, a loro discapito, sarebbe proprio Meloni.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e quello degli Esteri Antonio Tajani alla Camera, il 28 maggio 2025 (Mauro Scrobogna/LaPresse)
Ma le difficoltà per FdI sono costituzionali oltreché politiche. Il premio di maggioranza è sempre un po’ un’incognita. La Corte costituzionale, esprimendosi su un’altra legge elettorale (l’Italicum), nel 2017 stabilì il principio per cui il correttivo maggioritario al voto non può essere troppo consistente, perché altrimenti distorcerebbe la rappresentatività: insomma, il premio di maggioranza deve essere limitato (in quel caso, consentendo a chi raggiungeva il 40 per cento dei voti di ottenere il 55 per cento dei seggi della Camera, venne ritenuto eccessivo). Per questo FdI ha ipotizzato una sorta di premio modulare: chi arriva al 40 per cento ottiene il 52 per cento, chi arriva al 45 ottiene il 55 per cento. Ma non è detto che questo basterà a superare le obiezioni della Corte.
Inoltre, è difficilmente ipotizzabile un’estensione di un simile premio di maggioranza, su scala nazionale, al Senato. Perché il Senato, secondo la Costituzione, «è eletto a base regionale» (l’Italicum si applicava solo alla Camera, infatti). Per superare questo ostacolo, si sta discutendo di una procedura alternativa, piuttosto contorta, con un premio di maggioranza attribuito sulla base del voto nelle singole regioni ma attraverso un listino nazionale di candidati.
Altri problemi riguardano infine la composizione delle liste. La coalizione di destra non vuole rinunciare all’idea dei listini bloccati, che consentono dunque ai leader di partito di scegliere chi debba essere eletto e non direttamente agli elettori: ma, sempre per non contraddire le indicazioni della Corte costituzionale, i listini devono essere corti, così che l’elettore possa comunque conoscere la persona che contribuisce a eleggere col proprio voto. Ma è anche questo un motivo di conflitto: perché nei pochi preliminari scambi di opinione avvenuti, gli esponenti delle opposizioni hanno fatto sapere che una delle condizioni per poter condividere un percorso di riforma congiunto è di reintrodurre le preferenze dirette, quelle in cui bisogna scrivere il nome del candidato o della candidata scelta, come avviene per le regionali e le europee.