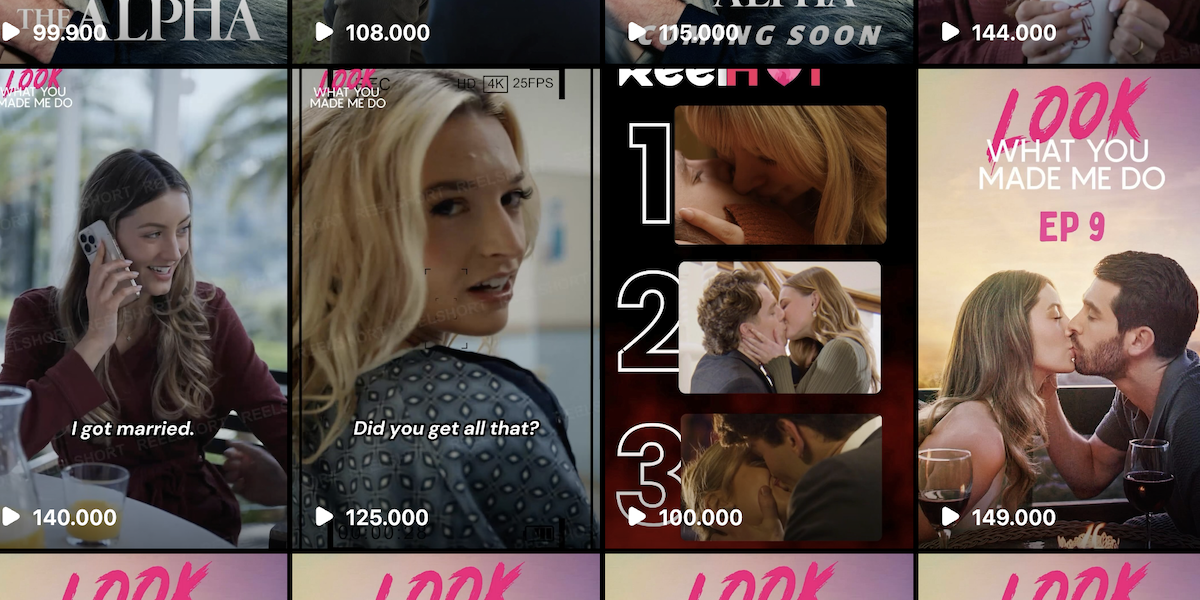I “body horror” fanno sempre il loro lavoro
Cioè scioccano, disgustano e affascinano, in particolare a Cannes, dove dopo una Palma d'oro nel 2021 sono tornati a far discutere

Domenica alla 77esima edizione del festival del cinema di Cannes è stato presentato il secondo film della regista francese Coralie Fargeat, The Substance, con Demi Moore e Margaret Qualley. È uno di quei film che si possono definire body horror, un sottogenere dell’horror che si incentra su aberrazioni varie del corpo umano, spesso ripugnanti o volutamente estreme, impiegate con intento allegorico: descritto come brutale e cruento, The Substance sta facendo parlare molto di sé, come d’altra parte The Shrouds, l’ultimo film del regista canadese David Cronenberg, che è considerato l’inventore del genere.
Anche se in generale i body horror non incontrano i gusti del grande pubblico interessano generalmente molto la critica, soprattutto per le riflessioni che sollecitano: nel 2021 la stessa Palma d’oro – il riconoscimento più prestigioso di Cannes – era stata assegnata per la prima volta proprio a un film di questo genere, Titane, della regista francese Julia Ducournau.
The Substance racconta la storia di un’attrice con una carriera in declino, interpretata da Moore, che accetta di sottoporsi a una terapia che le promette di ottenere «una versione più giovane, più bella, più perfetta di sé»: dalla sua schiena, chiusa con un’enorme cicatrice, esce così questo suo nuovo doppio, il personaggio di Qualley, con cui si trova a coesistere. La tecnologia e la non accettazione del decadimento dell’esistenza sono centrali anche in The Shrouds, presentato a sua volta a Cannes, dove il protagonista (Vincent Cassel) inventa un sistema che gli permette di vedere il corpo della moglie morta decomporsi a poco a poco, in una specie di sudario digitale.
Il film di Cronenberg è ispirato almeno in parte alla vita del regista, che ha 81 anni, è vedovo dal 2017 e con film come Videodrome (1983), La mosca (1986) e Il pasto nudo (1991) ha esplorato i temi centrali del body horror, facendone una sua cifra personale.
Il ricercatore della Manchester Metropolitan University Xavier Aldana Reyes lo definisce un genere che si basa «sull’innesto dell’orrido nel corpo umano attraverso un cambiamento, o una serie di cambiamenti, che trasformano il corpo percepito come ‘normale’ in una sua versione negativamente eccezionale o dolorosa». Film di questo tipo fanno largo uso di mutazioni, mutilazioni e metamorfosi, spesso causate per la stessa volontà dei protagonisti, e includono deformità, contaminazioni o ibridazioni tra corpo umano e macchine; più ampiamente mostrano un insieme di violenza dei corpi o sui corpi fatta anche di necrofilia, cannibalismo, pedofilia o abusi e che risulta scioccante, repellente, eccessiva, crudele.
– Leggi anche: Perché a Cannes si fischia e si fanno così tante standing ovation?
I body horror insomma si spingono oltre i limiti di ciò che è generalmente considerato accettabile. La loro violenza però non è fine a se stessa, come avviene talvolta negli horror, bensì è agita come metafora per esplorare aspetti nascosti della psicologia umana e affrontare, rielaborare e criticare temi considerati controversi: il terrore per l’invecchiamento, la sessualità, il senso di onnipotenza dell’essere umano, l’ipocrisia della società e via così.
I temi della sofferenza estrema e del terrore per le violenze sul corpo umano sono noti già da secoli sia nell’arte che nella letteratura, dalla Punizione di Marsia di Tiziano ai Tre studi di una crocifissione di Francis Bacon, da Frankenstein di Mary Shelley alla Metamorfosi di Franz Kafka. Questo genere di opere risulta grottesco e disturbante, per quanto a volte affascinante, e secondo storici del cinema come Linda Williams mostra sia le capacità che i limiti delle trasformazioni degli esseri umani, ricordando la loro fragilità.
Come ha notato Variety, per esempio, con un sacco di sangue, denti strappati e «alcune delle protesi più grottesche viste di recente», The Substance è «pregno di metafore sulle donne di Hollywood, sulla crudeltà dell’invecchiamento e sulle conseguenze dell’odio per il sé», «un body horror femminista e visionario che porta all’estremo la questione del miglioramento estetico». Per l’Hollywood Reporter mescola fantascienza, body horror e satira, mostrando come oggi le donne siano intrappolate da logiche sessiste e discriminazione basata sull’età.
The Shrouds, che comunque ha un impatto meno forte dei tipici film di Cronenberg, si può condensare nella frase che dice il suo protagonista verso l’inizio, «How dark do you want to go?»: quanto si è disposti a scavare in ciò che è buio, nascosto, inquietante. È un po’ la stessa domanda che il regista fa al suo pubblico da una vita, nota sempre Variety.
Il primo ad andare vicino a ottenere la Palma d’oro a Cannes con un horror fu proprio Cronenberg, che nel 1996 ottenne il premio speciale della giuria con Crash, un adattamento di un libro dello scrittore di fantascienza J.G. Ballard in cui un uomo sopravvissuto a un incidente stradale si eccita e ricava piacere sessuale da altri incidenti. Si dice che il presidente della giuria, Francis Ford Coppola, si rifiutò di assegnare il premio principale al film, che all’epoca piacque alla giuria ma fece scandalo.
A Cannes Cronenberg presentò anche Crimes of the Future, un body horror del 2022 con Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart, che secondo il New York Times «somiglia a quello che ci si può immaginare come un futuro non troppo distante, definito da bisogni, declino, violenza, intrattenimento estremo e catastrofi ambientali, il tutto scelto in maniera abbietta da noi stessi». Ma il successo più clamoroso di un body horror a Cannes è stato appunto quello di Titane di Julia Ducournau, vincitore nel 2021 della Palma d’oro.
La protagonista del film è Alexia, una giovane donna che tra le altre cose si rompe il naso per fingersi un ragazzino scomparso da dieci anni e resta incinta di un’automobile dopo averci fatto sesso. Mark Kermode del Guardian lo definì «un turbinio viscerale di sesso con le auto, mutazioni tra carne e metallo, e amore»; parlando sempre del film il presidente della giuria del festival, Spike Lee, disse: «Mi ha fatto uscire di me, ci sono genio e pazzia, due cose che spesso corrispondono».
Come molti body horror, Titane non è un film che ha convinto tutti, ma ha come obiettivi principali quelli di scioccare, sorprendere e far riflettere, cose che secondo l’Hollywood Reporter «molto cinema contemporaneo sembra non essere più in grado di fare».
Tra gli altri film del genere che si sono fatti notare più di recente ci sono Jumbo (2020) della regista belga Zoé Wittock, Srpski film (Un film serbo, 2010) di Srđan Spasojević e Raw – Una cruda verità (2016), sempre di Ducournau. Il primo parla di una ragazza insolitamente attratta da una giostra, mentre il secondo è stato vietato subito dopo l’uscita in decine di paesi per le scene esplicite di necrofilia, stupro e tortura. Raw invece è il film di debutto della regista di Titane e racconta la storia di una giovane vegetariana che diventa cannibale, largamente interpretata come un’esplorazione della sua sessualità: fece molto parlare perché, tra una serie di buone recensioni, in certi casi aveva fatto vomitare e svenire qualche suo spettatore in sala.
– Leggi anche: Il festival di Cannes di Pulp Fiction