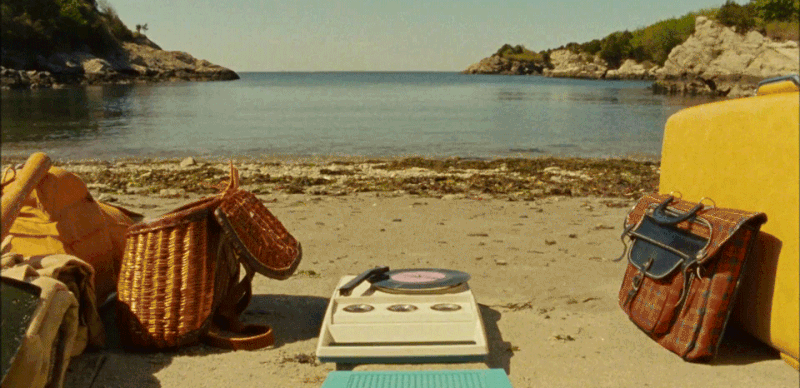Il governo Meloni ha un problema con la “Via della Seta”
Deve decidere entro fine anno se uscire dal grande progetto politico e infrastrutturale cinese, ma teme ritorsioni economiche

Entro la fine del 2023 il governo di Giorgia Meloni deve decidere se continuare ad aderire o meno all’iniziativa “Belt and Road”, l’ampio progetto promosso dalla Cina che prevede grandi investimenti su infrastrutture in tutto il mondo (spesso chiamato anche “Nuova Via della Seta”).
Nel marzo del 2019, durante il primo governo di Giuseppe Conte, l’Italia era diventata l’unico paese del G7 e dell’Europa occidentale (oltre al Portogallo) a firmare con rappresentanti del governo cinese un “memorandum d’intesa” per l’ingresso del paese nella “Belt and Road”. La firma dell’accordo aveva provocato enormi polemiche, perché implicava l’adesione dell’Italia al più grande progetto di espansione dell’influenza della Cina nel mondo. La questione si sta riproponendo in questi mesi perché l’accordo ha una durata di cinque anni e si rinnova automaticamente: per uscirne, il governo Meloni deve inviare una disdetta scritta con tre mesi di anticipo, e questo significa che ha tempo fino alla fine del 2023.
Ancora non ci sono decisioni ufficiali, e non è sicuro se alla fine il governo uscirà dall’accordo, ma l’indecisione di Meloni emersa negli ultimi mesi mostra come sia cambiata nel tempo la posizione del governo italiano nei confronti della Cina.
La “Belt and Road Initiative” è un grande progetto infrastrutturale annunciato dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013, che prevede l’investimento di centinaia di miliardi di dollari in vari paesi con l’obiettivo esplicito di rafforzare le infrastrutture commerciali nel mondo, e con quello implicito di espandere l’influenza della Cina su numerosi paesi tra Africa, Asia ed Europa. Quasi tutti i governi occidentali, a partire da quello degli Stati Uniti, si sono opposti al progetto considerandolo un tentativo da parte della Cina di aumentare la propria influenza economica e politica nel mondo.
Nel 2019 il governo italiano, al tempo sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, tentò di trasformare l’Italia in una specie di “ponte” tra Occidente e Cina mettendosi in una posizione privilegiata per approfittare dell’enorme potenziale del mercato cinese. Nella pratica, però, questa politica si tradusse in una serie di atti di ossequio nei confronti della Cina che preoccuparono molto gli Stati Uniti e gli altri paesi dell’Unione Europea. La firma del memorandum sulla “Belt and Road” fu il più importante e al tempo stesso il più preoccupante di questi atti.
Il documento non aveva un valore legale, né costituiva un accordo economico che impegnava le due parti in qualche modo: aveva soprattutto un valore politico e simbolico, che segnalava per la prima volta l’adesione di un paese del G7 al grande progetto cinese. È ormai piuttosto chiaro, inoltre, che al contrario di quanto sostenuto dai rappresentanti del governo in quegli anni l’ingresso dell’Italia nella “Belt and Road” non ha portato quasi nessun vantaggio economico all’Italia. Negli ultimi quattro anni le esportazioni italiane in Cina sono cresciute di poco, da 13 miliardi di euro a 16,4, mentre sono aumentate considerevolmente le esportazioni cinesi in Italia: da 31,7 miliardi di euro a 57,5.
L’atteggiamento estremamente conciliante del governo italiano nei confronti della Cina cambiò gradualmente con il secondo governo Conte (quello sostenuto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) e poi in maniera più energica con il governo di Mario Draghi, che rese evidente con diverse decisioni sia diplomatiche sia di politica economica che l’Italia era tornata ad allinearsi alle posizioni del resto dell’Europa occidentale: «convintamente atlantista ed europeista», come disse lui stesso nel discorso d’insediamento alle Camere.
L’insediamento al governo di Giorgia Meloni, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha portato numerosi elementi di continuità con Draghi, ma anche alcune contraddizioni.
L’anno scorso in campagna elettorale Meloni aveva assunto alcune posizioni estremamente critiche nei confronti della Cina: aveva denunciato l’autoritarismo del governo cinese e soprattutto aveva fatto atti di solidarietà nei confronti di Taiwan, l’isola di fatto indipendente che la Cina rivendica come propria. Lo scorso luglio Meloni si era fatta fotografare con Andrea Sing-Ying Lee, l’allora rappresentante diplomatico di Taiwan in Italia. Già di per sé questo sarebbe un fatto notevole, perché l’Italia non riconosce formalmente il governo di Taiwan, e perché ogni rapporto con i rappresentanti diplomatici di Taiwan è sempre duramente condannato dalla Cina che sostiene che Taiwan sia territorio cinese e non abbia diritto ad avere una propria rappresentanza diplomatica.
Meloni non soltanto aveva incontrato Sing-Ying Lee, ma lo aveva definito pubblicamente “ambasciatore”, un atto che era un’evidente provocazione nei confronti della Cina: proprio perché Taiwan non è riconosciuta dalla maggior parte dei paesi del mondo, formalmente le sue ambasciate sono definite “Uffici di rappresentanza”, e i capi di questi uffici non possono essere chiamati ambasciatori, anche se di fatto ne svolgono appieno il ruolo.
Atti del genere si erano uniti a tutta una serie di dichiarazioni piuttosto bellicose di Meloni nei confronti della Cina, che avevano fatto pensare che, una volta al governo, la leader di Fratelli d’Italia avrebbe mantenuto il paese su posizioni molto critiche.
Le cose sono andate così soltanto in parte. Come ha scritto sul Foglio Giulia Pompili, giornalista esperta di Asia che ha seguito l’evoluzione del rapporto tra il governo italiano e la Cina, «Meloni è arrivata a Palazzo Chigi con le idee molto chiare su Pechino, e una campagna elettorale con segnali evidenti pro Taiwan e pro Tibet. Poi, dopo il giuramento, qualcosa è cambiato».
Meloni è diventata più cauta. Al G20 dello scorso novembre a Bali ha visto Xi Jinping (come in realtà praticamente tutti i leader presenti) e ha accettato un suo invito a fare una visita di stato in Cina, che però non è ancora stata organizzata. Soprattutto, dopo le dichiarazioni aggressive in campagna elettorale di fatto ha smesso di citare in pubblico i rapporti con la Cina.
Il governo Meloni si è comunque mosso con una certa continuità rispetto alle politiche di contenimento dell’influenza cinese messe in atto dal governo Draghi. Un mese fa Bloomberg ha rivelato che il governo starebbe pensando di ridurre l’influenza dell’azienda di stato cinese Sinochem nell’azionariato di Pirelli, la storica azienda italiana che produce pneumatici e altri componenti. Sinochem è il più grande azionista di Pirelli, e secondo Bloomberg il governo vorrebbe usare il cosiddetto “Golden Power” (un meccanismo che dà al governo il potere di intervenire su acquisizioni in settori strategici) per limitare per esempio il potere di voto dei rappresentanti di Sinochem nel consiglio di amministrazione di Pirelli.
La decisione da prendere sulla riconferma o meno dell’iniziativa “Belt and Road” mostra però come il governo sia molto indeciso, e tutto sommato diviso, su come gestire i rapporti con la Cina. Negli ultimi mesi sono uscite sui giornali numerose indiscrezioni che parlavano del fatto che il governo Meloni sarebbe intenzionato a uscire dalla “Belt and Road”: l’ultima è di mercoledì sul Corriere della Sera, e dà la decisione come già presa e comunicata agli alleati.
Almeno per ora, il governo non ha fatto nessun annuncio ufficiale, e l’unico esponente della maggioranza a parlare della questione è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, di Forza Italia, che ha detto che il governo sta ancora valutando cosa fare. Tajani ha posizioni storicamente molto critiche nei confronti della “Belt and Road Initiative”, così come buona parte degli esponenti di Forza Italia. Gli altri due membri della coalizione di governo, Fratelli d’Italia e la Lega, al momento sembrano molto più cauti.
Una delle ragioni per cui uscire dalla “Belt and Road” sarebbe problematico per l’Italia sono le possibili ripercussioni diplomatiche ed economiche.
Benché il memorandum firmato dal governo Conte sia soprattutto simbolico, è plausibile che la Cina percepirebbe la decisione italiana di non rinnovare l’accordo come una provocazione. Potrebbe mettere in atto ritorsioni economiche, anche se è impossibile dire di che tipo, o comunque raffreddare i rapporti. Sempre Giulia Pompili ha scritto: «Come dimostra il dilemma Meloni con la Via della Seta, per un esecutivo in carica è difficile affrontare la coercizione economica di Pechino da solo, perché gli effetti delle ritorsioni arrivano direttamente sui cittadini, cioè sugli elettori, e su quelle aziende che fanno la differenza, anche elettorale».
D’altro canto, rimanere nella “Belt and Road” per l’Italia non avrebbe sul breve periodo grosse conseguenze pratiche, ma sarebbe un segnale piuttosto scoraggiante del fatto che agli occhi degli alleati occidentali l’Italia è ancora «l’anello debole della catena» nello scontro di potere con la Cina, come scrisse Politico nel 2020. Per Giorgia Meloni, che in campagna elettorale aveva assunto posizioni estremamente critiche nei confronti della Cina, sarebbe anche un segnale di debolezza politica: significherebbe che non è riuscita a risolvere quello che lei stessa in più di un’occasione aveva definito un grave errore strategico.