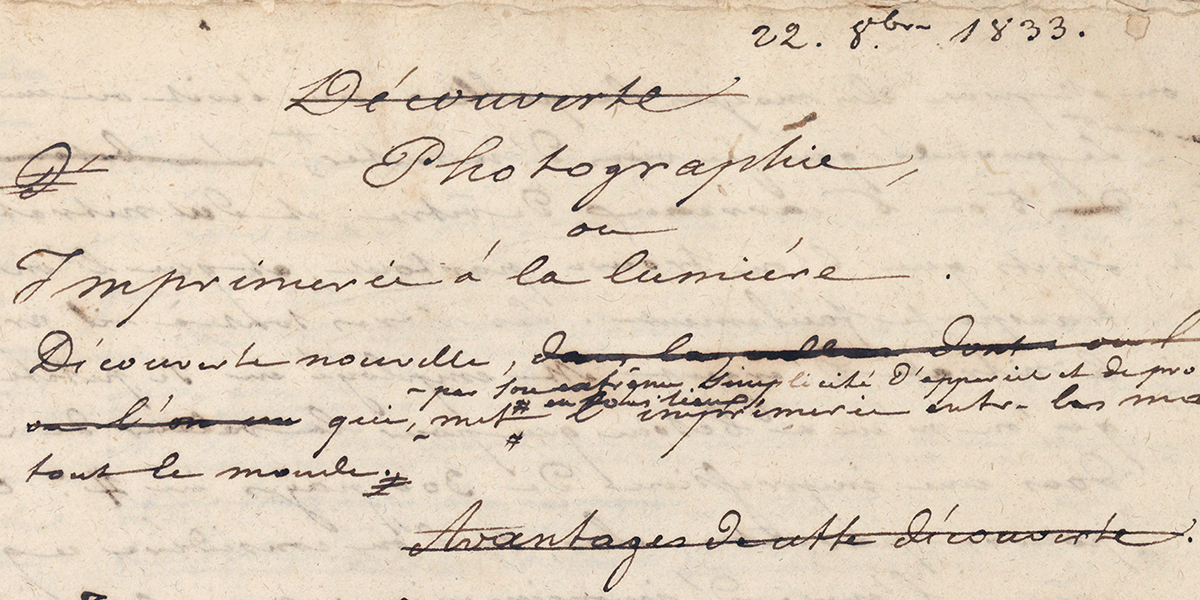Il mondo di Siccità
«Il dominio della paura e dello smarrimento che si è imposto all'improvviso sulle nostre vite non può essere raccontato senza una presa di distanza dalle confortevoli situazioni narrative della commedia, che, per funzionare davvero, ha sempre bisogno di stereotipi, di sapienti variazioni su temi familiari, di un ambiente i cui rapporti di forza siano abbastanza codificati da essere oggetto di satira».

Trovandomi fra coloro che pensano che la verità sia nei dettagli, non me ne è sfuggito uno che ha illuminato il senso più autentico di Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì, nelle sale in questi giorni. O, almeno, quello che mi è parso tale, nella speranza di arrivare a restituirne una lettura abbastanza forte da spiegarci perché proprio il regista al quale si riconosce di aver ereditato e attualizzato il meglio della grande commedia all’italiana, ci abbia portato a spasso, con tanta divertita disperazione, per una Roma futuribile assetata e atroce, popolata da blatte e narcolettici da tripanosomiasi.
E la luce per me è arrivata nel momento in cui, sul display del tablet che tiene al laccio della disintermediazione il povero driver Loris (un gigantesco Valerio Mastandrea), compare il nome dell’utente che ha prenotato la corsa: Bong Joon-Ho.
Credo che sarebbe riduttivo vedere in questo particolare soltanto l’omaggio di un regista a un collega che ammira, o una strizzatina d’occhio a un ristretto pubblico di cinefili che ha riconosciuto nel personaggio di Loris un’aria di famiglia con Gang-du, il padre picchiatello di The Host (2006), anche lui un narcolettico alle prese con la follia di una città attraversata da una epidemia e da un fiume, per così dire, problematico.
Piuttosto, il riferimento a Bong Joon-Ho, è un’utile chiave di lettura. È il modo in cui Virzì ci sta dicendo all’orecchio che, dopo il letargo dei lockdown, il mondo non è più lo stesso di prima. Di più: se intendiamo per “mondo” l’ambiente che ci avvolge e in cui il nostro vivere di relazioni, di commerci e affetti trova un senso, il “mondo” non c’è più. Se è così (ed è così, mentre cerchiamo di capire se ci siamo beccati il covid per la terza volta o se ci arriva un’atomica sulla testa), il dominio della paura e dello smarrimento che si è imposto all’improvviso sulle nostre vite non può essere raccontato senza una presa di distanza dalle confortevoli situazioni narrative della commedia, che, per funzionare davvero, ha sempre bisogno di stereotipi, di sapienti variazioni su temi familiari, di un ambiente i cui rapporti di forza siano abbastanza codificati da essere oggetto di satira. Paradossalmente, allora, proprio la distanza di questa Roma futuribile sembra essere la condizione necessaria e indispensabile per non tradire la vocazione realista che ha reso grande il cinema italiano del dopoguerra, anche quello che voleva farci ridere di noi stessi.
Siccità si svolge così in una parentesi che si apre e si chiude fra la fine del mondo e l’inizio di un altro, ancora ignoto e indecifrabile.
Del resto, e Virzì lo sa, non è la prima volta che il mondo finisce. Se, come pare, siamo in un punto di svolta della Storia la cui oscurità è paragonabile a quella che calò sull’Europa fra la caduta dell’Impero Romano e l’avvento del cristianesimo, ecco che sul greto rinsecchito del Tevere vengono rinvenuti i resti di un’enorme statua di età imperiale, e stanno lì, come un enorme feto bronzeo in un ventre arido, a testimoniare una storia compiuta per sempre. Per lo stesso motivo, sullo stesso greto, passa una Madonna incinta a dorso di mulo.
Siccità, si è detto, è un film ambientalista. Lo credo anch’io, ma nel senso che si interroga sull’“ambiente”, inteso, alla lettera, come ciò che ci sta intorno. Un ambiente che, adesso, è diventato uno spazio sconosciuto e ostile dove ci muoviamo come Antonio (Silvio Orlando): evasi nostro malgrado di prigione. Pesciolini fuor d’acquario.
Mi sono chiesto se una scelta estetica tanto estrema fosse davvero estranea alla tradizione di quel realismo italiano di cui Virzì è sicuramente uno dei custodi più autorevoli. E mi è tornata in mente un’intervista a De Sica che avevo letto da qualche parte. A Giuliano Ferrieri, che gli chiedeva come fosse passato dalla struggente rappresentazione della lotta per la sopravvivenza nell’Italia devastata dalla guerra di Ladri di biciclette alla favola di Miracolo a Milano, De Sica rispose così:
«Prima rendevamo sullo schermo il momento che vivevamo, in quei giorni, in quell’anno: la cronaca ci nutriva e ci dava forza, subito dopo la guerra vivevamo passioni umane ben definite, ben chiare. Poi le passioni sono mutate, ci allontanavamo da una certa situazione morale e una specie di angoscia ci stringeva: la minaccia di una nuova guerra, la cattiveria»
Nella stessa intervista, poi, De Sica confessò il disagio che gli dava il pensiero che «il neorealismo diventasse formula». Infine, concluse, «abbiamo fatto questo tentativo, di applicare il neorealismo a tutte le forme dello spettacolo, e così anche alla favola».
Ecco, Siccità di certo non è una favola. E la pioggia che cade in fondo al film non basterebbe, nel cercare una speranza da lieto fine, per ribattezzarlo Miracolo a Roma. Credo però che Virzì, alle prese con questo tempo indecifrabile e pericoloso, abbia fatto lo stesso tentativo di De Sica. E credo anche che abbia avuto il coraggio di guardare fino in Corea per fare un film italiano che ci restituisce un’immagine tanto cruda e vera quanto compassionevole di quello che siamo diventati.