I vaccini proteggono dalla long-COVID?
Se lo stanno chiedendo molti gruppi di ricerca, ma trovare risposte convincenti non è semplice
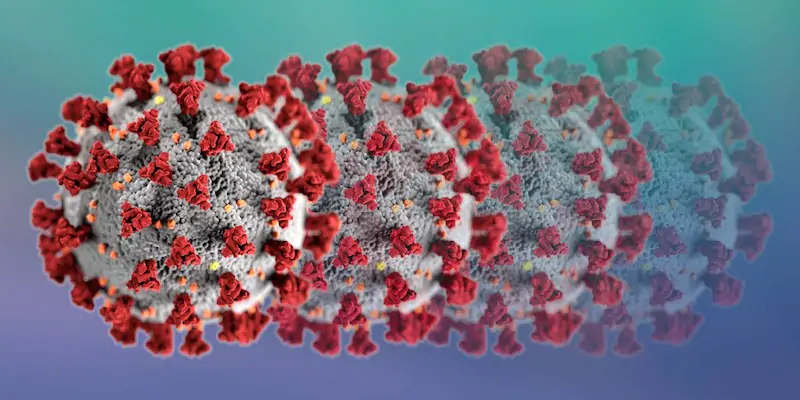
I vaccini contro il coronavirus sono impiegati da ormai un anno e hanno contribuito a salvare milioni di vite, evitando che persone a rischio e con altri problemi di salute sviluppassero forme gravi di COVID-19, che in alcuni casi possono rivelarsi letali. Le vaccinazioni hanno inoltre contribuito a ridurre la cosiddetta “long-COVID”, anche se ad oggi non è ancora completamente chiaro in quale misura e con quali prospettive, specie da quando è in circolazione la variante omicron.
Con “long-COVID” si intende il protrarsi per settimane, a volte mesi, di sintomi dopo il superamento della fase acuta della malattia. I disturbi più segnalati e ricorrenti sono dolori diffusi, spossatezza, difficoltà a concentrarsi e un senso generale di debolezza. Stimare quante persone siano interessate da questo problema non è semplice, ma dalle analisi svolte finora sembra che tra il 10 e il 30 per cento di chi ha avuto la COVID-19 fatichi a recuperare in tempi brevi le condizioni di salute che aveva in precedenza.
Quantità ed entità dei sintomi nella fase acuta della malattia sembrano essere un fattore nel determinare un’eventuale long-COVID, ma non è chiaro se sintomi più gravi portino necessariamente a svilupparla o se in alcune circostanze ciò possa avvenire anche in presenza di sintomi più lievi. Non è escluso che in rari casi un’infezione da variante omicron, che comporta in molti casi sintomi meno significativi, possa portare comunque a sviluppare la long-COVID.
In generale, comunque, i vaccini riducono il rischio di avere a lungo strascichi perché rendono meno probabile che ci si ammali di COVID-19, soprattutto in forma grave. I vaccini non impediscono però completamente l’infezione da coronavirus, in modo particolare nel caso della variante omicron (con la dose di richiamo si ottiene una migliore protezione), e non è quindi escluso che ci si possa ammalare.
Attualmente non ci sono molti dati per stabilire quale sia l’incidenza della long-COVID tra le persone vaccinate e più in generale tra chi subisce un’infezione da coronavirus. Medici e ricercatori ritengono che numerosi casi passino del tutto inosservati e non siano mai notificati alle autorità sanitarie. Ciò dipende dal fatto che questa condizione può manifestarsi dopo una malattia lieve o quasi del tutto asintomatica, rendendo più difficile la sua identificazione: le persone interessate hanno stanchezza e difficoltà a concentrarsi, ma non sempre attribuiscono le cause all’infezione subita in precedenza.
Uno studio condotto in Israele prima della variante omicron su circa 1.500 operatori sanitari vaccinati aveva rilevato 39 casi in cui il vaccino non aveva impedito l’infezione. In sette casi, la malattia aveva portato a sintomi prolungati, riscontrabili a 6 settimane dal loro manifestarsi. La quantità di casi analizzata è però ridotta e difficilmente rappresentativa in termini statistici.
Una ricerca più ampia aveva invece riguardato oltre 1,2 milioni di individui, che avevano ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus e che avevano segnalato i propri sintomi su un’applicazione sviluppata dal King’s College di Londra. L’analisi dei dati aveva permesso di verificare che due dosi di vaccino riducono di circa la metà il rischio di long-COVID nelle quattro settimane dopo l’infezione. L’analisi, svolta prima dell’avvento della variante omicron, aveva però ricevuto qualche critica perché il campione analizzato era sbilanciato, con più donne e meno uomini.
Le ricerche negli ultimi mesi hanno inoltre interessato i dati sanitari di migliaia di individui, che avevano subìto l’infezione nonostante fossero vaccinati. Una di queste analisi, ancora in attesa di revisione e quindi da valutare con qualche cautela, ha messo a confronto le cartelle mediche di 10mila pazienti vaccinati con individui con infezione da coronavirus che non si erano sottoposti alla vaccinazione. Lo studio ha rilevato alcune condizioni tipiche della long-COVID in entrambi i gruppi, anche se con numerose cautele nell’arrivare a qualche conclusione.
I vaccini potrebbero però contribuire a ridurre gli effetti stessi della long-COVID. Lo scorso ottobre nel Regno Unito tra le persone vaccinate con almeno una dose e affette da questa condizione di salute è stata rilevata una riduzione del 13 per cento delle segnalazioni dei sintomi. L’analisi è però basata su due mesi di segnalazioni, quindi i dati potrebbero variare man mano che si attenuano gli effetti del vaccino o i sintomi stessi della long-COVID.
Altri gruppi di ricerca stanno invece cercando di capire quale sia la causa di una condizione che interessa così tanti convalescenti. Tra le ipotesi più condivise c’è quella secondo cui al termine di un’infezione acuta rimangano alcune riserve del coronavirus in vari tessuti del nostro organismo, dove il sistema immunitario fatica a identificarlo. Altre ipotesi sono invece legate alla forte reazione immunitaria indotta dal coronavirus alla prima infezione, che in alcuni casi porta a causare danni all’organismo che si risolvono solo dopo molto tempo, maggiore rispetto alla durata dell’infezione vera e propria.
La vaccinazione potrebbe contribuire a ridurre queste eventualità, perché induce un’alta produzione di anticorpi (che si ridurranno poi col tempo) e innesca i meccanismi attraverso i quali il sistema immunitario impara a riconoscere autonomamente il coronavirus e ad affrontarlo nel caso di future infezioni. Ciò fa sì che si abbiano migliori difese per fermare il virus prima che produca molte copie di sé e in varie parti del nostro organismo, riducendo il rischio che si formino le riserve che potrebbero essere tra le cause della long-COVID.
Come per molti altri aspetti della pandemia, saranno necessari nuovi dati per avere le idee più chiare su un problema che interessa milioni di persone in tutto il mondo e non sempre semplice da diagnosticare.



