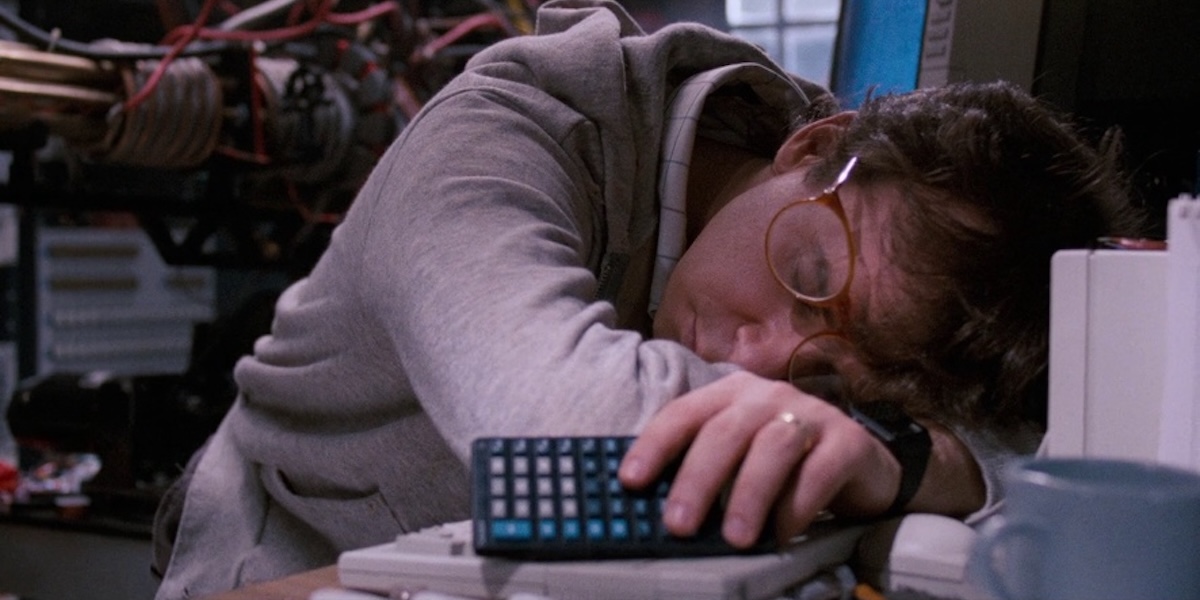Le reinfezioni da coronavirus, spiegate
Il caso di Hong Kong di un paziente che ha nuovamente contratto il coronavirus è meno preoccupante di quanto sembri, e non implica che non si diventi immuni
di Emanuele Menietti – @emenietti

All’inizio di questa settimana è stata ampiamente ripresa la notizia di una persona che a Hong Kong ha contratto nuovamente il SARS-CoV-2 – il coronavirus che causa la COVID-19 – a circa quattro mesi e mezzo dalla prima infezione. Diversi giornali hanno dedicato titoli e articoli allarmati alla possibilità che non si possa sviluppare un’immunità dal coronavirus, quindi con il rischio di ammalarsi più volte e di non poter produrre un vaccino completamente efficace per prevenire la COVID-19. In realtà a oggi i ricercatori non sanno con certezza come si comporti il nostro sistema immunitario contro il SARS-CoV-2 nel lungo periodo, anche se mantengono un certo ottimismo sapendo come vanno le cose con altri coronavirus, come quelli che causano il comune raffreddore.
Il caso di Hong Kong
Sul caso di Hong Kong mancano ancora molti dettagli: i ricercatori che hanno rilevato la reinfezione hanno fornito informazioni tramite un comunicato stampa, in attesa che il loro studio con maggiori dettagli sia pubblicato su una rivista scientifica. Il caso fa riferimento a un uomo di 33 anni che quattro mesi e mezzo fa aveva contratto il coronavirus e si era in seguito ammalato, sviluppando sintomi come febbre, tosse, mal di gola e mal di testa, al punto da rendere necessario un suo ricovero in ospedale. Di recente, la stessa persona era risultata nuovamente positiva al coronavirus, dopo un controllo in aeroporto.
Confrontando le caratteristiche genetiche della prima infezione con la seconda, i ricercatori hanno concluso di essere davanti a un caso di reinfezione, e non a una recidiva dovuta ancora alla prima infezione. Dopo avere contratto nuovamente il coronavirus, l’individuo non aveva segnalato di avvertire particolari sintomi, tanto da non essersi accorto di essere nuovamente infetto. Circostanze simili, difficili da confermare con certezza, sono state segnalate negli ultimi tempi da altri ricercatori sulla base delle loro analisi su alcuni pazienti in Europa e in altre aree del mondo. È bene ricordare che per ora i casi segnalati sono pochi e isolati, quindi devono essere presi in considerazione con qualche cautela.
Il fatto che il paziente di Hong Kong non abbia nuovamente sviluppato sintomi è ritenuto incoraggiante da medici e immunologi, perché potrebbe indicare la capacità dell’organismo di mantenere comunque un certo livello di protezione dal coronavirus, anche se non si diventa completamente immuni. Questa circostanza potrebbe sembrare controintuitiva, ma dipende da come siamo fatti, da come funziona il nostro sistema immunitario e dal fatto che con la parola “immunità” si intendono spesso cose molto diverse tra loro.
Immunità
Tendiamo a pensare che essere immuni a una malattia implichi esclusivamente la capacità del nostro organismo di impedire a un agente infettivo, come un virus o un batterio, di attecchire nelle cellule e fare danni, ma non è necessariamente così. Le ricerche condotte finora sull’attuale coronavirus, per esempio, hanno evidenziato come gli anticorpi neutralizzanti – cioè le proteine che si occupano di impedire agli agenti infettivi di attaccare le cellule – che sviluppiamo durante un’infezione da coronavirus tendano a scomparire a mesi di distanza dal momento in cui siamo stati infettati. La loro eventuale scomparsa non implica però che si perda completamente l’immunità.
Ci sono diverse altre risorse che il sistema immunitario mette a disposizione del nostro organismo per offrire protezione dalle minacce esterne. Tra le più efficaci ci sono i linfociti T, che hanno la capacità di identificare e distruggere le cellule che sono state colonizzate da un agente infettivo, come l’attuale coronavirus. Semplificando molto: gli anticorpi sono in grado di eliminare i virus nei fluidi dell’organismo, prima che entrino nelle cellule per sfruttarle per iniziare a replicarsi, se però falliscono (o non sono disponibili) allora i linfociti T possono rivelarsi utili per identificare e distruggere le cellule infette, prima che si sviluppino sintomi più gravi.
Il sistema immunitario ha poi a disposizione altre risorse ancora per affrontare un’infezione e cercare di contenerla. A volte la reazione finisce però fuori controllo ed è necessario intervenire per rallentarla e ridurne la portata, evitando che causi più danni che benefici: è il lavoro molto delicato che viene svolto nei reparti di terapia intensiva, nei rari casi in cui i pazienti sviluppano sintomi gravi.
Studiando le infezioni da coronavirus, diversi ricercatori hanno rilevato che circa un individuo su due (uno su quattro secondo stime più caute) possiede cellule T adatte a contrastare il SARS-CoV-2 anche se non è mai entrato in contatto con il coronavirus. Un’ipotesi è che tale capacità sia stata sviluppata in seguito a infezioni da altri coronavirus, che causano sintomi meno gravi come quelli del comune raffreddore, ma a oggi non ci sono spiegazioni soddisfacenti su questa circostanza.
Da mesi i ricercatori discutono e si confrontano su cosa possa davvero significare diventare immuni dall’attuale coronavirus e, anche se non ci sono ancora risposte definitive, iniziano a profilarsi quattro possibili scenari, come hanno spiegato diversi esperti interpellati dal sito di notizie mediche STAT.
1. Immunità sterilizzante
Sarebbe lo scenario migliore, quello in cui il nostro sistema immunitario impara a difendersi dal coronavirus nel modo più efficiente, fermandolo ancora prima che causi un’infezione. È una circostanza che si verifica con alcune malattie virali che causano una tale e duratura risposta immunitaria, dopo un singolo episodio, da rendere quasi impossibile una reinfezione. Accade per esempio con il morbillo e con alcune altre malattie che si prendono da piccoli o verso le quali si viene vaccinati.
La brutta notizia è che di solito i virus che causano infezioni a partire dalle vie aeree superiori, proprio come il SARS-CoV-2, non inducono un’immunità sterilizzante. Per questo motivo molti ricercatori ritengono improbabile che dopo un’infezione con l’attuale coronavirus si possa sviluppare una capacità, che duri nel tempo, di bloccare il virus ancora prima che possa fare danni. Il sistema immunitario di alcuni individui potrebbe riuscirci, ma sarebbero eccezioni più che la regola.
2. Immunità funzionale
Al momento per diversi ricercatori questo sembra essere lo scenario più probabile. Semplificando molto, l’immunità funzionale non impedisce una reinfezione, ma consente comunque di sconfiggerla e risolverla in fretta e senza che si abbiano particolari sintomi.
Questa circostanza implica di essere già entrati in contatto con il coronavirus (o con un vaccino apposito) e di avere quindi sviluppato capacità a livello del sistema immunitario per affrontare con successo nuove eventuali infezioni. Un individuo nuovamente contagiato non dovrebbe sviluppare sintomi o ne potrebbe sviluppare di lievi, più simili a un raffreddore che a quelli gravi della COVID-19.
Se così fosse, con l’aumentare delle persone infettate dal coronavirus (tramite contagio o con una versione depotenziata di un vaccino) l’impatto sui sistemi sanitari della COVID-19 dovrebbe diventare col tempo meno rilevante. Sintomi più lievi implicherebbero una minora richiesta di ricoveri, e naturalmente un rischio inferiore di patire conseguenze gravi a causa di una reinfezione. Nel caso del 33enne di Hong Kong le cose sembrano essere andate in questo modo e, almeno finora, gli esperti non hanno rilevato discrepanze tali rispetto ad altre malattie respiratorie virali per pensare che il nostro sistema immunitario si comporti diversamente con il SARS-CoV-2.
I virologi sono comunque ancora cauti perché questo nuovo virus è noto da poco più di 8 mesi. Sarà necessario continuare a seguire i pazienti che avevano subìto un’infezione mesi fa, per verificare come si regoli il nostro sistema immunitario con il passare del tempo, soprattutto nel mantenimento delle capacità per contenere velocemente l’infezione, pur non riuscendo a impedirla.
3. Immunità in diminuzione
È una condizione simile all’immunità funzionale, ma prevede che nel corso del tempo la capacità di risolvere una seconda infezione diminuisca, esponendo quindi a qualche rischio in più, anche se non sono noti casi in cui ci si ammali come ci si era ammalati la prima volta che si era entrati in contatto con il virus. Questo andamento è stato verificato negli anni sui coronavirus noti per causare il comune raffreddore (che può essere anche causato da virus di altro tipo). Eventuali reinfezioni potrebbero avvenire in tempi più stretti e alcuni ricercatori sono comunque ancora cauti nel fare previsioni sulla gravità dei sintomi, che potrebbe comunque variare sensibilmente a seconda dei soggetti.
4. Perdita dell’immunità
È lo scenario più pessimistico e ipotizza che il nostro sistema immunitario perda, in un certo periodo di tempo, le proprie risorse contro il coronavirus. In questo caso, una reinfezione avrebbe effetti paragonabili alla prima infezione, con tutti i rischi che comporta per la salute. A oggi non ci sono però elementi per sostenere che la perdita dell’immunità possa essere la norma: anche per questo motivo molti virologi ritengono che sia uno scenario improbabile.
E il vaccino?
Se immunità funzionale e immunità in diminuzione saranno gli scenari effettivi, come suggeriscono il caso di Hong Kong e qualche altra segnalazione dall’Europa, non solo le reinfezioni da coronavirus saranno meno preoccupanti, ma anche il coronavirus tenderà a essere meno in circolazione. Gli individui con una nuova infezione svilupperanno sintomi lievi o saranno asintomatici, avranno una carica virale più bassa e dovrebbero quindi essere meno contagiosi. Nella migliore delle ipotesi, la COVID-19 potrebbe diventare una malattia meno frequente e meno rischiosa.
Secondo alcuni esperti, un vaccino potrebbe contribuire ad accelerare questo processo: non impedirebbe un’infezione da coronavirus, ma si rivelerebbe utile per ridurre il rischio che si sviluppino sintomi gravi e semmai paragonabili a quelli di una seconda infezione. I vaccini sperimentali finora testati su alcuni primati non umani hanno dato esiti di questo tipo, facendo ipotizzare che potrebbero portare allo stesso grado di copertura anche tra gli esseri umani.
Previsioni
Anche se si iniziano ad avere più dati sulla COVID-19, ricercatori e medici invitano a essere ancora molto cauti nel fare previsioni. Non è per esempio chiaro se negli individui che vengono contagiati una prima volta, e che non sviluppano particolari sintomi, si generi una risposta immunitaria sufficiente per generare una memoria dell’infezione, in modo da contrastare più facilmente un eventuale nuovo contagio. Altri ricordano che è ancora presto per sostenere con certezza che i sintomi nel caso di una reinfezione siano sempre lievi, o comunque inferiori rispetto a quelli eventualmente sviluppati dopo il primo contagio.
Ogni individuo è un mondo a sé soprattutto quando si parla di medicina e di malattie infettive. Immaginare scenari troppo netti e in modo categorico sarebbe un errore, considerato che ogni individuo reagisce diversamente. La realtà è molto più sfumata e anche per questo è difficile fare previsioni accurate, soprattutto all’inizio di un fenomeno così esteso e che interessa ormai buona parte del pianeta.