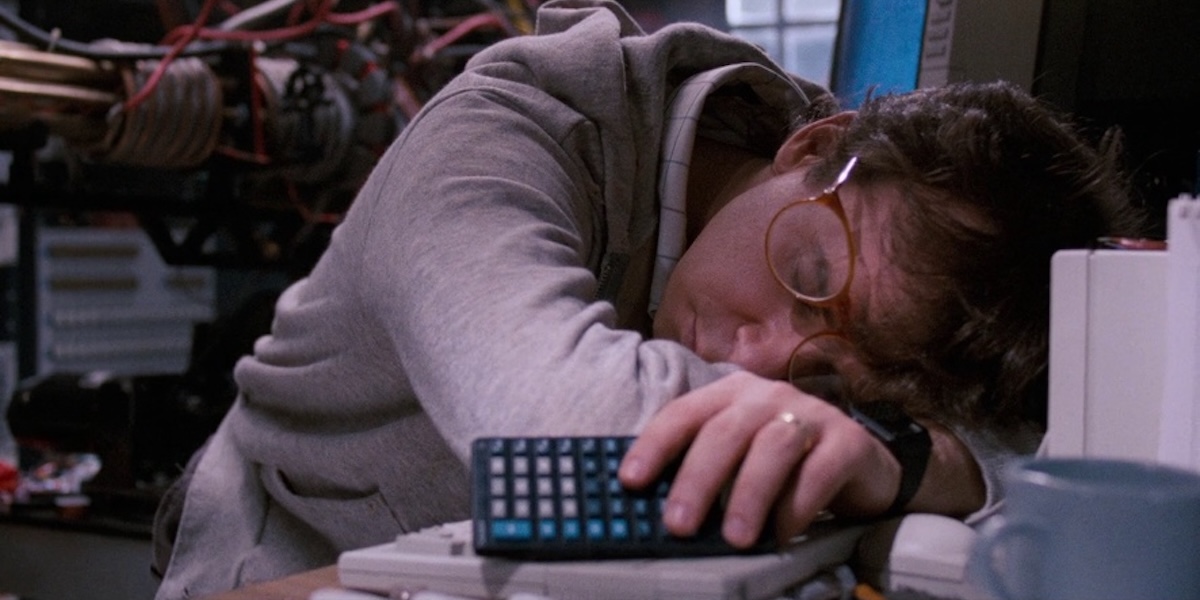Il coronavirus in ospedale
Il presidente del Consiglio ha criticato la gestione dei primi contagiati al Nord Italia, ma nei prossimi giorni parleremo soprattutto della capienza dei reparti di terapia intensiva

Nella mattina di martedì 25 febbraio l’assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha definito un “attacco ignobile” le affermazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che lunedì aveva sollevato dubbi sulla gestione dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) nella regione e in particolare nell’ospedale di Codogno (Lodi), dove è stato identificato il primo paziente infetto venerdì 21 febbraio. In seguito Conte ha invitato le istituzioni a collaborare, annunciando un confronto con tutte le regioni italiane, per uniformare alcuni degli approccio all’emergenza sanitaria.
Il coronavirus e il sistema sanitario
In mancanza del “paziente zero” – quello che ha portato il contagio dalla Cina (dove è iniziata l’epidemia da coronavirus) – è per ora difficile stabilire con certezza se qualcosa non abbia funzionato in Lombardia per prevenire la diffusione del virus. Il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) è organizzato infatti in modo da delegare alle regioni buona parte delle competenze sulla gestione della sanità. Gli ampi margini di autonomia sono un’opportunità per organizzare meglio sul territorio gli interventi, ma in casi straordinari come l’attuale possono portare a una gestione poco coordinata, soprattutto in assenza di protocolli chiari da fare applicare alle singole agenzie sanitarie e aziende ospedaliere (che a loro volta hanno molte autonomie).
Dall’organizzazione dei sistemi di diagnosi, di ricovero e isolamento degli infetti e dal trattamento dei pazienti in gravi condizioni dipenderà la capacità del sistema sanitario di reggere forti stress, man mano che si diffonderà il contagio. Non sarà solamente un problema italiano: le istituzioni sanitarie negli altri paesi dovranno affrontare una situazione simile e l’esperienza cinese, con la gestione di migliaia di pazienti infetti, sta richiedendo sforzi senza precedenti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ne è consapevole e nelle ultime settimane ha mostrato grandi attenzioni, e qualche preoccupazione, per come si stanno organizzando i paesi con il maggior numero di contagi, come Italia, Iran, Corea del Sud e Giappone.
Identificazione in ritardo
Stando ai rapporti prodotti finora, l’81 per cento degli infetti sviluppa sintomi lievi o moderati dovuti alla COVID-19, la malattia causata dal coronavirus. Molti si ammalano e guariscono senza nemmeno scoprire di avere la malattia, magari pensando a un raffreddore più forte del solito o a un’influenza: restano a casa qualche giorno, poi riprendono la loro vita normalmente e non ricevono una diagnosi.
C’è invece un 14 per cento circa di persone che manifesta sintomi più gravi e che ha quindi bisogno di assistenza medica o necessità di ricovero in ospedale. Il coronavirus interessa le vie aeree inferiori e nei casi più gravi comporta una polmonite, come fanno diverse altre malattie infettive. Per i medici, capire da subito se ci si trova davanti a una persona con COVID-19 può quindi essere complicato, considerato che in Italia ci sono ogni anno decine di migliaia di casi di polmonite e per le cause più disparate.
È stata probabilmente questa difficoltà a rendere tardive le prime diagnosi di coronavirus negli ospedali nel nord Italia, dove fino a cinque giorni fa si pensava che non ci fossero altri casi oltre a quelli trattati presso l’Istituto Spallanzani di Roma.
Dai racconti del personale medico e dalle ricostruzioni circolate finora, emergono dinamiche simili sulle cause delle prime diagnosi mancate: una persona è arrivata in pronto soccorso con un’infezione grave alle vie aeree ed è rimasta per alcune ore a contatto con il personale sanitario, che non aveva elementi per sospettare una COVID-19, ed era quindi priva delle protezioni adeguate. Dopo le verifiche sul primo caso a Codogno, le altre aziende ospedaliere della Lombardia hanno avviato sistemi di controllo più accurati, scoprendo in alcuni casi di avere già pazienti in cura nelle loro strutture affetti da coronavirus.
La logistica dei pazienti
Un ospedale è una struttura complessa, con reparti e aree diagnostiche, in cui lavorano e circolano di continuo centinaia di persone, che hanno un maggior rischio di entrare in contatto con individui contagiosi. Per questo, dopo Codogno sono state diffuse istruzioni per isolare il prima possibile le persone potenzialmente infette, evitando che ne possano contagiare altre mentre si trovano in ospedale per esempio in attesa di una diagnosi.
La mancanza di protocolli e una certa accelerazione dell’emergenza dopo i primi casi hanno fatto sì che ci fosse scarsa organizzazione in alcune strutture, con conseguenze non solo per i pazienti, ma anche per il personale sanitario. Nel caso di epidemie, l’OMS raccomanda che siano adottati protocolli per ridurre il più possibile il rischio per medici e infermieri, considerato che dalla loro possibilità di lavorare dipende la salute di tutti gli altri. L’esposizione senza protezioni a pazienti che si è poi scoperto avevano il coronavirus ha fatto aumentare i rischi di contagio per il personale medico, rendendo necessario in alcuni casi il suo isolamento in attesa dei test per verificare eventuali infezioni.
Test e tamponi
Il test più pratico e rapido per verificare la presenza del coronavirus consiste in un prelievo di saliva, tramite un tampone (una specie di lungo cotton fioc) che viene strofinato sulle mucose più profonde della bocca. Nelle ore successive al primo caso, in Lombardia sono state fatte centinaia di test quasi sempre su persone che non presentavano alcun sintomo, per verificare comunque se fossero state contagiate. Stando alla Protezione Civile, le autorità sanitarie lombarde ne hanno eseguiti circa 3.300 fino al 24 febbraio, comportando un consumo significativo di tamponi, che ora scarseggiano anche per il personale medico esposto, in attesa di sapere se possa o meno tornare a lavorare.
In un collegamento televisivo questa mattina, l’assessore Gallera ha spiegato che i tamponi “scarseggiano, ma ci sono” e che è stato cambiato il modo in cui vengono eseguiti i test. La circostanza è stata confermata da Walter Ricciardi, medico e rappresentante per l’Italia all’OMS: i tamponi saranno eseguiti sulle persone che mostrano già chiaramente sintomi, come una polmonite, e che potrebbero quindi avere la COVID-19.
Affanno
Gli ospedali e i medici non sono naturalmente impegnati nella sola diagnosi delle infezioni, ma anche nel trattamento dei pazienti con sintomi più gravi. Questi devono essere ricoverati in aree isolate dal resto dei pazienti ed eventualmente nei reparti di terapia intensiva, dove è quindi necessario adottare ulteriori sistemi per garantire che non entrino in contatto con altri in condizioni di salute già precarie. In pochi giorni, le aziende ospedaliere in Lombardia e Veneto hanno quindi dovuto destinare aree specifiche per i pazienti con COVID-19, garantendo al tempo stesso le cure per tutti gli altri con altre patologie.
Su una scala molto più grande, le stesse difficoltà organizzative si erano presentate anche in Cina, dove gli ospedali avevano difficoltà a ricoverare centinaia di persone con sintomi gravi dovuti alla COVID-19. Molti pazienti gravi richiedono poi un’assistenza prolungata, di diverse settimane, in terapia intensiva prima di poter essere dimessi, e questo potrebbe mettere ulteriormente sotto stress i sistemi sanitari nei paesi in cui si registrano molti casi.
Uno studio realizzato presso l’ospedale Jin Yintan di Wuhan, per esempio, ha rilevato come in due casi su tre si sia resa necessaria l’intubazione in un campione di pazienti, in condizioni critiche. La ricerca dà un’idea di quanto potrebbe essere difficile e oneroso (in termini di tempo e risorse economiche) trattare quel 5 per cento circa dei malati da COVID-19 che sviluppa sintomi molto gravi. Solo in Cina ci sono almeno 1.800 ricoverati in queste condizioni, su un totale di circa 77mila casi confermati da coronavirus.
Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, ricorda che le polmoniti da COVID-19: “mettono a dura prova le unità di terapia intensiva degli ospedali, specialmente se non sono adeguatamente fornite di personale e strumentazioni”. Un paziente che rimane a lungo in terapia intensiva occupa un letto che non può essere utilizzato per altri, anche con malattie diverse. La ricerca cita tre pazienti all’ospedale di Wuhan ancora intubate a 28 giorni dal ricovero.
Alcune aziende produttrici delle strumentazioni che si impiegano nei reparti di terapia intensiva, come la svedese Getinge, hanno segnalato già da alcune settimane un aumento significativo degli ordini per i loro prodotti. La produzione è stata aumentata per rispondere alla domanda, che implica naturalmente nuove spese da parte degli ospedali e dei sistemi sanitari per acquistare le strumentazioni.
Diversi epidemiologi non escludono che il coronavirus sia ormai incontenibile e che ci si debba quindi preparare a una sua ampia diffusione. La maggior parte delle persone svilupperà sintomi lievi o non si accorgerà nemmeno di essersi ammalata, ma per gli individui più a rischio (con altre condizioni mediche) non ci sarà la protezione di un vaccino come avviene per altre malattie contagiose come l’influenza. Gli ospedali dovranno quindi occuparsi di un maggior numero di pazienti, e dovranno disporre delle risorse per farlo.