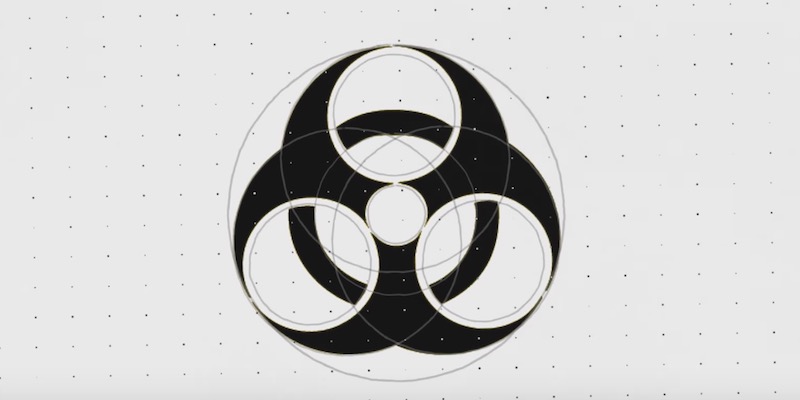Notizie dalla Francia
Storie del Louvre, di Hollande e di mille altre cose, come sa raccontarle Filippomaria Pontani
di Filippomaria Pontani

Da lunedì il museo più famoso del mondo ha un nuovo direttore. A guidare il Louvre, antica residenza reale aperta al pubblico con la Rivoluzione nel 1793, sarà il 49enne Jean-Luc Martinez, già conservatore della sezione delle antichità greche, etrusche e romane, che è stato preferito alla candidata Sylvie Ramond (direttrice del Musée de Beaux-Arts de Lyon), appoggiata dalla ministra della cultura Aurélie Filippetti, e a Laurent Le Bon, direttore del nuovo museo di arte contemporanea Pompidou – Metz.
La scelta di Martinez può suscitare diverse osservazioni sul piano metodologico: non è stato premiato il criterio femminile, in un museo che vede diverse donne in posti importanti ma non ne ricorda una al comando in tutta la sua storia; non è stato seguito il criterio della notorietà sul piano dell’industria culturale (Le Bon ha portato Murakami a Versailles, ed è stato organizzatore di Notti bianche parigine, tra cui l’ultima del 6 ottobre scorso, martoriata dal maltempo); non hanno avuto seguito le voci che volevano candidate alla direzione del museo (posto che molti ritengono non meno rilevante di un ministero) le due soccombenti del Partito Socialista francese, ovvero Ségolène Royal, ex-moglie di Hollande e antagonista di Sarkozy alle presidenziali del 2007, e Martine Aubry, sconfitta dallo stesso Hollande alle primarie socialiste del 2012. Dunque nessuna soluzione “Melandri”, nessuna imposizione di un “grande nome” dall’esterno, nessuna riconversione ad hoc di un esperto del mercato dell’arte contemporanea, bensì la valorizzazione di una risorsa interna, la promozione di un conservatore che ha fatto bene il suo mestiere e che per giunta non vanta (a differenza del suo predecessore) né natali illustri né l’appartenenza a una Grande École. Di che meditare per un Paese come il nostro che mortifica le proprie soprintendenze e affida i suoi beni culturali a un manager di MacDonald Italia, Mario Resca.
Al di là degli uomini (o meglio: in ragione degli uomini), contano le prospettive. Al termine di un ventennio di espansione galoppante, che ha portato il Louvre a raddoppiare il numero dei visitatori fino agli attuali 10 milioni (il 65% straniero, il 50% sotto i 30 anni: fino ai 26 l’entrata è gratuita), a stabilire decine di partenariati internazionali, a varare due nuove sedi (il Louvre-Lens, aperto a novembre 2012, e il Louvre-Abu Dhabi, che sarà pronto per il 2015, anzi – forse – per il 2016), e a ricavare nella sede storica una nuova, enorme sezione dedicata all’arte islamica, oggi predomina il consenso sulla necessità di sedare la proliferazione e di procedere a un consolidamento. Un po’ per sistemare i progressi compiuti (nella sezione islamica, per esempio, il percorso è a tratti un po’ confuso, e forse l’esposizione fin troppo generosa), un po’ perché la congiuntura economica è quella che è.
Con lungimiranza, la direzione del Museo si è andata sempre più svincolando dal finanziamento pubblico (che nel 2001 era il 75% delle entrate, mentre ora rappresenta appena il 48%), e ha saputo vendere il proprio marchio e le proprie competenze là dove questi potevano essere lautamente remunerati in vista non di una faticosa manutenzione ordinaria bensì di nuovi progetti di restauro e rinnovamento. Si segnala in tal senso il Louvre-Abu Dhabi, che sarà ospitato nel piccolo emirato da un fiammante edificio progettato da Jean Nouvel, e costituirà il primo museo “universale” del Medio Oriente: l’accordo trentennale, imperniato sul prestito di centinaia di opere dei musei francesi, e su un piano di acquisti di lungo periodo, ha fruttato alla casa madre parigina oltre 400 milioni di euro. Ma rimane celebre anche il prestito di molti capolavori al High Museum di Atlanta tra il 2006 e il 2009, prestito i cui proventi (5 milioni) hanno permesso di restaurare a Parigi le sale del XVII secolo. Insomma, un museo in buona salute, pieno di energia e di ambiziosi progetti per il prossimo futuro.
È questa realtà trionfale che François Hollande ha celebrato martedì scorso nella cerimonia di congedo dal direttore uscente, Henri Loyrette. Dinanzi a un pubblico scelto, che riuniva sotto la Piramide i due “gloriosi” predecessori Michel Laclotte e Pierre Rosenberg, diversi ministri, e l’organico dei lavoratori del museo al gran completo, Hollande ha tessuto le lodi della direzione Loyrette, insistendo con toni fortemente patriottici sul primato mondiale della Francia nell’ambito dell’arte e della cultura, ribadendo la continuità di scelte fra diversi presidenti in nome del superiore bene della République (Loyrette fu nominato da Chirac nel 2001; Sarkozy non è stato mai menzionato), predicando l’arte come ponte fra le culture, e lodando non solo l’attivismo dell’ormai ex-direttore, ma anzitutto la sua abilità nell’associare fondi pubblici e fondi privati al fine di rendere il Louvre un motore importante per il rilancio dell’economia culturale della Francia.
Hollande, è risaputo, non ha una vis oratoria che sappia trascinare le folle, e questo discorso di venti minuti, pur condito da qualche battuta, non ha fatto eccezione. Tra l’altro, il contrasto fra il tono deciso e quasi sbarazzino dell’aitante Loyrette nell’indirizzo di saluto che ha aperto la cerimonia e la cadenza un po’ bolsa del più tarchiato presidente al suo fianco, non andava a vantaggio di quest’ultimo. Ma la questione è forse più profonda della mera forma, o della fisicità di una kermesse improvvisata su una pedana sotto i vetri della Piramide di Pei: il caso in esame può essere preso come significativo campione di una linea politica che in questi mesi di presidenza sembra aver condotto a una sorta di impasse.
Se infatti c’è stato un carattere saliente nella gestione Loyrette, questo è stato senz’altro l’accentramento di poteri nelle mani del direttore, al fine di varare o di orientare iniziative più ispirate al guadagno economico immediato che non a principi di tutela o conservazione del bene pubblico. Si può sostenere che Didier Rykner, agitatore della rivista “La Tribune de l’Art”, grande critico di Loyrette, e grande fautore del concetto che “i musei non sono vendita” e che non devono comportarsi come multinazionali, rimanga in tal senso un attardato estremista; e si può anche obiettare che anche i contatti amichevoli con Bashar al-Assad, un certo egocentrismo, o la sovraesposizione mediatica, fossero per Loyrette dei meri strumenti per conferire un rinnovato élan al suo museo e garantirgli una posizione salda nello scacchiere internazionale. Tuttavia rimane il fatto che l’appello promosso nel 2007 da Rykner contro le iniziative mercantili del Louvre e contro il progetto di Abu Dhabi (si veda in particolare il libro Le spleen d’Apollon, 2008) ha riscosso molte firme di intellettuali d’ogni colore, evidentemente poco persuasi della bontà delle intenzioni:fra tutti, Jean Clair con il suo duro pamphlet dal titolo La crisi dei musei (Milano 2008). E rimane il fatto che con il Louvre siamo dinanzi a un caso speciale, anzitutto per l’entità e il peso degli attori coinvolti.
Che i legami tra la Francia e i Paesi del Golfo siano stretti, è fuor di dubbio: che gli Emirati Arabi Uniti abbiano acquistato dalla Francia armamenti per diversi miliardi di euro negli ultimi anni, è un fatto di cui nessuno fa mistero. Che l’arte e lo spettacolo rappresentino utili “corollari” a movimenti di tutt’altro segno, è un’opinione che molti si sentono di esprimere apertamente dopo l’emersione del cosiddetto Qatargate svelato da France Football, ovvero quel sordido accordo fra Sarkozy, Platini e l’emiro del Qatar per l’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022. Così, anche se i retroscena di queste vicende rimangono spesso oscuri, in molti osservano che la stretta cooperazione con gli Emirati sembra mettere in questione gli stessi principi basilari cui s’ispira la civilisation francese, se è vero che quei ricchi staterelli sono il paradiso delle disuguaglianze, in cui vige una discriminazione assoluta fra i pochi indigeni abbienti (unici detentori del potere politico ed economico) e la massa dei lavoratori del Sud-Est asiatico e di altri Paesi arabi più poveri, costretti a ritmi di lavoro massacranti e privati talora dei basilari diritti umani. Per non parlare di politiche speciali come l’espulsione dei cittadini sieropositivi o la discriminazione delle donne. Che il tempio dell’égalité e della fraternité finisca per trasferirsi, foss’anche solo in parte, in paesi soggetti a regimi di tal fatta, ha del paradossale, in quanto sminuisce di riflesso la portata educativa e civile che il Louvre, come e più di tutto il Patrimoine de la République, ha sempre detenuto agli occhi dei francesi. Per non dire del rischio che potrebbero correre opere allocate nei palazzi delle famiglie regnanti, in tempi di primavere non sempre sopite. Delle difficoltà e delle polemiche che hanno accompagnato e che non abbandonano il progetto del Louvre Abu Dhabi (minacciato da sempre più frequenti bagarres di soldi e di prestigio) ha parlato in modo esaustivo e competente Mercedes Auteri proprio sul Post.
Altro discorso vale per la decisione di impiantare un “secondo Louvre”, dotato di alcuni dei capolavori della casa madre (dalla Libertà che guida il popolo di Delacroix al Ritratto di Monsieur Bertin di Ingres, tutti in prestito per cinque anni) ai margini della città di Lens, nel cuore di un antico bacino minerario oggi in disarmo e in indigenza, all’ombra dei giganteschi terrils conici che punteggiano il paesaggio come tetri souvenirs di un faticoso passato. Questa scelta ha fatto segno a numerose critiche, sia politiche sia culturali: a voler tralasciare gli aspetti prettamente economici (i costi, elevati, sono stati sostenuti dalla Regione a detrimento di altri musei esistenti, e hanno drenato ben 30 milioni di euro di finanziamenti europei), che andranno valutati anche in rapporto alla frequenza prevista di visitatori (comunque assai elevata nei primi mesi dopo l’apertura), tra molti osservatori e tra non pochi specialisti serpeggia l’idea che il Louvre-Lens sia un progetto monco, arenatosi sui veti incrociati dei diversi dipartimenti, e infine ridottosi a un modesto catalogo di opere sparse più o meno rappresentative, fiaccamente suturate fra loro dal percorso virtuale suggerito nella guida gratuita formato smartphone fornita all’ingresso.
La realtà è che l’ambizione della Galerie du Temps nel museo di Lens è proprio quella enciclopedica di raccontare la storia dell’arte universale in un Bignami eccezionalmente dotato di un'”aura” di genuinità: in tal senso, qualunque scelta sarebbe stata fondamentalmente inadeguata, e anche questa naturalmente lo è, specie se si considerano la compressione dell’Alto medioevo, la virtuale assenza dell’arte bizantina, lo spazio abnorme concesso alle collezioni islamiche, la sproporzione fra le tante opere del Rinascimento franco-tedesco e le poche (anche se ottime) di quello italiano. Tuttavia, non si può non apprezzare la spregiudicatezza intellettuale dell’operazione, molto francese sia nell’envergure sia nella rapidità di realizzazione (progetto scelto nel 2005, cantiere aperto nel 2009, apertura nel 2012): né risultano inefficaci certi “tagli” prospettici suggeriti dalla Galerie, per esempio quelli che fanno dialogare il gesto della Venere di Thorvaldsen con quello della Marianna di Delacroix subito dietro, o la posa di Monsieur Bertin con quella di un sultano su una tavola ottomana, oppure ancora un ritratto marmoreo di Giustiniano con un angelo a mosaico da Torcello: non si tratta di mere suggestioni estetiche, ma di contatti stilistici che possono indurre riflessioni, per quanto estemporanee. E anche la prima mostra tenuta negli ampi spazi del Louvre-Lens, quella sulla Renaissance in cui era esposta la Sant’Anna di Raffaello, pur gravata da un’ansia di completezza forse malposta, ha offerto per esempio l’occasione unica di contemplare dispiegato su una parete tutto l’enorme arco di trionfo disegnato da Dürer per Massimiliano d’Austria nel 1517 (ben 36 fogli di incisione), o di paragonare in una vasta sala i marmi antichi e le loro riprese rinascimentali, secondo una linea non dissimile da quella della notevole mostra su Bembo aperta in questi mesi a Padova.
Insomma, il Louvre-Lens può essere senz’altro criticato, ma rappresenta un’iniziativa di per sé rispettabile, nel contesto del recupero di un territorio disastrato e dell’apertura di una nuova opzione culturale ed educativa. Altro discorso vale per le operazioni di Atlanta e Abu Dhabi, il cui primo motore è palesemente quello economico, o per i perlopiù modesti tentativi di “spettacolarizzare” il Louvre tramite l’inserimento nel museo di artisti contemporanei. Ora, non è chiaro quale sia l’orientamento del nuovo direttore Martinez: c’è chi lo ritiene un fedelissimo di Loyrette (che lo ha promosso, ancor giovane, a un ruolo di alta responsabilità) e chi si proclama convinto che egli segnerà invece un’inversione a U rispetto alla linea fin qui seguita. Il punto che volevo sollevare qui, in effetti, è più politico che non strettamente artistico. Martedì 9 il discorso di Hollande sotto la Piramide (che in questo ha seguito perfettamente il tono pacato ma poco trascinante della sua intervista televisiva del 28 marzo), ha lasciato trasparire con chiarezza tutte le difficoltà della gauche transalpina nell’elaborare una propria strategia politica nettamente distinguibile da quella degli avversari. Se Loyrette, uomo di fiducia di Chirac nutrito di una rispettabile cultura mercantilistica e dirigista, è davvero il modello da seguire per il suo successore, vuol dire che in quest’ambito Hollande non ha un paradigma culturale da contrapporre a quello dominante, non sa (o non intende) accennare o articolare nel concreto un discorso pubblico alternativo a quello della destra. Questo sospetto è purtroppo confermato dal quadro generale di questo primo anno di presidenza socialista all’Eliseo.
Perché l’impopolarità di Hollande (la più alta mai registrata nella storia della quinta repubblica) non è il frutto di sapienti imboscate politiche di un’opposizione peraltro lacerata e in disarmo, bensì discende dalla profonda delusione suscitata nei francesi da quasi tutte le sue politiche. Delle promesse-bandiera formulate in campagna elettorale, sta andando a effetto soltanto quella sul matrimonio tra omosessuali, che per quanto sacrosanta di per sé ha finito per coalizzare contro il presidente un vasto raggruppamento di forze conservatrici, largamente al di fuori della contrapposizione politica: ne fanno fede le oceaniche Manif pour tous di gennaio, di marzo e di domenica scorsa. Sul piano economico, il più tangibile per un paese in declino, che vede galoppare la disoccupazione e ha vissuto il proprio declassamento ad opera di Moody’s come un’onta, la manovra 2012 non ha mostrato alcun cenno d’inversione di rotta rispetto alla linea della destra, e soprattutto nessuna concreta intenzione di mettere in discussione i paradigmi di austerità propagandati dall’Europa (il solo ministro delle finanze Montebourg rilascia talora dichiarazioni in tal senso, ma senza séguito palese). La tassazione del 75% per i salari alti è naufragata sugli scogli della Corte suprema; la tassazione del capitale e delle plusvalenze finanziarie è annegata in un dedalo di eccezioni e franchigie; il mondo della finanza, definito nel gennaio 2012 come «il più grande avversario» del presidente in pectore, non ha subito alcun rovescio (e infatti non si lamenta); non è stata creata una banca d’investimenti semi-pubblica; il piano di assunzioni nell’insegnamento pubblico è rimasto al palo. Si è invece intervenuto ampiamente sulla flessibilità lavorativa, sulla diminuzione delle garanzie per i lavoratori, sulla facilità di licenziare e imporre trasferimenti (eufemisticamente definita sécurisation de l’emploi, e in realtà mirante all’abolizione dei contratti nazionali a vantaggio di contratti locali o ad hoc), sulla riduzione (pardon, “modernizzazione”) del pubblico impiego, sull’aumento generale dell’IVA, sul finanziamento “a pioggia” alle imprese indipendentemente da quanto abbiano investito in ricerca o in crezione d’impiego. Il tutto, si badi, con la benedizione di molti sindacati (ma non del più grande, la CGT), convinti che questo “liberalismo di sinistra” sia efficace contro la disoccupazione, e non crei invece (come sta avvenendo) lavoratori precari e malpagati, calo della domanda, e via via la spirale che a noi Italiani è nota su scala più vasta (ed è nota, con le debite proporzioni, agli Spagnoli e ai Greci).
Se c’è un luogo dove queste contraddizioni precipitano, è l’officina occupata di Aulnay-sous-Bois, che Citroën e Peugeot sono determinate a chiudere nel 2014, scontrandosi con una tenace resistenza degli operai, i quali bivaccano da settimane contro ogni prospettiva di smobilitazione, di mobilità, di reimpiego forzoso in un altro stabilimento (per di più in catena di montaggio, con mansioni usuranti improponibili per gli over-45). Attorno a Aulnay, la Pomigliano d’Oltralpe, si sta coalizzando un vasto fronte di lotte contro grandi imprese che licenziano (Sanofi, Virgin, Alcatel), e si combatte una battaglia decisiva per la distruzione del sistema degli accordi nazionali collettivi tra padronato e sindacati, in nome di flessibilità e deregulation. La simpatia che questo movimento ispira in parte della società francese non esime i manifestanti da difficili difese in tribunale (in un processo per tentate lesioni si è discettato del lancio di un uovo “in linea retta” o “a campanile”), né li dissuade da azioni eclatanti come la recente invasione del comitato centrale del Partito Socialista, il quale risulta allo stato il loro avversario piuttosto che il loro alleato.
È su questo sfondo che si agitano delusioni più piccole ma forse perfino più simboliche: una politica contro l’immigrazione (quella portata avanti dall’energico ministro Manuel Valls) che non fa certo dimenticare l’asprezza dei tempi di Sarkozy; un impegno bellico (quello in Mali) che non ha una tempistica precisa e che dopo i primi, controversi successi ha lasciato spazio a molte inquietudini circa la sua durata e soprattutto i suoi finanziamenti (tutti gli alti ranghi dell’esercito levano alti lai contro i tagli annunciati alle spese militari); una progettualità urbana, quella per il Grand Paris 2020 (tre nuove linee di metropolitana; aggiornamento e raccordo dei mezzi di trasporto pubblico; nuovi campus universitari a Aubervilliers e altrove…), che pare fortemente minacciata dalla mancanza di denaro. Tra le delusioni meno piccole si annovera poi il disegno di legge su scuola e università, così poco diverso da quello del precedente governo da riscuotere un plauso pressoché bipartisan in Parlamento (salvo qualche critica dai deputati conservatori che lo giudicano al più inutile), e da sollevare in alcuni perplessità non dissimili da quelle che noi associamo alla legge Gelmini (impressione di un sostanziale taglio delle risorse; “professionalizzazione” dell’istruzione a beneficio delle imprese del territorio; sfrondamento – o depauperamento – dell’offerta formativa; rinvio di molti provvedimenti a decreti attuativi al di là da venire; nuovo sistema di reclutamento dei docenti medi, che rischia di compromettere una delle risorse più funzionanti dell’intero sistema dell’istruzione francese).
Tra le delusioni più grandi, ovviamente, torreggia quella relativa alla questione morale. Chi abbia seguito sin dal principio l’affaire del ministro del Bilancio Cahuzac, che ha dovuto ammettere di avere un conto in Svizzera dopo reiterate e convinte proteste d’innocenza, può immaginare l’entità del danno inflitto da questa vicenda alla credibilità dell’intero sistema politico d’oltralpe (all’onestà dei politici non crede ormai più del 30% dei Francesi). Mentre i cittadini increduli, già provati dai gravi sviluppi dello scandalo Bettencourt (nel quale Sarkozy
è stato appena rinviato a giudizio per circonvenzione d’incapace), si domandano se sia più grave il fatto che il capo della lotta all’evasione sia egli stesso un evasore, o il fatto che un ministro si sia sentito libero di prendere in giro la nazione e il presidente per molti mesi, la vicenda di Cahuzac può essere letta in due chiavi. La prima attiene strettamente alle spaccature interne al Partito socialista, ormai tali da minare la stessa leadership di Hollande, e a un sistema di finanziamento della politica che mostra diverse crepe.
La seconda lettura, come suggerisce il magistrato Jean de Maillard su Le Monde del 10 aprile, è più “di sistema”, in quanto considera le frodi, le fughe nei paradisi fiscali, le manipolazioni dei mercati e simili come i veri elementi che regolano direttamente o indirettamente lo spazio pubblico (espace public) e l’attività politica che in esso si esplica, a prescindere dal fatto che molti singoli sono indubbiamente onesti. Scrive Maillard che «governi, autorità monetarie e attori finanziari agiscono oggi come complici per mantenere ad ogni costo, e a qualunque prezzo, l’illusione: i primi per la loro sopravvivenza, le seconde per dogmatismo ideologico e i terzi perché sono i veri padroni di un mondo nel quale non vogliono che cambi alcunché». È con questa sfida più ampia, non con le toppe di fortuna a una legge sul finanziamento alla politica, che dovrebbe misurarsi – e con tutta evidenza non sa misurarsi – un governo di sinistra che voglia offrire una prospettiva di vero rinnovamento, e non una mera gestione dell’esistente.
A livello politico, il malcontento stenta a trovare un canale credibile: se il Parti de gauche di Jean-Luc Mélenchon prende ormai dichiaratamente di mira il bacino elettorale del Partito socialista, e in vista della decisiva manifestazione del 5 maggio adotta contro i politici una retorica sempre più sferzante e aggressiva («purificazione», «colpo di ramazza», «fuori tutti»), d’altra parte rimane sempre alla finestra il Front National, che ha sempre beneficiato delle onde di protesta, e che molti individuano – specie dopo la clamorosa vittoria di una sua candidata nelle elezioni suppletive dell’Oise – come candidato a insperati trionfi elettorali nel breve periodo. La sensazione di un “vuoto” è forte, ed è questo che alimenta oltralpe l’interesse per il fenomeno-Grillo (si veda per esempio la prima pagina di Le Monde dedicata a Casaleggio il 14 marzo), oltre che ovviamente per il cammino di Alba Dorata in Grecia.
Chiudo il ragionamento, tornando al Louvre. Il più grande museo del mondo è stato esposto negli ultimi anni alla decisa tendenza mondiale verso la mercantilizzazione dei beni culturali, tendenza che va inevitabilmente a detrimento del valore “civico” ed educativo delle opere d’arte, e che peraltro a Parigi è almeno temperata da un cospicuo apparato statale che continua nonostante tutto a produrre mostre eccellenti e a promuovere iniziative di ricerca di prim’ordine. Non è chiaro se la sinistra al potere intenda cambiare qualcosa nella politica del Louvre e dei beni culturali, anzi in base alle parole di Hollande è lecito dubitarne: ma in Francia, e ancor più in Italia, l’idea di far cassa con l’arte, passivamente subita dalla sinistra, anzi talora da essa sposata con l’entusiasmo e i complessi del neofita (diversi casi-simbolo, sopra tutti quello del sindaco di Firenze, sono raccolti nell’ultimo libro di Tomaso Montanari, Le pietre e il popolo), non è che una spia, un aspetto – e invero non il meno rilevante – di una più vasta debolezza strutturale dei partiti progressisti, della loro incapacità di fornire ai popoli europei una visione alternativa del presente e del futuro anche entro (e oltre) i limiti imposti dai tempi difficili che viviamo. Forse non sarà un caso che uno dei libri più stimolanti degli ultimi tempi a livello d’idee, Azione popolare, sia stato scritto da uno storico dell’arte, purtroppo invano invocato negli ultimi giorni tra i papabili alla presidenza della nostra Repubblica.
PS: Ogni grande tendenza storica comporta i suoi aspetti da operetta, che non di rado riguardano l’Italia: nella fattispecie, mi riferisco alla mirabolante mostra dei 140 Capolavori del Louvre che dovevano figurare a Verona nell’autunno del 2009 (c’è ancora un sito internet che fa capire l’entità dell’evento) sotto l’egida di Marco Goldin e della sua società Linea d’ombra. Per una serie di malintesi legati all’entità delle risorse da investire, e forse a più profondi conflitti personali e istituzionali, la mostra fu annullata a poche settimane dall’inaugurazione dopo ben due presentazioni ufficiali, e dopo la vendita di molti salati biglietti. Colpisce solo, a margine, che il responsabile di questo tristo fallimento, l’ineffabile Goldin, dopo aver spadroneggiato in tutto il Nord grazie ad opportuni appoggi (da Treviso a Torino, da Brescia a Genova), sia ora tornato a Verona, e sia anche diventato il dominus della basilica palladiana nella limitrofa Vicenza, dove ha depositato una sedicente mostra Raffaello verso Picasso i cui tramezzi (inamovibili ancora mesi dopo la chiusura, in attesa della prossima esposizione programmata per il 2014) impediscono e impediranno chissà per quanto di fruire compiutamente della Basilica stessa, appena restaurata.
Foto: Francois Hollande alla cerimonia di saluto dell’ex direttore del Louvre Henri Loyrette, Parigi, 9 aprile 2013 (CHRISTOPHE ENA/AFP/Getty Images)