Sorelle d’Italia
Le attrici più leggendarie degli anni epici del cinema italiano, raccontate e mostrate sul nuovo Europeo
di Claudio Carabba

altre
foto
Il numero di questo mese dell’Europeo è dedicato, all’avvio della Biennale dei Cinema di Venezia, alle dive più famose degli anni più ruggenti del cinema italiano, raccontate con una serie di articoli di Oriana Fallaci e Lietta Tornabuoni e molte belle fotografie. L’elenco è presentato da un’introduzione di Claudio Carabba.
La ragazza cantava con voce soave: «Guardando le rose / sfiorite stamani / io penso: / domani / saranno appassite. / E tutte le cose / son come le rose / che vivono un giorno/ un’ora e non più». E vai col refrain: «Ma l’amore no / l’amore mio non può / disperdersi nel vento / con le rose. / Tanto è forte / che non cederà / non sfiorirà. / Io lo veglierò / io lo difenderò / da tutte quelle insidie velenose / che vorrebbero strapparlo al cuor, / povero amor».
Scritta da un venerabile maestro del melodico come Giovanni D’Anzi, la canzone era uno dei pezzi forti del film Stasera niente di nuovo (1942), commedia aspretta diretta dal re del comico Mario Mattoli (nella sua lunga carriera ha fatto di meglio, specialmente con Macario e con Totò). Ma la canzone, intitolata appunto Ma l’amore no, è diventata una sorta di grido rampante (ne ha presentato una moderna variazione buffa Arisa a Sanremo 2010). Anche perché continuava in un crescendo di melanconia: «Forse te ne andrai / d’altre donne le carezze cercherai / ahimè / e se tornerai / già sfiorita ogni bellezza troverai / in me.
Ma l’amore no / l’amore mio non può / dissolversi con l’oro dei capelli…».
Arditi storici del costume hanno letto questo brano come una sorta di metafora, il lamento sentimentale di un’epoca che stava morendo, il regime fascista insomma. Magari è una forzatura; la giovanissima Alida Valli (era nata a Pola nel 1921) si è sempre dichiarata abbastanza estranea agli affanni della politica. Ricostruendo l’inizio della sua carriera a Roma disse per esempio: «Al Centro sperimentale ho conosciuto un sacco di gente importante… C’era anche Pietro Ingrao, il futuro deputato comunista. Loro parlavano di cose serie, specialmente di politica, ma di politica io non capivo nulla, e poi loro non mi volevano, mi consideravano troppo bambina. Cominciai a sapere che cosa era il fascismo solo nel 1941». In realtà, la verde Alida non doveva essere così sprovveduta. Si rifiutò per esempio di salire sulla zattera dei disperati, negli studi improvvisati alla Giudecca, e appena poté se ne andò all’estero a girare classici: fu una gelida imputata da delitto e fiamma del peccato nel processuale Il caso Paradine di Alfred Hitchcock (uno che di bellezze altere se ne intendeva) e poi donna del mistero in una Vienna tetra e notturna ne Il terzo uomo (1949), accanto all’infernale Orson Welles.
Quando tornò in Italia girò con massimi maestri, da Luchino Visconti (l’appassionata ma antipaticissima contessa Serpieri in Senso, nel 1954) a Michelangelo Antonioni (Il grido, 1957). La “usarono”, come musa più matura, Bernardo (Strategia del ragno, 1970) e Giuseppe Bertolucci (Berlinguer ti voglio bene, 1977). In definitiva, fra le varie attrici che fiorirono durante il fascismo, la Valli è la mia preferita, certo meglio delle segretarie private come l’insopportabile Elsa Merlini (Elsa Tscheliesnig, 1903-1983), o delle ragazze da “gli uomini che mascalzoni” e “grandi magazzini” tipo María Denis (1916-2004) o Assia Noris (1912-1998).
Accanto a queste bellezze da telefoni bianchi, c’erano anche le Veneri proibite da telefoni neri: la bruna Doris Duranti (1917-1995), che fece perdere la testa al “gerarchissimo” Alessandro Pavolini (segretario del Partito fascista repubblicano: prima di morire con Benito Mussolini, la salvò aiutandola a fuggire quando tutto crollò), o la sventurata Luisa Ferida, che, con il suo compagno Osvaldo Valenti, fu l’unica a pagare l’adesione al fascismo davanti a un plotone di esecuzione.
In mezzo c’erano femmine più aggressive e pericolose, come Clara Calamai (1909-1998), che dalla storica scena ne La cena delle beffe, forse il primo nudo del cinema italiano (il primo, una comparsata di pochi secondi, fu di Vittoria Carpi ne La corona di ferro di Alessandro Blasetti; seguì Doris Duranti, ndr), passò alla rivoluzione neorealista con l’Ossessione (all’americana) di Luchino Visconti. E come Anna Magnani, battagliera Nannarella forever. La Magnani, che si era fatta le ossa nel teatro di varietà, diventò di colpo uno dei simboli del cinema italiano con la corsa disperata dietro il camion dei nazisti che portava via il suo uomo in Roma città aperta, epico manifesto dell’antifascismo di Roberto Rossellini.
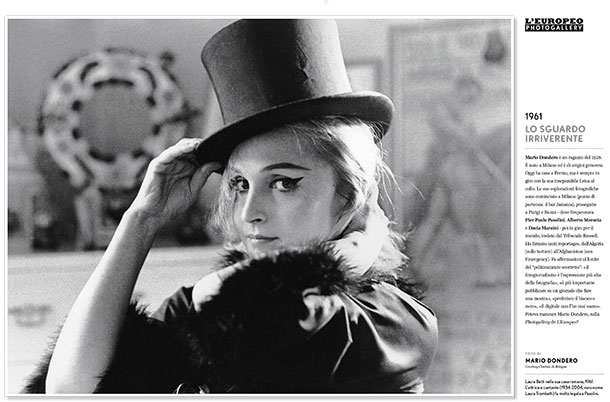
Raccontò anni più tardi lo sceneggiatore Sergio Amidei (e Rossellini non lo smentì mai) che quella scena madre, marchio di tutto il neorealismo, era nata per caso. Era notte in città e la focosa Anna aveva ricevuto la visita del suo fidanzato, il biondo Massimo Serato. I due avevano litigato furiosamente e il povero Serato (che aveva qualche colpa da seduttore farfallone) uscì via di corsa e saltò su una camionetta della produzione: «La Magnani gli corse appresso gridando i peggiori insulti di cui era capace: frocio, magnaccio e roba del genere». Secondo la leggenda Rossellini folgorato le urlò: «Ferma così, abbiamo trovato l’immagine giusta per la tua morte». Al di là della Magnani, che poi se ne andò anche in America a vincere un Oscar (per La rosa tatuata nel 1956), nel cinema italiano del Dopoguerra fiorirono straordinarie bellezze.
Molte, come Lucia Bosè, Gianna Maria Canale, Eleonora Rossi Drago e Silvana Pampanini avevano cominciato con i concorsi da Miss. Fu una specie di star system alla casalinga. La più travolgente del mazzo mi sembra Silvana Mangano, forte e voluttuosa con i calzoncini da mondina in Riso amaro di Giuseppe De Santis (1949). Su quel set pare che tutti si fossero innamorati di lei, dal “cattivo” Vittorio Gassman in giù. Passeggiava da quelle parti anche il giovanissimo Marcello Mastroianni che con il film non c’entrava nulla ma era attratto dal fascino della prorompente Silvana (ebbero una relazione, ndr). Quando l’attrice scelse di dare il suo cuore (forse commettendo un errore) al produttore Dino De Laurentiis, piccolo e francamente bruttino, in molti piansero di delusione.
Aldo Tonti, uno dei massimi operatori dell’epoca, rievocò così la crescita di quelle fanciulle in fiore: «Agli inizi erano solo delle sprovvedute fisicamente ben dotate. Ma siccome il cinema non chiedeva loro niente di diverso dalla bellezza, andavano benissimo». Tonti faceva però un profetico distinguo per la Mangano: «Silvana aveva sempre questo suo dramma interno che in Riso amaro funzionò moltissimo». I duri eventi della vita dell’attrice confermarono questa intuizione. Furono importanti in quegli anni da risveglio e ripresa le allegre ragazze da commedia comica. La bruna Silvana Pampanini e la bionda Delia Scala, vivaci “bellezze in bicicletta”, la piccante Isa Barzizza, che ammaliava in treno o sul lettino dei massaggi il grande Totò, la stella da varietà felliniano Carla Del Poggio. O, cambiando genere, Rossana Podestà, piccola e peccaminosa (lo vidi da bambino, ma il suo corpo nudo e sabbioso nel drammatico La rete, girato nel 1953 dal messicano pazzo Emilio Fernández, non l’ho più dimenticato).
Mi ricordo anche di Eleonora Rossi Drago, voluttuosamente appoggiata a una colonna in Sensualità di Clemente Fracassi; il fiero Amedeo Nazzari le si avvicinava e le diceva con voce profonda: «Vostro fratello è partito a cavallo, siamo soli». Frasi che segnano una vita. Gli anni Cinquanta furono fatalmente scanditi dal duello fra Gina Lollobrigida e Sophia Loren.
A quei tempi molto avveniva per caso. Raccontò una volta la stessa Gina: «Un giorno dell’aprile del 1946, mentre passeggiavo con un’amica in via Veneto, fui avvicinata da un uomo che mi propose di fare del cinema. Pensai in un primo momento che si trattasse di uno dei soliti importuni della strada e gli risposi male». E invece l’importuno era un noto produttore e dopo qualche giorno la ragazza si trovò davanti a Riccardo Freda, popolarissimo regista di quei tempi. Io, come spettatore, mi innamorai della Lollo un po’ dopo, vedendola in una coproduzione italo-francese, Fanfan la Tulipe. Era una storia da cappa e spada, e l’audace fanciulla faceva perdere la testa all’avventuriero Gérard Philipe, con i suoi scolli vertiginosi a balconcino. «Ma che bel panorama», commentava lo sfacciato, guardandola dall’alto. E il dettaglio è rimasto impresso per varie generazioni ai francesi che chiamarono “lollò” il petto delle donne. Il mito della Lollobrigida crebbe con il ciclo di Pane, amore e fantasia dove era la selvaggia “Bersagliera”, invano corteggiata dal maresciallo Vittorio De Sica. Invece non cedette al suo fascino il duro Humphrey Bogart, che dopo aver girato con lei il pasticciato Il tesoro dell’Africa commentò freddo: «Gina è certo ben fatta, ma per i miei gusti non è sexy, e poi io non sono un uomo per grandi seni».
Fu più lenta l’ascesa di Sophia Loren, che cominciò dai fotoromanzi («lei non sa posare, non sa fare le facce», le dicevano i redattori responsabili) e affrontò vari stenti: il primo ostacolo fu trovarle un nome giusto. Quando confessò a un produttore perplesso di chiamarsi Scicolone, quello gli rispose: «Peggio mi sento, è roba da circo». Decisivo per la carriera (e per la vita) fu l’incontro con il produttore Carlo Ponti. Gli spettatori cominciarono ad accorgersi di lei per le poppe al vento di Aida (1953) e per il ballo senza freni de La donna del fiume di Mario Soldati. Ma a creare il suo mito furono Alessandro Blasetti (in varie commedie in coppia con il giovanotto Mastroianni) e, specialmente, Vittorio De Sica, che le disegnò addosso il personaggio della sfrontata pizzaiola ne L’oro di Napoli.
Nel 1960 il grande regista portò Sophia all’Oscar, dirigendola nella Ciociara. In un primo momento la Loren doveva impersonare la figlia violentata dai marocchini, con Anna Magnani nei panni della madre. Almeno così voleva Carlo Ponti. Ma l’accorto De Sica riuscì a cambiare il cast. Pur ancora molto bella, l’attrice era troppo matura per fare la figlia; e diventò così Cesira, la madre coraggio. E il suo urlo dopo la violenza è diventata un’altra immagine simbolo del cinema italiano. Molte bellissime donne, spesso appoggiate da un marito produttore (o erano loro a sostenere gli affari?) si affermarono nei decenni Cinquanta- Sessanta.
Fra le tante seleziono Rosanna Schiaffino, bruna da “sfida” camorrista, l’irraggiungibile Claudia Cardinale da I soliti ignoti a 8 ½ e la travolgente Stefania Sandrelli, una capace di scatenare un “divorzio all’italiana” con un battito di ciglia e poi di tradirti a sangue solo con un movimento del leggiadro piedino. Altre stelle si rafforzarono lavorando per il loro regista del cuore, dalla sbigottita Giulietta Masina di Federico Fellini (il maestro e “Gelsomina” già facevano coppia alla radio durante la guerra) alla prima, tormentata Monica Vitti di Michelangelo Antonioni, che per L’avventura (1960) e L’eclisse (1962) dimenticò la sua vena buffa. Il catalogo delle donne del cinema italiano potrebbe continuare per un pezzo, come quello di Don Giovanni. Al di là delle tentazioni erotiche non è dimenticabile Franca Valeri, mitica signorina snob. Mentre si potrebbe studiare meglio la nuda galleria delle maliarde irresistibili: la “maliziosa” Laura Antonelli, tata e amica da peccato veniale, e tutta la scuderia da scuola e dei filmetti “decameronici” (Edwige Fenech, Barbara Bouchet, Nadia Cassini, gloriosa pioniera dell’importanza del lato B, e affettuosamente le altre). Per non parlare dell’acerba Catherine Spaak e delle auree ninfette da dolce inganno e voglia matta.














