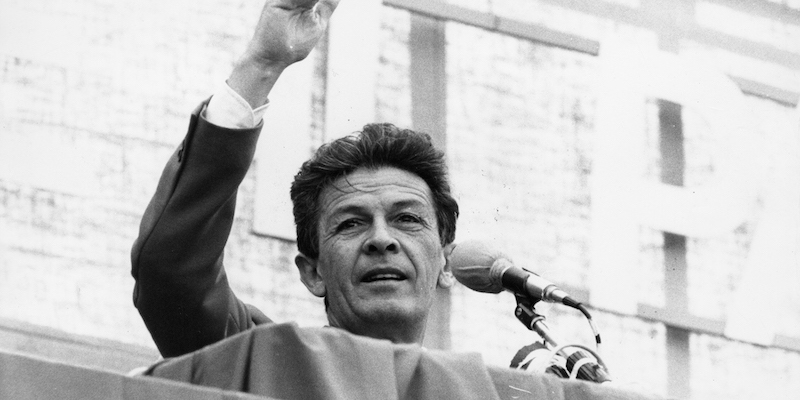A cosa serve la Leopolda
Quattro protagonisti della riunione di Firenze spiegano cosa se ne aspettano e cosa bisognerà fare dopo
di Antonio Campo Dall'Orto, Giuliano Da Empoli, Giorgio Gori, Riccardo Luna

Il 28 agosto del 1963 Martin Luther King non era di buon umore. Qualche giorno prima il presidente Kennedy, suo principale sostegno nella lotta per i diritti civili, gli aveva chiesto di cancellare la marcia di Washington per timore di spaventare l’opinione pubblica. Dagli Stati del Sud arrivavano notizie orribili di pestaggi, incendi e omicidi. Subito prima del suo discorso, Mahalia Jackson aveva cantato una canzone tristissima dedicata ai mali del mondo.
King avrebbe potuto raccontare alle migliaia di manifestanti riuniti davanti al Lincoln Memorial di aver fatto un incubo. I suoi sostenitori avrebbero vigorosamente annuito e sarebbero tornati a casa più arrabbiati di prima.
Invece, quel giorno, Martin Luther King volle raccontare un sogno. E cambiò per sempre il volto degli Stati Uniti.
In Italia, nel nostro piccolo, siamo a un punto simile.
La tentazione di mettere l’accento sui fattori di crisi e di incertezza che ci assediano è quasi irresistibile. Giorno dopo giorno, i mercati e le istituzioni internazionali ci inviano segnali d’allarme sulla salute dei nostri conti pubblici e sulla tenuta del nostro sistema finanziario. Nel frattempo, i dati ci dicono che i redditi reali sono fermi ai livelli di dieci anni fa, mentre la pressione fiscale continua ad aumentare e la disoccupazione giovanile è al doppio della media OCSE.
Se alziamo lo sguardo sullo scenario globale, non troviamo elementi di conforto. La globalizzazione vive la sua prima crisi strutturale. E non si tratta di una difficoltà puramente finanziaria. Il livello di insicurezza ha superato la soglia di non ritorno su molti fronti. Nelle ultime settimane, i ricercatori del CERN di Ginevra hanno rimesso in discussione perfino una delle pochissime certezze che ci erano rimaste: la teoria della relatività di Einstein…
Di fronte a questa situazione, in Italia si riaffaccia la tentazione del riformismo crepuscolare. Ancora una volta, di fronte alla smentita delle promesse berlusconiane, l’opposizione di centrosinistra si presenta al Paese col volto severo della Cassandra vendicata dagli eventi.
È una reazione in parte comprensibile alla spensierata irresponsabilità del governo in carica. Dalla Leopolda, però, chi scrive si aspetta qualcosa di più.
– un discorso di verità contro i tabù. Non possiamo nasconderci la gravità della fase che stiamo attraversando. Questo implica, però, la disponibilità a sfatare tabù consolidati anche a sinistra: la sacralità della casa, che ha fatto sì che le tasse, in Italia, gravino quasi tutte sui fattori produttivi e quasi per nulla sugli immobili e sui patrimoni; l’intangibilità dei diritti acquisiti che ha iscritto nel marmo la diseguaglianza tra chi ha beneficiato della generosità del welfare passato e chi vive sulla propria pelle le deficienze del welfare presente; il dualismo del mercato del lavoro, che ha diviso il mondo del lavoro in insiders e outsiders, provocando l’espulsione di oltre ottocentomila giovani dal sistema produttivo proprio quando avremmo più bisogno di innovare.
L’elenco dei tabù da affrontare per mettere in sicurezza il Paese e tornare credibili prima di tutto di fronte a noi stessi è lungo e doloroso. Illudersi di poter uscire da anni di paralisi con un semplice colpo di bacchetta magica sarebbe irresponsabile.
– una visione motivante del futuro. Il rigore nell’affrontare la crisi, però, non può prescindere dalla capacità di imprimere uno slancio in positivo. Le due cose non sono incompatibili. Anzi, è necessario che convivano se vogliamo alimentare la speranza di un cambiamento reale.
L’approccio ospedaliero della sinistra europea è perdente, di fronte ai rivolgimenti in corso su scala globale. Esso si giustifica solo con il timore permanente di un ricatto massimalista. Sulla base del quale, riconoscere le opportunità offerte dal nuovo scenario competitivo significherebbe manifestare indifferenza nei confronti dei più deboli, di coloro che fanno più fatica a trovare il loro spazio nella società del XXI secolo.
Invece è vero esattamente il contrario. La promessa della vecchia economia grosso modo suonava cosi: “se lavori duro e risparmi sarai ricompensato con la sicurezza, un reddito in crescita nel corso della tua carriera e una pensione affidabile”. Questa promessa di stabilità è stata spazzata via e non può essere restaurata. L’idea che le uniche battaglie da combattere siano quelle a difesa dei diritti acquisiti è assurda. La nuova economia ha bisogno di una visione motivante e di istituzioni pensate per farla funzionare. L’unica via d’uscita è riuscire a coinvolgere le forze più vitali nella costruzione di un nuovo modello competitivo che abbia lo stesso potenziale di inclusione sociale del precedente.
Nel corso degli ultimi anni, l’economia italiana si è profondamente trasformata. E lo ha fatto senza seguire le fosche previsioni dei profeti del declino. La desertificazione industriale non c’è stata. Mentre tutti si stracciavano le vesti lamentando la struttura inadeguata della nostra industria, si è scoperto che, sia pure con qualche scossa di aggiustamento, la manifattura ha retto. Nel 2011 le esportazioni vanno bene, nonostante la crisi, e le quote di mercato sono quelle di otto anni fa.
Il mancato declino non è frutto del caso, bensì di ragioni strutturali che avremmo potuto analizzare in anticipo, se non fossimo stati assordati dalle grida delle cassandre. La globalizzazione – dicono gli esperti – è composta essenzialmente di due cose. Un abbassamento delle barriere sui mercati lontani e una crescita tumultuosa, su quei mercati, di una classe media affluente e consumista. Entrambi questi fattori hanno favorito un’industria come quella italiana, fatta di piccole imprese dinamiche orientate all’estero e posizionate sui prodotti giusti.
Nel maggio del 2010, il sorpasso in borsa di Apple ai danni di Microsoft ha segnato il primato del capitalismo culturale. Un sistema nel quale il valore estetico e di esperienza dei prodotti conta almeno quanto il loro contenuto tecnologico. Possibile che, in un contesto del genere, l’Italia non riesca a trovare la sua strada?
La verità è che, nel nostro Paese, si sono prodotti mutamenti nella struttura economica, sociale e culturale che non hanno ancora trovato una traduzione politica. A questo punto, tutto dipende dalla capacità di fare leva sugli elementi più vitali della trasformazione in corso per ricostruire una visione motivante del futuro.
– la fine della questione generazionale. In Italia, la questione generazionale è finita. Non perché le condizioni dei giovani siano migliorate: è vero il contrario. Ma semplicemente perché l’emergenza è quella di un Paese nel quale il vecchio sistema delle paghette del nonno che compensavano le lacune del welfare dei nipoti non funziona più. I costi dell’immobilismo non sono più concentrati su alcune fasce di outsider: stanno creando metastasi nel corpo sociale nel suo insieme.
In modo analogo, i segnali di rinnovamento non arrivano certo esclusivamente dalle generazioni più recenti. La Leopolda sarà l’appuntamento di tutti gli innovatori, e dovrà smentire anche una volta per tutte chi fa finta di non aver capito che il concetto di rottamazione si applica alla classe politica, non ai milioni di cittadini e di lavoratori che hanno gettato le fondamenta di una delle democrazie industrializzate più avanzate del mondo.
– l’affermazione di nuovi protagonisti. Il problema è che parlano sempre gli stessi. La ridicola sovraesposizione della politica fa sì che i protagonisti del mutamento siano occultati dagli schiamazzi dei peones dell’immobilismo. Il grado di notorietà dei Bocchino e degli Scilipoti è, assurdamente, molto superiore a quello degli Alessandri o dei Ghisolfi.
La Leopolda deve servire anche a questo: usare la sovraesposizione mediatica della politica per dare visibilità ai protagonisti di un rinascimento possibile. Immettere nel dibattito nazionale i volti e soprattutto le idee di una nuova categoria di imprenditori, di studiosi, di uomini e di donne del volontariato e dell’associazionismo, di amministratori locali che hanno il potenziale per cambiare l’Italia.
– il valore di un’ora. In tutte le società avanzate, la grande barriera che tiene gli outsider fuori dalla politica è il tempo. Nel mondo del lavoro, ma anche nel tempo libero, il valore di un’ora si è moltiplicato per venti o per trenta grazie ai progressi della tecnologia. In politica, invece no. Lì le forme della partecipazione continuano a essere quelle di sempre: interminabili riunioni e assemblee dall’esito incerto, comitati e sottocomitati che passano giornate intere a non decidere nulla. Sarebbe frustrante per chiunque. Ma per chi è abituato ai tempi istantanei della rete, è addirittura insopportabile.
Nelle sue modalità di svolgimento, ma soprattutto nel seguito che l’incontro avrà nei mesi successivi, la Leopolda dovrà imporre un nuovo paradigma. Presenza on e off-line devono avere pari dignità e intrecciarsi di continuo. Per quante persone in gamba si possano riunire in una sala, perfino gigantesca come la Leopolda, le idee migliori sono sempre là fuori, in attesa che qualcuno le vada a pescare.
Un rigoroso discorso di verità unito a una visione del futuro, l’iniezione di nuovi protagonisti nel dibattito nazionale attraverso un ripensamento delle forme stesse dell’azione politica: immaginare che tutto questo accada in un weekend sarebbe ridicolo. Ma, come dice il saggio, anche un viaggio di mille chilometri inizia con un singolo passo.