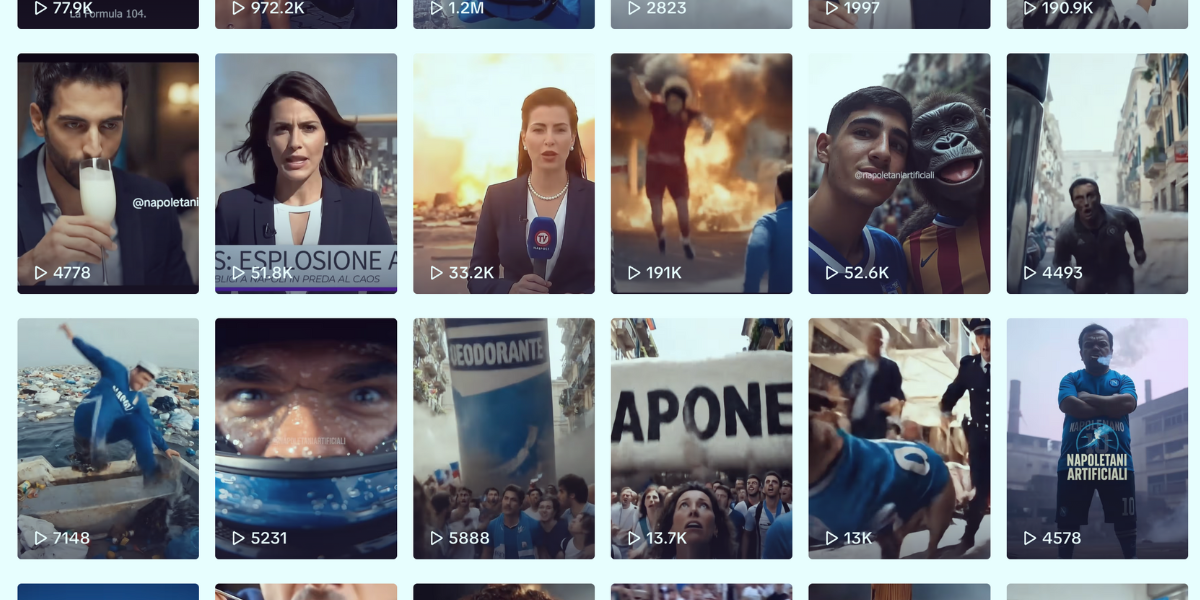Troppo connessi?
Ci vuole più internet, non meno, scrive Federica Colonna sul Secolo
di Federica Colonna

«Ho fatto un corso di lettura veloce. Ho letto Guerra e pace in due ore. Parla di certi russi…» Woody Allen non è tra i più accaniti sostenitori dello speed reading, la lettura rapida tanto di moda qualche tempo fa. La sua (poco) velata critica potrebbe oggi rappresentare la battaglia di chi scorge pericoli e trappole anche nello speed thinking, il pensiero veloce cui ci ha abituato l’uso di Internet.
Susan Mausahart, paladina dei critici d’Oltreoceno e autrice del fortunato L’inverno della nostra disconnessione, analizza i rischi cui siamo sottoposti stando con le dita premute sui touch-screen e con il cervello concentrato sul susseguirsi rapido delle notizie. La giornalista non è una conservatrice tecnofobica, né ovviamente fa parte del pubblico di Rete 4, abituato dai servizi di Emilio Fede a considerare Facebook un coacervo di mali indicibili e vergognose attitudini. Susan Maushart è, invece, una signora avvezza alla digitocrazia e suggerisce agli utenti americani una dieta tecnologica dimagrante, promossa anche sulle pagine del Wall Street Journal. L’invito a staccarsi dallo schermo del computer e a spegnere BlackBerry e iPhone durante le conversazioni con gli amici, le cene galanti e le serate in famiglia non è nuovo: è, anzi, un monito provenuto da più parti e lanciato spesso da voci autorevoli. È un bene o meno essere always on, sempre connessi?
La domanda nasconde una trappola cognitiva, c’è una parola spia da cancellare dal vocabolario: sempre. Il rischio è, infatti, che il dibattito venga animato da due fazioni di ultrà i cui punti di vista sono poco utili a capire l’impatto del web sulla società attuale. Ci sono i fautori della connessione perpetua, che nemmeno in vacanza, magari durante una passeggiata in alta quota, riescono a staccare la suoneria da ufficio dell’aggiornamento mail sullo smart phone. Sono i cyberentusiasti, sereni solo se hanno a portata di mano la mail del capo, vivono di stress, sorridono instancabili sulla foto del profilo LinkedIn. I grandi oppositori sono invece i timorosi tecnofobici, convinti che nel nuovo si nasconda sempre il barbaro male, conservatori persino nella capigliatura, hanno di solito idee in grado di scadere in fretta come gli yogurt del discount.
«Sono due atteggiamenti depressivi, perché dogmatici, impediscono di comprendere». Li liquida così, Douglas Ruskoff, entrambi, gli allegri digitomani e i grigi spaventati. Vincitore del primo Neil Postman Award, premio alla carriera come intellettuale di rilievo pubblico, è un giovane guru degli studi mediatici, concentrato sugli sviluppi e le implicazioni della cultura pop. Autore di Program or be programmed. Ten commands for a digital age, pone le condizioni per un dibattito davvero proficuo. «Il ragionamento sulla bontà o sulla cattiveria della Rete è inadatto a dare le risposte alle vere domande del nostro tempo. La Rete è ovunque, non è solo da qualche parte. La vera domanda è: la usiamo o siamo noi ad essere usati?». Il tranello c’è, riuscire ad evitarlo dipende dalla consapevolezza degli internauti. Esiste, allora, un modo per stare bene on line, così come ne esiste uno per vivere bene, per stare al mondo. Ruskoff descrive dieci regole basilari e tutte vertono su un assunto chiave: il linguaggio di programmazione è la letteratura del tempo contemporaneo. Ognuno ha da compiere una scelta: capire il web e accedere, così, al pannello di controllo della civilizzazione, oppure restare inconsapevole e subire gli effetti della Rete. Internet è un pezzo di mondo, per starci bene è necessario conoscerlo, non valgono a nulla i preconcetti, né sono giuste quelle le domande in grado di contenere in sè una risposta e di rafforzare un pregiudizio.
Mashable, sito di riferimento per tutti gli appassionati di web e social media, organizzatore del Mashable Award, premio annuale per la migliore campagna on line, il brand più connesso e il personaggio più abile e seguito su Twitter, Facebook e simili, accoglie le tesi di Ruskoff. «La rete è uno spazio infinito, di cui non abbiamo ancora capito tutte le potenzialità – si legge nel commento a Program or be Programmed – Per non sprecare l’occasione di comprendere e portare fino in fondo le conseguenze dirompenti del web dobbiamo conoscere le dinamiche di mercato e di scambio che lo riguardano». L’idea chiave descritta su Mashable è affascinante; il web ha ricreato la società peer to peer, come quella del baratto, la vita on line è un palinsesto personale in continuo aggiornamento. Il modo per stare bene in rete, allora, è non farsi condizionare dalle discussioni e dalle mode lanciate dai brand. Per vivere on line in maniera sana bisogna diventare guru e non subire il fascino degli altri guru, perchè «siamo noi a costruire l’organismo sociale del web, siamo noi a determinarne le buone regole di comportamento. Se il web riesce davvero a esse rivoluzionario dipende da noi, dal nostro comportamento quotidiano». Bisogna starci, allora, online, ma con la testa.
Per la fondazione Edge, nata nel 1988 con il nome di The Reality Club e diventata il punto d’aggregazione on-line del pensiero contemporaneo più originale e innovativo, la domanda è posta male. Non si tratta di chiedersi se la rete è un bene o meno, la Edge Annual Question, il quesito dei quesiti è: come Internet sta cambiando il modo in cui pensi? Evitando con accuratezza di stare dalla parte degli Alice della situazione, per cui il web è una sorta di paese delle meraviglie, Edge riconosce due elementi considerati problematici ne L’inverno della nostra disconnessione: la pressione costante dell’overload comunicativo e della disponibilità informativa immediata. Scienziati, scrittori, architetti, linguisti hanno risposto, allora, alla domanda dell’anno partendo da questo assunto problematico.
«Stiamo diventando Pancake People», sostiene Richard Foreman, drammaturgo americano conosciuto per pièces teatrali sperimentali e provocatorie. L’immagine è evocativa e un po’ comica: esplodiamo in un istante, come se fossimo pieni di conoscenza, dati, esperti di tutto, ma sempre velocemente implodiamo, basta lo spillo di una domanda più approfondita, ci sgonfiamo in un attimo. C’è un famoso articolo che gira tra gli analisti americani, scritto da Nicholas Carr: “Google ci sta rendendo stupidi?”. La tesi di fondo riguarda la difficoltà a leggere testi lunghi, ad approfondire. È un falso problema, sostengono però gli studi sull’apprendimento e sulla capacità dei media di incidere sulle nostre facoltà intellettive. Se, infatti, i testi on line sono frammentati è anche vero che le persone leggono in media di più e che, grazie ai link, sviluppano l’abilità di connettere temi diversi. Inoltre ogni individuo è costretto a capire se le informazioni di cui viene a conoscenza sono esatte o sbagliate. Per ogni dato esiste un anti-dato, per ciascun esperto un anti-esperto: chiunque, come in Wikipedia, è chiamato a dare il proprio contributo e la qualità della conoscenza non è mai acquisita una volta per tutte, è frutto iper-dinamico di costanti revisioni, dubbi, domande. «Non ho più certezze e non le voglio più – scrive Kevin Kelly, giornalista e cofondatore di Wired – Non sono più interessato alla Verità, ma alle verità». A ben vedere, allora, Google non ci sta rendendo più stupidi, incapaci di percorrere fino in fondo un percorso cognitivo, abituati alla superficialità. Potrebbe essere il contrario: diventando più dubbiosi siamo anche più capaci di critica, di fare domande, di guardare oltre. Siamo, cioè, più intelligenti. Facciamo più connessioni, individuali e sociali insieme. Abbiamo una mente più grande.
Il web, infatti, è strutturato come il cervello, ogni sito e profilo è un neurone e l’intelligenza sociale si crea a partire dal legame elettronico tra i link, proprio come nella testa di una persona. Il romanzo di Fred Hoyle, La nuvola nera, racconta la rete proprio come un grande cervello futuro. La nuvola è un viaggiatore interstellare sovrumano dotato di un grande sistema nervoso. Ogni unità che lo compone comunica con l’altra via radio a una velocità elevatissima. Le distinzioni tra singoli sono cancellate dalla rapidità delle connessioni. Ecco, la società post-umana potrebbe essere più o meno così: le persone si comprendono all’istante, perchè capiscono la comunicazione del loro interlocutore nel momento stesso in cui formula un pensiero, come se esistesse un megacervello creativo. L’ipotesi è adatta a una storia post-atomica, però coglie un aspetto: l’intelligenza sociale è maggiore, più dinamica, più veloce e in grado di dare soluzioni nuove, rispetto a quella individuale.
Secondo il sociologo di fama planetaria Derrick de Kerckhove, direttore del Programma McLuhan in Cultura e Tecnologia e autore di La pelle della cultura e dell’intelligenza connessa, Internet sta davvero cambiando il nostro modo di pensare. «Il tema fondamentale dei miei libri è questo: è possibile interpretare lo sviluppo della psiche dell’uomo occidentale in relazione ai mezzi di comunicazione? Il linguaggio o è esterno e ci controlla oppure è interno e lo controlliamo. Se è al di fuori, allora abbiamo un potere minimo sul nostro destino e una scarsa autocoscienza, una libertà limitata. È il caso della tv. Se il linguaggio proviene da dentro, allora siamo più liberi, come con i libri e il computer».
Il ragionamento di de Kerckhove è anche una risposta ad un altro best-seller, che sta animando il dibattito negli Usa e rappresenta, con le proprie tesi, una motivazione in più per i sostenitori della dieta tecnologica promossa dal Wall Street Journal. You are not a gadget, non sei un gadget, è il recente saggio di Jaron Lanier, computer scientist, filosofo, docente, musicista, considerato dall’Encyclopedia Britannica tra i 300 più importanti inventori della storia. Insomma, uno che se ne intende e non è propriamente animato da tecnofobie modello Emilio Fede. La creatività individuale sta passando di moda, la musica sta diventando una ripetizione ossessionante di ritmi e brani già ascoltati, persino gli individui stessi sono superflui e demodè. Lanier descrive così la famosa saggezza delle masse, come un riciclo noioso e banale di cose già dette, comunicate e persino pensate. La personalità è fuori moda, out. Una volta appreso il meccanismo ogni persona non fa che rimetterlo in pratica all’infinito, in modo veloce, privo di fantasia. Lanier scrive un manifesto a supporto degli umani, una difesa strenua e fascinosa dell’essere pensante, libero, dell’uomo inventore della vita e delle cose.
In definitiva la risposta alla domanda sul pericolo di stare molto tempo on line, sembra essere, come sempre, nelle sfumature dei ragionamenti, nelle particolarità. La conoscenza del linguaggio, la comprensione del modo di scrivere e di vivere la Rete ci renderà individui liberi. L’ignoranza, le certezze preconcette, la paura, ci renderanno, invece, semplici widget, accessori da blog.
La riflessione riguardante vivibilità del web, però, è dominata da esperti americani, il consiglio di imbastire una dieta tecnologica non viene da un quotidiano di Roma. L’Italia, oggi, come sostiene Giovanna Cosenza, ha troppa fame: «Parlare di dieta tecnologica in Italia – afferma – è come parlare di disturbi alimentari in Africa!». I dati indicano una chiara difficoltà: navighiamo in condizioni più impervie degli altri paesi europei, anche a causa dei costi alti di connessione, spesso lo facciamo solo dal luogo di lavoro, usiamo raramente dispositivi mobili. Insomma, negli USA ci sarà pure una ragione per discutere di eccessi e limitazioni a fronte di abitudini e modi di connettersi bulimici. Noi, che siamo anoressici, non possiamo evitare di assaggiare nessun piatto. Abbiamo bisogno, al contrario, di una dieta tecnologica ingrassante.
Questo articolo è uscito sul Secolo di domenica 23 gennaio 2011