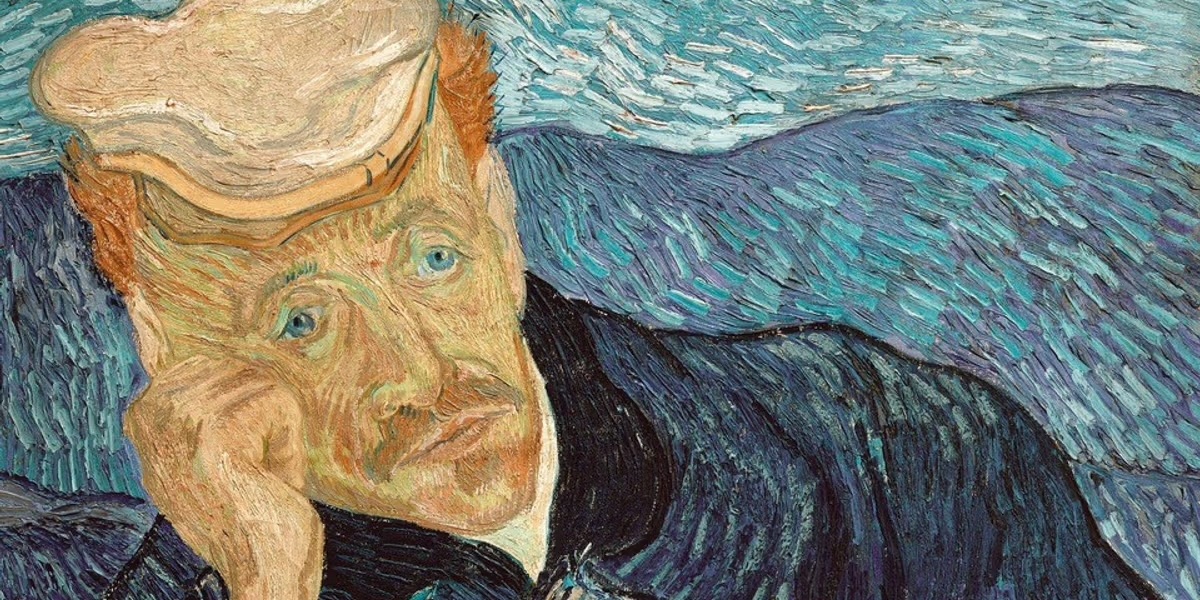‘mbuto
Lo stato di ubriachezza con cui l’informazione italiana ha seguito le cose di Wikileaks in questi due giorni ricorda inevitabilmente il rapporto dei giornali con internet in generale una decina d’anni fa, quando qualunque notizia avesse dentro la parola “internet” guadagnava di filato un suo spazio in pagina nel quale non si capiva una cippa. Il gap tra attenzione al fenomeno e comprensione del fenomeno era straordinario e di ovvia spiegazione: meno capisci una cosa, più ti affidi alle semplificazioni, perdi la complessità e i dettagli, ti dedichi ai titoloni senza chiederti se la notizia ci sia o non ci sia. Non sapresti risponderti.
E così adesso per due giorni è sembrato che nei documenti si parlasse solo dei “festini” di Berlusconi, quando i documenti dedicati all’Italia finora diffusi sono due su 280 e la parola “festini” non ricorre se nell’isolata espressione “partying hard” (darci dentro con le feste) dedicata da una signora americana semplicemente alla tesi che il PresdelCons si riposi poco. Ma era cominciato da prima: per cercare di non mostrarsi impreparati, domenica la Stampa era uscita con una storia sul Papa ingannevolmente associata a Wikileaks (non c’entrava niente, è già sparita) e il Corriere con un’intervista all’ambasciatore Spogli ultraenfatizzata malgrado lo stesso ambasciatore dicesse che non sarebbe successo nulla.
Oggi Christian Rocca sostiene che nei documenti mostrati finora non ci sia praticamente niente: non sono del tutto d’accordo con lui – ci sono diverse storie affascinanti e qualche notizia, anche se nessuna da saltare sulla sedia – ma ha di certo più ragione del 90% di quello che è uscito in questi due giorni. Anche Massimo Mantellini ha analizzato l’approssimazione con cui Wikileaks viene spiegata, approssimazione che è tutto fuorché divulgazione o semplificazione: piuttosto falsificazione ed errata informazione. E in estrema sintesi la spiegazione è purtroppo facile e suona saccente persino alle orecchie stesse di chi la formula e di chi ha seguito queste cose da un po’ di tempo e ha cercato di capirle: la spiegazione è che non ne sanno niente. Si trovano improvvisamente per le mani fenomeni nuovi persone che non ne hanno seguito la genesi, non conoscono quel mondo, non conoscono questo tempo: ed è inevitabile, se fino a ieri le tue priorità informative erano le dichiarazioni di Casini, le puntate di Porta a porta, o Ruby.
Da tempo vado formulando un’ipotesi sull’autosufficienza dell’arretratezza italiana: un paese dove le avanguardie di modernità e innovazione invece di trascinare avanti le retroguardie ne vengono trattenute indietro. Un paese in cui la palude si autoalimenta e la mediocrità e l’anacronismo si nutrono di se stessi: si parla di Porta a porta, si va a Porta a porta, la gente guarda Porta a porta e quindi si riparla di Porta a porta. È un sistema chiuso e impermeabile all’intelligenza, alla qualità e al progresso. E non conosce momenti di scardinamento nemmeno quando è costretto ad accogliere elementi del mondo di fuori completamente sovversivi: perché invece li ingloba, li riconduce a se stesso e li fa divenire Porta a porta. E così è stato con la storia Wikileaks, i suoi contenuti e le sue forme: raccontati non per quello che sono ma per quello che è familiare: festini, provincialismo, informazione fatta male.
Aggiornamento: devo correggermi sull’intervista dell’ambasciatore Spogli, che evidentemente metteva le mani avanti su qualcosa di effettivamente cospicuo, altro che festini.
Vedi anche: