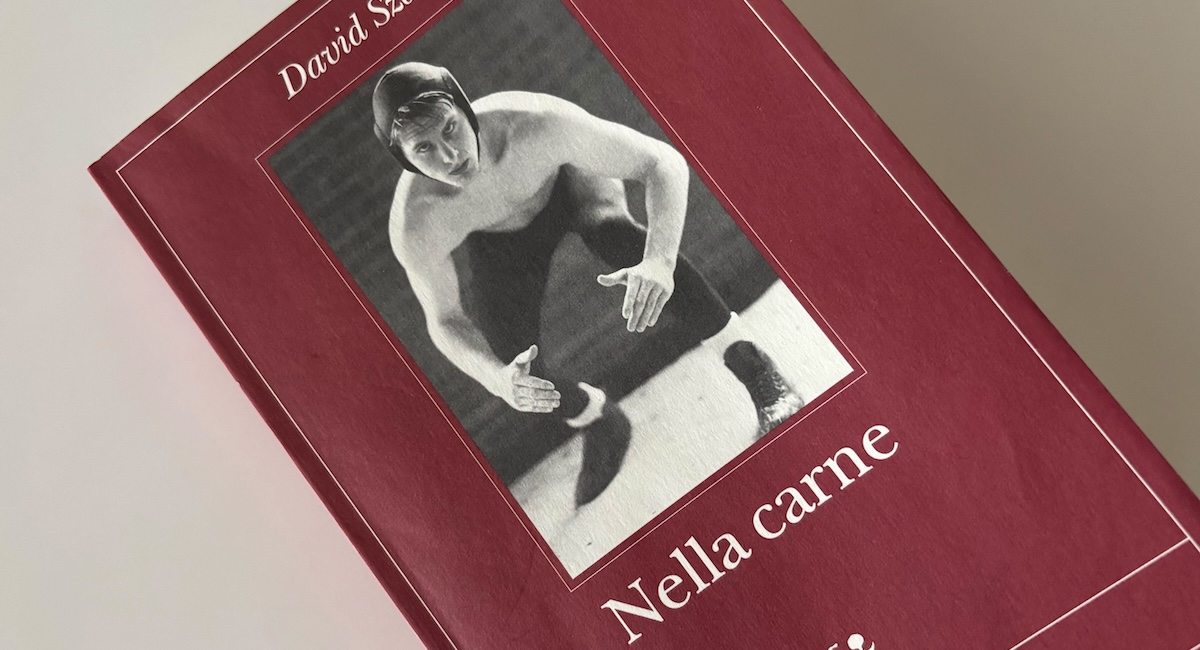Ideona per la crescita: più ricambio
Ha ragione il ministro per lo sviluppo economico Corrado Passera quando afferma, come ha fatto domenica in tv da Lucia Annunziata, che «per la crescita non c’è un’ideona». Giusto. Bastano e avanzano buone idee. Idee, cioè, concretamente percorribili e innovative. Solo che le buone idee hanno tutte un duplice comune denominatore: necessitano di un “habitat” favorevole per emergere; mirano a mutare il corso delle cose, a promuovere il cambiamento, in sostanza a mettere in discussione posizioni consolidate di potere. Due condizioni che in un Paese ingessato come il nostro si rivelano spesso proibitive. Se non impossibili.
Basta guardare a ciò che succede con le fondazioni bancarie e con la Borsa, due “luoghi” simbolo delle difficoltà di ricambio di classe dirigente. Infatti al vertice di fondazioni bancarie e imprese ci sono da troppo tempo, anni e anni se non decenni, quasi sempre le stesse persone. Ma in queste condizioni le buone idee non spuntano fuori. Perché chi prova a sfornarle scopre presto che chi dovrebbe implementarle non di rado finisce con l’annacquarle o non prenderle affatto in considerazione per non intaccare le proprie posizioni di potere. È quindi verosimile che dopo uno, due, tre tentativi i flussi di buone idee si interrompano, lasciando ai promotori amaro in bocca se non senso di frustrazione. Le fondazioni bancarie e la Borsa sono, appunto, paradigmi molto significativi di questa dinamica.
Partiamo dalle prime. Poco meno di due mesi fa (il 26 febbraio), due economisti di vaglia come Luigi Zingales e Roberto Perotti scrissero sul Sole 24 Ore un articolo particolarmente tranchant in cui sostenevano, tra le altre cose, che: «Le fondazioni sono tanto più pericolose perché sono pervase di buone intenzioni e ammantate di una patina di rispettabilità. Nell’immaginario collettivo esse finanziano progetti meritori nel campo della cultura e del volontariato e beneficiano la società civile. Ma il prezzo da pagare è altissimo, una rete fittissima di clientelismo a monte e a valle delle fondazioni per ingraziarsi il potere politico, acquisire consenso e distribuire prebende».
Giuseppe Guzzetti, classe 1937, presidente della Fondazione Cariplo (dal 1997) e dell’Acri, l’organismo di rappresentanza delle fondazioni bancarie (dal 2000), non la prese bene e, qualche giorno dopo (il 2 marzo), si misurò in un serrato confronto radiofonico (su Radio radicale) con lo stesso Zingales il quale affermò che «la Fondazione Cariplo gestisce soldi che sono dei lombardi, soldi che vengono gestiti da un vecchio gruppo di notabili che non ha alcun mandato dai cittadini per far questo». Al che Guzzetti ha replicato: «Io ho un mandato che mi deriva dal fatto che la legge dello Stato ha previsto in un certo modo di comporre gli organi…chi ci manda a casa sono i cittadini lombardi che verificano ogni 4 anni quello che abbiamo fatto e se non va bene mettono nelle loro terne (di candidati per l’organo di indirizzo della fondazione proposte dagli enti locali, da università, da camere di commercio e gerarchie ecclesiastiche) persone che ci mandano a casa».
Perché ho riportato questo scorcio di dibattito? Per una ragione molto semplice. Perché formalmente il discorso di Guzzetti non fa una grinza. Ma il nocciolo della questione è un altro, ossia che se si occupa una certa poltrona per troppo tempo si finisce poi sistematicamente per essere rieletti alla stessa carica perché gli “elettori”, avendo instaurato nel frattempo consolidati e proficui rapporti di collaborazione con i vertici delle fondazioni ci tengono a non cambiare interlocutori. Con il risultato finale che però alla fine chi ne risente di più è la capacità propositiva e innovativa della stessa fondazione e, quindi, i suoi stakeholder in senso lato.
E un esempio molto indicativo in proposito lo ha fornito lo stesso Guzzetti due giorni fa in un’intervista rilasciata ad Affari&Finanza per comunicare che l’Acri si è dotata di una Carta che si propone di tener lontana la politica dalle fondazioni stabilendo, così ha rivelato il presidente dell’associazione delle fondazioni, che «chi ha fatto politica non può entrare in una fondazione se non dopo un periodo di decantazione di uno-due anni (e chi lo stabilisce se uno oppure due? ndr). La discontinuità deve valere anche in uscita: chi è stato dentro una fondazione non potrà candidarsi in un partito se non passeranno uno o due anni di sabbatico».
E questa sarebbe un’ideona che dovrebbe spazzar via ogni dubbio circa l’invadenza della politica nelle fondazioni bancarie? Come se non fosse risaputo che il potere vero dei vertici delle fondazioni, molto forte e tangibile, derivi dalla loro stretta vicinanza con il potere bancario e, più in generale, con i cosiddetti salotti della finanza. E in ogni caso fa riflettere che la domanda dedicata al caso fondazione Mps («Almeno in un caso, quello Mps, la fondazione è stata finora controllata da Comune e Provincia, altro che ente terzo…» ha chiesto il giornalista Adriano Bonafede), Guzzetti l’abbia liquidata in una riga: «Lei ha citato un caso particolare». Sarà anche particolare ma, come scrivevano Zingales e Perotti nell’articolo sopra citato, «per questioni di potere le fondazioni hanno concentrato il loro patrimonio nelle banche locali. Questa gestione ha portato alla perdita di più di 4 miliardi di euro nella sola fondazione Montepaschi, minacciandone la sopravvivenza. E nessuno ne viene considerato responsabile».
Eppure un’idea per innovare il mondo delle fondazioni bancarie ci sarebbe: stabilire un limite al numero dei mandati, dopo due mandati lo stesso presidente non dovrebbe potersi più ricandidare. Un limite simile ce l’ha Confindustria (fino a pochi anni fa era un mandato di due anni rinnovabile una sola volta, poi è stato stabilito un solo mandato di 4 anni non rinnovabile), ce l’hanno i sindaci, ce l’ha persino la Banca d’Italia dopo l’esplosione del ”caso Fazio” nel 2005 (prima il mandato del governatore era a vita), non si capisce perché non debbano averlo i vertici delle fondazioni bancarie e dell’associazione che le rappresenta.
Per completezza di informazione, la scorsa settimana Guzzetti è stato rieletto presidente dell’Acri, carica che ricopre dal 2000, per un altro triennio, fino al 2015.
E veniamo al secondo “paradigma”, quello della Borsa.
In questi giorni è in corso la quotazione a Piazza Affari del gruppo tessile di Brunello Cucinelli, fondato nel 1978 dallo stilista e imprenditore umbro di Solomeo, comunemente definito “imprenditore umanista” oltre che “re del cachemire”. Si tratta di una azienda gioiello dove l’attenzione all’ambiente, al rispetto delle esigenze dei lavoratori, alla creazione di nuova occupazione la rendono un caso scuola di cosa voglia dire coniugare sul serio etica ed economia. Il punto è che si tratta della prima matricola di Borsa di questo 2012. Siamo arrivati a metà aprile ed appena adesso una nuova azienda ha deciso di esordire in Piazza Affari, collocando il 30% del capitale.
Se si pensa ai noti problemi di strozzatura del credito bancario in atto da molti mesi sembra un controsenso visto che una delle poche valide alternative per approvvigionarsi di capitali è appunto quella di quotarsi in Borsa. Ma un simile passo comporta tutta una serie di obblighi di comunicazione, rendicontazione e trasparenza che i nostri imprenditori non sembrano disposti a voler compiere, come spiegava bene Salvatore Bragantini, ex commissario Consob, qualche settimana fa (il 5 marzo su Corriere Economia): «Le famiglie azioniste preferiscono di solito l’illusione ottica del controllo assoluto su imprese che in conseguenza di questa scelta autarchica stentano a sopravvivere (e non possono progettare sviluppi innovativi), ai rischi della navigazione in mare aperto di un’impresa più forte, ma che esse non controllano più in modo incontrastato. I nuovi investitori, infatti, vogliono un management scelto, scrutando non l’albero genealogico familiare, ma la competenza e il carattere, questo non meno di quella necessaria per ben guidare un’impresa». Per cui si arriva al paradosso che un’azienda come Benetton decide di uscire dalla Borsa (ricomprandosi le sue azioni per 210 milioni di euro, tramite il finanziamento di tre banche, IntesaSanpaolo, Unicredit e Mps), «per attuare», così si legge nel prospetto informativo, «una strategia di aggiornamento e rafforzamento del modello di business finalizzata a migliorare il posizionamento competitivo e per beneficiare di una più adeguata flessibilità finanziaria». Ha commentato ironico Alessandro Penati (su Repubblica del 17 marzo): «E io che credevo il contrario: che la quotazione servisse a facilitare la crescita tramite acquisizioni e l’accesso al credito vista la migliore garanzia che le azioni offrono in questo caso».
E pensare che di recente è stato calcolato che portando a 1000 le società quotate (adesso sono 300 scarse) a Piazza Affari si genererebbe un aumento del Pil dello 0,9-1,5%, un incremento di 2,85 miliardi di euro del gettito fiscale e 137.000 nuovi posti di lavoro in un anno.
La crescita quindi non ha bisogno di ideone. Bensì di buone idee. A patto che se ne agevoli l’emersione e poi camminino su gambe non anchilosate per eccesso di sedentarietà sulla stessa Poltrona.