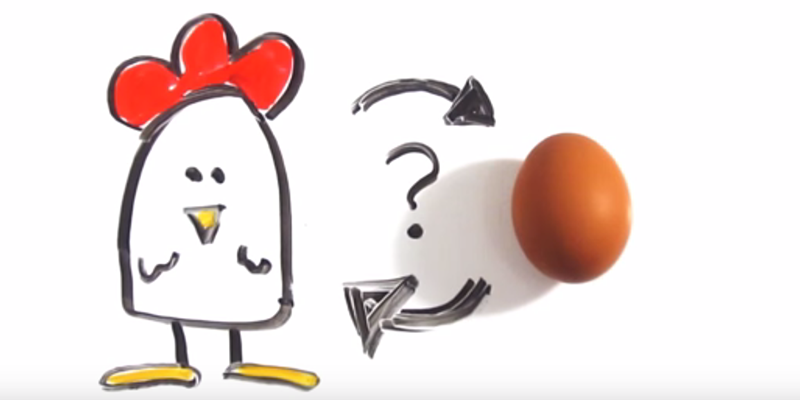Respirare l’ombra
“Possa tu vivere in tempi interessanti”. L’estate scorsa questo auspicio di dibattuta origine (una maledizione cinese, secondo un famoso discorso di Bob Kennedy a Città del Capo), i cui ambigui risvolti inducevano molti addetti ai lavori a variopinti gesti apotropaici, è stato il titolo della Biennale veneziana d’arte contemporanea a cura di Ralph Rugoff: la mostra proliferava di distopie, cadaveri, apocalissi, scheletri e deformità, e culminava nel padiglione danese con un potente video di Larissa Sansour, In Vitro, che immaginava il dialogo tra una madre morente e una figlia immemore nel sottosuolo di Betlemme, dove i superstiti si erano rifugiati in seguito alla calamità ecologica che trent’anni prima aveva reso inabitabile la città della Palestina, compresa la Basilica della Natività.
Un anno dopo, quasi a confermare la vena “nera” di una rassegna che in molti padiglioni pareva annunciare la fine dell’Antropocene, i tempi sono diventati interessanti per davvero. Ed è partita tra amatori e specialisti la corsa a cercare le opere degli ultimi tempi più adatte a incarnare – se non la peste in sé – almeno il lockdown o il momento di lacerante fissità: per esempio, l’ominoso vuoto delle metropoli ha portato alla mente le Strassen del fotografo tedesco Thomas Struth, e gli strazianti squilibri del nostro universo hanno trovato un’eco nelle “dissezioni” di Anish Kapoor.
Mille altre, ovviamente, le possibili sinapsi, che sconfinano facilmente nel reame del macabro (le tombe di Jan Fabre o di On Kawara), dell’apocalittico (tutto Thomas Hirschhorn), dell’uncanny nella reclusione (la Casa morta di Gregor Schneider), o dell’emergenziale (i letti da campo alla Tate in TH 2058 di Dominique González-Foerster, come in queste settimane alla Fiera di Madrid).
C’è però forse una chiave che travalica i confini della semplice analogia didascalica, e va dritta alla sostanza del Coronavirus. Si è detto – lo dicono i firmatari di una “preghiera civile” lanciata in vista della Giornata della Terra che si celebra il 22 aprile – che la presente calamità non solo è materialmente connessa al maltrattamento dell’ambiente (dall’inquinamento che facilita il contagio e infirma i sistemi respiratori di chi poi contrae la malattia, fino alla piaga degli allevamenti intensivi che facilitano lo spillover e la zoonosi), ma discende dalla malposta presunzione umana di dominare il mondo obliterando i nostri indissolubili legami di appartenenza e mutua dipendenza rispetto al reame animale e vegetale, e violando gli equilibri esistenti fra le specie: “Ogni componente organica e inorganica, dai microorganismi agli esseri umani, concorre a formare un unico complesso sistema che mantiene le condizioni di vita sulla Terra”.
Si può pensare ciò che si vuole circa queste affermazioni, e i loro effetti pratici sui nostri futuri comportamenti quotidiani: ma se c’è una cosa in cui il virus ha trionfato è stato il richiamo alla pertinenza della specie umana al mondo cui credeva di dettare legge. Se c’è stato un movimento che ha fatto dell’identificazione uomo-natura, “che non ha più il fine teologico del narrator-narratum medioevale, ma un intento pragmatico, di liberazione e non di aggiunzione di oggetti e idee al mondo, quale oggi si presenta” (così Germano Celant nell’articolo “fondativo” del 1967), questo è l’Arte Povera italiana.
Su tutti, Giuseppe Penone, e, su tutte le sue installazioni, quella che fodera le pareti di una stanza vuota con foglie di alloro (o, in un’altra versione, di tè) contenute entro apposite gabbie metalliche, e mette al centro (appoggiata quasi mimeticamente su una di quelle pareti, oppure isolata in mezzo all’ambiente) una riproduzione in bronzo dorato a dimensioni naturali (dunque, relativamente piccole) dell’apparato respiratorio umano.
Viviamo in tempi di polmoniti interstiziali e di trombosi polmonari, tempi in cui fabbriche d’auto si convertono a sfornare respiratori e i saturimetri sono merce rara nelle farmacie, tempi in cui ognuno è introflesso con terrore a misurare la propria temperatura corporea e ad auscultare ogni fruscio sospetto dei propri bronchi: nata vent’anni fa a valle di una lunga ricerca sulla materia dei Soffi, l’installazione Respirare l’ombra (1999) incarna plasticamente la compenetrazione fra uomo e ambiente che si verifica ogni volta che introiettiamo ed emettiamo un volume d’aria.
“Nel respiro, in un attimo, il vivente e il cosmo si ricongiungono, e sigillano un’unità diversa da quella che segna l’essere e la forma”, afferma Emanuele Coccia nel suo La vita delle piante (Il Mulino 2018). Quella di Penone è una scultura che non vuole insegnare nulla, ma nemmeno soltanto compiacere sul piano estetico: mira a invadere gli esseri umani con uno pneuma di alloro (la pianta dei poeti laureati, la pianta di Dafne, la pianta che protegge dalle zanzare) o di tè (la pianta che beviamo, la pianta dell’India e della Cina, ormai e partibus contagionis), con un soffio che trascolora al passare del tempo esattamente come l’aspetto di quelle foglie, come la capienza e la fluidità dei nostri alveoli. Dorati nel riflesso, brillanti nella loro precaria vitalità, i polmoni umani si volgono alla luce tanto quanto introiettano l’ombra della propria finitudine: l’ombra approfondita ormai nel nostro quotidiano dalle mascherine destinate a proteggerci dal “fuori”.
In mezzo a un’arte contemporanea sempre più cerebrale, artificiale, corriva, l’immersione lunga, sospesa e silenziosa che Penone richiede (a Parigi, a Versailles , a Venezia, a Rivoli dove Respirare l’ombra è esposta in pianta stabile) allunga il campo della nostra umanità facendoci percepire, presentificando un oggetto altrimenti inafferrabile, e dando senso tangibile e familiare anche al nido invisibile in cui – ci si ripete ossessivamente – s’accampa il virus.
Non è, questa, ecologia tradizionale, né rivendicazione di romantici ritorni a improbabili comunioni o stati edenici, bensì la constatazione dell’interdipendenza e dell’equilibrio instabile in grazia del quale noi umani viviamo dentro la “natura” (nelle sue forme più varie e variamente spiranti, dalle foglie d’alloro al bacillo del Covid) tanto quanto essa vive in noi; e, per quanto deinòi (direbbe Sofocle), non siamo in grado di predire come scorrerà, che profumo, che forma avrà il nostro prossimo respiro, o se esso – l’atto più naturale, magico e irriflesso – ci sarà intercluso. Forse in base a questa sensazione (e consapevolezza) si potrà capire più facilmente, senza scivolare nel New Age o nel Buddismo, come intervenire a modificare il mondo (cosa di per sé inevitabile, se non necessaria per ogni essere vivente) sia anche intervenire, fisicamente, su noi stessi.
PS: Garessio, paesino del Cuneese dove Penone è nato nel 1947 e di cui da tre mesi è cittadino onorario, è stato duramente provato dal Coronavirus: il sindaco Ferruccio Fazio, radiologo e pneumologo già ministro della Salute nel Berlusconi IV (quando affrontò la pandemia di suina e auspicava “una sanità integrata ospedale-territorio”, ma secondo alcuni non dimenticò il milieu delle grandi aziende private lombarde da cui proveniva) combatte il focolaio sviluppatosi in una casa di cura, recuperando mascherine dalla Germania e chiamando tutta la collettività a uno sforzo comune di resistenza e di coesione.
Così accade in tanti piccoli paesi (del Veneto, dell’Emilia, della Lombardia) in cui “si conoscono tutti”, e ora “tutti hanno paura”. Un inedito trattato greco del ‘500, dedicato alla natura delle leggi, sviluppa una sottile allegoria del corpo civico, secondo la quale proprio al polmone – l’organo che permette la vita del cuore – corrispondono l’amicizia e l’accordo fattivo (sympnoia, il “soffiare insieme”) fra tutti i membri di una comunità.