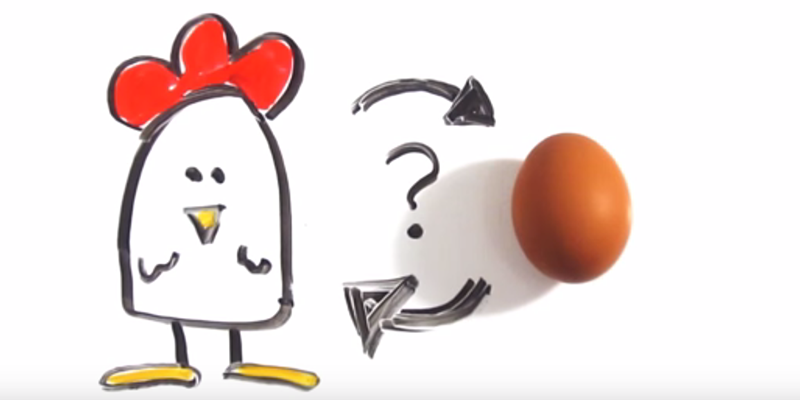Perché Napoli non è Londra, spiegato col colera
Pare sia andata così: erano ancora in voga le teorie miasmatiche – vapori infetti che si sprigionavano dagli affollati agglomerati urbani – ragione per cui le autorità francesi di diverse città della Provenza decisero di allontanare una parte della popolazione dai sobborghi, e dunque dai suddetti vapori. Il classico esodo forzato e le prime vittime furono gli italiani emigrati in Francia, gran parte in Provenza, circa 70 mila – tutti molto poveri, e che, per forza di cose, alloggiavano nei quartieri più degradati, e lì l’igiene era un lusso. E dunque i ghetti italiani vennero considerati focolai miasmatici pericolosissimi e da svuotare al più presto e l’Italia dovette accogliere una massa di concittadini impoveriti, spaventati e potenzialmente contagiati dal colera.
Accogliere sì, ma dove? Non c’era ancora chiarezza sull’origine della malattia (anche se Filippo Pacini nel 1854 aveva visto e disegnato il vibrione – “non sono affatto rettilinei ma un po’ curvi” – e successivamente Koch, nel 1884, si trovava a Calcutta, aveva annunciato di averlo isolato in una coltura di feci prelevata da pazienti con il colera, mentre era assente in pazienti che mostravano solo sintomi di diarrea senza la malattia) e tuttavia l’esperienza ricavata dalle precedenti epidemie – che dal 1830 si erano abbattute sull’Europa – aveva insegnato che per prevenire e ridurre il contagio, bisognava per prima cosa migliorare l’igiene e poi predisporre un cordone di ospedali in grado di accogliere i malati.
Ma si era nel 1884 e l’Italia non poteva vantare né adeguati sistemi fognari né appositi ospedali e quindi si decise di ricorrere a un sistema di prevenzione abbastanza screditato: i lazzaretti.
C’è una discussione aperta in letteratura sull’efficacia di quest’ultimi, o meglio: la scomparsa della peste in Europa a partire dal XVIII secolo non è stata spiegata in modo esauriente. Se le quarantene, soprattutto per le navi in arrivo da porti contagiati, furono probabilmente efficaci, molti altri fattori, come cambiamenti nell’ecologia del ratto – il bacillo della peste alloggia nelle pulci dei ratti – e miglioramenti nella dieta umana, ebbero sicuramente un ruolo nella drastica riduzione della peste.
E poi il colera è un batterio che sopravvive nell’intestino umano e nell’ambiente esterno solo in certe condizioni di temperatura, alcalinità, insomma quelle proprie dei liquami fognari.
Fatto sta che nonostante l’Italia avesse partecipato nel 1874 a una conferenza sanitaria a Vienna, nel corso della quale lazzaretti e cordoni erano stati giudicati inefficaci e controproducenti, e nonostante avessimo sottoscritto le dichiarazioni finali, si approntarono lo stesso lazzaretti improvvisati vicino al confine, fra Bardonecchia e Ventimiglia: e solo per motivi politici, insomma, per rassicurare la popolazione, non certo per scopi medici.
Altri emigrati vennero invece spediti, via mare, nei lazzaretti sull’isola di Nisida di fronte a Napoli e sull’isola di Varignano di fronte a La Spezia.
Se allestisci dei lazzaretti poi ci vogliono i soldati che presiedono, e se dispieghi i soldati – tra l’altro per affrontare un problema sanitario – oltre a spaventare gli emigrati, comunichi un messaggio chiaro: i contagiati sono nemici e non malati da curare.
Il risultato fu la nascita spontanea, soprattutto in Calabria e in Sicilia, di gruppi di autodifesa pronti a tenere alla larga, con ogni metodo, stranieri, sconosciuti, vagabondi e minoranze etniche, tra cui gli zingari, che vennero considerati untori.
E dunque – riprendendo e riassumendo e considerate le premesse – pare sia andata così: il paziente zero sarebbe sbarcato tra luglio e agosto 1884 da una nave – quella che portava gli emigrati dalla Francia nel lazzaretto sull’isola di Nisida. A Nisida i controlli erano stati affidati a un improvvisato corpo di guardie molto attente nel trarre il massimo guadagno dagli emigrati e dunque con la tendenza a contrabbandare placidamente persone, cibo e vestiti con la terraferma (poi il vibrione che alla fine arrivò anche in Italia e a Napoli nel 1884 era partito da molto più lontano: dall’Indocina, terra che i francesi stavano tentando di conquistare. Da una nave militare francese il vibrione era sbarcato a Tolone, nel maggio del 1884. L’ipotesi più accreditata individua la via del contagio negli effetti personali di alcuni soldati deceduti in Indocina e riportati nella madrepatria).
Insomma, dovunque fosse arrivato il paziente zero, aveva buone probabilità di corrompere le guardie, passare il cordone e scatenare un’epidemia. Così accadde.
Del resto le condizioni igieniche della città erano pessime. Tanto per indicare alcuni punti: solo nei fondaci, le grotte urbane, vivevano dai 30 ai 90 mila uomini, donne e bambini in un totale stato di miseria. Axel Munthe, un medico svedese volontario durante l’epidemia di colera del 1884, in Letters from a Mourning City le definisce «le più terrificanti abitazioni sulla faccia della Terra»
I dati forniti da Snowden, nel suo Naples at the Time of Cholera 1884-1911, sono impressionanti: Snowden ha molto faticato per raccoglierne sul quel particolare periodo e la difficoltà di reperire statistiche ufficiali del comune dà un’idea dell’indifferenza verso questa umanità – per chilometro quadrato la città bassa di Napoli ospitava 130 mila abitanti, mentre nella città in generale erano 64 mila. Per fornire delle misure comparative: Londra 13 mila, Roma 28 mila, Parigi 29 mila e Torino 34 mila. Discorso a sé meriterebbero le «locande», stanze che venivano affittate alla sterminata schiera di lavoratori occasionali e nomadi, che si accalcavano su materassi o pagliericci buttati per terra e chissà se mai sostituiti.
La condizione della rete idrica poi: l’acqua, non potabile e inquinatissima, arrivava da due acquedotti, il Bolla e il Carmignano (il più recente, del 1627). In 200 anni mai nessun ampliamento e pochissima manutenzione. Fatto sta che i 45 mila metri cubi di acqua al giorno erano già inquinati prima di varcare i confini cittadini. I canali scoperti passavano per le campagne, i contadini qui si lavavano, facevano il bucato, maceravano lino e canapa e altro. In città l’acqua finiva in circa 2000 cisterne. Nessuno ha mai calcolato le infiltrazioni. Peggio andava con l’acqua tirata su dai circa 4500 pozzi artesiani, contaminata dai liquami fognari dispersi al suolo. Almeno la popolazione più ricca e benestante, che viveva sulle colline, raccoglieva l’acqua piovana in cisterne private.
Le fogne avevano un’estensione di 180 chilometri, ma erano realizzate però per il drenaggio dell’acqua piovana. Senza manutenzione, quel poco che le fogne riuscivano a trasportare finiva nella Baia, inquinando il mare, dal mare poi venivano pescati i molluschi, alimento anche allora molto popolare. La gran parte delle abitazioni, soprattutto nella città bassa, non aveva alcun tipo di sistema fognario, tutto giù per le scale, nei cortili o per strada.
Sempre Snowden cita un dispaccio inviato dal console americano Frank Goddard Haughwout al Dipartimento di Stato: 22 dicembre 1884, a Napoli non esiste la categoria degli idraulici, perché non esistono tubature o reti idriche come negli Stati Uniti. Spazzini? La maggior parte di loro si occupava di pulire le belle strade, via Toledo o la piazza del Duomo. Nelle altre vie, quelle meno importanti, ci si limitava ad aprire un varco nelle immondizie, in modo da permettere la circolazione. Così i rifiuti ammucchiati e messi da una parte dagli spazzini la mattina, venivano, in teoria, portati via il pomeriggio da imprese private: carri trainati da asino e caricati da uno o due ragazzini. Da una parte caricavano dall’altra rispargevano per strada, causa buche, sobbalzi e della copertura approssimativa del carretto. La mattina dopo gli spazzini ricominciavano ad aprire un varco nell’immondizia, e così via.
Di conseguenza i dati sulla mortalità sono impressionanti, mostra sempre Snowden: tra 1878 e il 1883 per 1000 abitanti a Napoli, nelle sezioni più popolose della città (Porto 33,7 Mercato 32,9 Pendino 33,3 Vicaria 32) c’era una mortalità del 40 per mille (o di poco superiore) che sui lunghi periodi non è compatibile con la sopravvivenza di una società umana. Gli indici di mortalità della città bassa nella Napoli di fine Ottocento erano molto vicini al limite dell’insostenibilità demografica.
Il 31 agosto morirono di colera 82 persone. Il 10 e l’11 settembre, la cifra era di 550 morti. Poi ci fu il panico: si cominciò a sospettare che il colera fosse in realtà un complotto per ridurre di numero la popolazione più povera, un genocidio.
Del resto c’erano sempre le prescrizioni della teoria miasmatica, tra l’altro riveduta e corretta da Max Pettenkofer, e allora il municipio di Napoli prelevava con la forza i malati di colera per isolarli, ma inizialmente c’era un solo ospedale disponibile, quello di Conocchia. Intanto vestiti, lenzuola, materassi venivano bruciati da una seconda squadra, mentre la stanza e il vicolo dove abitava il contagiato venivano disinfettati con asfissianti fumigazioni allo zolfo.
Il problema era che dagli ospedali pochi tornavano vivi, sia perché il ricovero avveniva in una fase ormai terminale, sia perché le terapie anticolera erano quasi tutte più letali del colera stesso: la malattia lasciata al suo corso uccideva circa il 50 per cento dei contagiati, con quelle terapie si arrivava a una mortalità anche dell’80 o del 90 per cento. Basta scorrere la lista delle terapie in uso: purgare l’organismo dai vapori miasmatici, quindi purganti e sanguisughe o sudoriferi e bagni caldi. Con conseguente aumento della disidratazione e della mortalità. Oppure combattere il colera con stricnina, arsenico, acido prussico, composti del mercurio: aumento della mortalità. O ancora clisteri acidi. Questo perché Koch aveva scoperto che il bacillo del colera viveva in ambienti alcalini. Quindi alcuni suoi seguaci come Arnaldo Cantani (non approvati da Koch) immaginarono che creando un ambiente acido nell’intestino il colera venisse debellato: altissima mortalità.
La Croce Bianca ebbe un ruolo importante nel ridurre la tensione creatasi nella città. La strategia che adottò fu infatti quella di curare a casa i malati e di non usare mai la forza negli interventi. Alla fine si registrarono il 68% di guarigioni e il 32% di decessi, mentre negli ospedali le percentuali erano rovesciate: 70% di decessi, 30% di guarigioni.
I morti del colera del 1884 a Napoli furono in appena due mesi e mezzo 7200: in tutta Italia si contavano 14 mila vittime, quindi a Napoli si era verificato ben il 50 per cento dei decessi. Non doveva più succedere. Le cronache del tempo raccontano del Re Umberto e del primo Ministro Agostino Depretis in visita a Napoli, entrambi particolarmente scossi, toccati, tanto che rifiutarono il protocollo ufficiale, si spinsero fino nei luoghi del degrado, non ebbero paura del contagio e alla fine, in tempi rapidissimi, il 15 gennaio 1885, il Parlamento italiano approvò la legge per il risanamento della città di Napoli: 100 milioni di lire per le grandi opere necessarie. Napoli andava sventrata, cioè bisognava abbattere tutte le sezioni della città bassa, Porto, Mercato, Pendino e Vicaria, aprire strade larghe, soleggiate e arieggiate, ricostruire edifici igienici, serviti da acquedotti e fogne. Lorenzo Pinna nel suo libro Autoritratto dell’immondizia fornisce alcune cifre: 90 mila persone degli slum della città bassa dovevano trovare un nuovo e decente alloggiamento, 144 vicoli stretti e malsani dovevano scomparire, 127 strade dovevano essere allargate, 521 costruzioni fatiscenti e 56 fondaci dovevano essere demoliti.
Sì, vero, a Roma, Torino e Milano, erano stati effettuati interventi di risanamento nei decenni precedenti, ma si trattava di opere su piccola scala. Invece lo sventramento di Napoli era un progetto di dimensione analoga a quelli che avevano segnato la trasformazione di Parigi e di Londra: aprire una strada lunga e ampia: rettifilo appunto (l’attuale corso Umberto I, anche se a Napoli continuiamo a chiamarlo il rettifilo), sul quale si dovevano innestare ad angolo retto, sia a destra che a sinistra, 16 strade, anche queste larghe e soleggiate. Il piano stradale della città bassa sarebbe stato rialzato di tre metri, con le cosiddette colmate, per bonificare bassi e fondaci e allontanare le fondamenta dall’umidità e dalle falde acquifere infette che imputridivano il suolo e generavano i micidiali miasmi perché il piano urbanistico di Napoli seguiva i precetti delle teorie miasmatiche di Pettenkofer. Le colmate avrebbe permesso la costruzione della rete fognaria, grazie alla maggiore pendenza: un sistema di pompe avrebbe sollevato le acque luride dalle zone più basse, per scaricarle lontano dalla Baia di Napoli, a Licola, nei pressi di Gaeta.
Come a Londra e Parigi. Piccolo dettaglio, a Napoli non ci saranno figure all’altezza di Haussmann o Bazalgette.
Fu un fallimento. Lorenzo Pinna in un capitolo del suo autoritratto nell’immondizia, scrive un paragrafo illuminante: dieci istantanee per un disastro – che qui riporto – riassumendo così alcune pagine della dimenticata relazione della Regia Commissione d’inchiesta per Napoli, istituita l’8 novembre 1900 e presieduta da Giuseppe Saredo, e che tra l’altro venne venne istituita nella certezza che non avrebbe concluso molto. Invece, la straordinaria efficienza e l’indipendenza della Commissione misero in imbarazzo, a sentire Nitti, in primo luogo, lo stesso governo.
Dunque:
1) Mancavano progetti precisi e studi dettagliati, soprattutto per quel che riguardava le case da espropriare e gli abitanti della città bassa da ricollocare in nuove abitazioni da costruire.
2) La totale responsabilità delle grandi opere per la bonifica di Napoli era stata affidata, in concessione, a una sola impresa privata, la Società Anonima per il Risanamento di Napoli (fondata da quattro banchieri settentrionali). Il comune di Napoli, nonostante le precise disposizioni della legge del 1885 sul risanamento, abdicò completamente al ruolo direttivo.
3) La commissione tecnica della Società Anonima per il Risanamento, cioè l’organo che dirigeva tutti i lavori era composta quasi completamente da persone esperte di finanza, ma non di ingegneria. Uno soltanto era ingegnere (ferroviario).
4) La Società Anonima per il Risanamento violava sistematicamente gli impegni contrattuali, elevando a quattro piani edifici previsti di tre, restringendo la larghezza delle strade, eliminando le aree verdi, non sincronizzando l’abbattimento dei vecchi edifici con la costruzione di quelli nuovi, nelle aree di «ampliamento». Il tutto in una logica bancaria e predatoria lontanissima da quella industriale delle spese produttive alla Haussmann.
5) Il comune dava prova di negligenza, «distrazione» e omissioni nel controllare che i lavori della Società Anonima procedessero secondo i progetti e i capitolati concordati. Gli ispettori non si accorsero mai delle violazioni.
6) Dopo appena 4 anni (il contratto era di 12), la Società Anonima dichiarò di essere sull’orlo della bancarotta e minacciò il comune di Napoli di interrompere i lavori lasciando la città sconvolta dai cantieri aperti e fermi. Ottenne, per riprendere i lavori, di stralciare 30 interventi di bonifica – quelli commercialmente meno interessanti – e così rimase in piedi il 50 per cento circa degli slum della città bassa. Nonostante gli stralci ne avessero ridotto gli impegni, la Società per il Risanamento riuscì a farsi rifinanziare per altre due volte.
7) La Società pagava pochissimo le ditte subappaltatrici e queste, per avere un margine di guadagno, costringevano i lavoratori a ritmi impossibili, con salari da fame, usando materiali scadenti e tecniche non adatte.
8) L’ingegnere-capo della commissione tecnica della Società, Martinoli, mise in piedi una fiorente impresa di mattoni, da cui, come è facile immaginare, dovevano rifornirsi le ditte subappaltatrici se volevano continuare a lavorare. I mattoni prodotti da Martinoli erano costruiti a basso costo e con materiali di pessima qualità, con il risultato che si sbriciolavano superata una certa pressione.
9) La rete fognaria (grandi collettori e diramazioni secondarie) fu costruita solo nella città alta e non in quella media e bassa, dove era assolutamente indispensabile. Neanche il rialzo del piano stradale venne realizzato. Le nuove abitazioni costruite (che portarono all’aumento degli affitti, non certo alla portata degli sfollati degli slum) erano insufficienti e di pessima qualità.
10) Nel 1900, oltre 11 anni dopo l’inizio dei lavori (quindi al termine previsto dal contratto) solo il 60 per cento delle opere era stato completato, e la città bassa non era stata bonificata. Come scrisse Matilde Serao: “vi sono dei vicoletti che precipitano per mezzo di dislivelli paurosi, di scalette ripide, difese da rozze ringhiere, in tutto ciò che sta dietro il Rettifilo, vicoletti sinuosi, vicoletti neri, angoli dove due o tre vicoli s’intersecano dirupandosi, tutto un disegno bislacco e grottesco”.
Ci fu una vera e propria cricca, guidata dal deputato Alberto Casale, in odore di camorra, dal sindaco Celestino Summonte, e da Edoardo Scarfoglio, direttore del Mattino, con molti altri complici che gestivano i lavori pubblici della città.
Le gare di appalto per le opere pubbliche venivano aggiudicate, con ribassi vertiginosi fino al 44 per cento, sempre a una ristretta rosa di ditte privilegiate; il ribasso era un trucco per aggiudicarsi la gara.
Scrive Saredo:
“Gli appaltatori erano incoraggiati a mettersi nella via ruinosa dei ribassi esagerati, nella certezza di trovare nella imperfezione dei progetti o in qualche clausola dei contratti, nell’analisi dei prezzi, una ragione o un pretesto per assicurarsi un compenso doppio o triplo del ribasso oppure di ottenere, con la connivenza degli assessori del ramo o degli ingegneri, altri e maggiori guadagni mercé l’ordinazione di nuove opere suppletive per lo più non giustificate, o con la concessione di compensi e magisteri non compresi nei progetti e non dovuti”.
Poi il colera tornò nel 1911.
Ma invece a Londra e Parigi?
Sempre Lorenzo Pinna: “Bazalgette operò circa trent’anni prima del risanamento napoletano. E comunque la direzione e la responsabilità dei lavori spettavano al Metropolitan Board of Works: un ente pubblico. L’opera fu poi suddivisa in grandi sezioni, ognuna delle quali venne data in appalto.
Per ogni contratto d’appalto gli uffici tecnici del Metropolitan Board preparavano le mappe e i disegni dei luoghi e dei lavori da svolgere, specificando le dimensioni e le misure delle opere, le tecniche di costruzione, i materiali da impiegare e le loro specifiche tecniche. Erano disegni molto dettagliati e una volta completati venivano passati al Quantity Surveyor. Quest’ufficio quantificava il lavoro da eseguire, precisando tutto: quanti metri cubi di terra si dovevano rimuovere, quanti metri cubi di cemento dovevano essere impiegati, quanti mattoni erano necessari per quella data sezione dei lavori.
Il piano così elaborato veniva sottoposto da Bazalgette all’approvazione del Board e in caso positivo si procedeva alla gara pubblica d’appalto.
Tutte le informazioni tecniche, insieme ai metodi di pagamento previsti (e alle penali in caso di ritardata consegna), venivano rese pubbliche con una gara il cui annuncio appariva su riviste specializzate, e il prezzo più basso di un’offerta non era l’unica condizione per vincere una gara. Bazalgette, ad esempio, rifiutava di assegnare lavori particolarmente impegnativi a imprese che non avessero precedenti esperienze nel campo. Per la grande vasca collegata al collettore di scarico a nord, quello di Beckton, vinse così l’appalto la ditta Furness, la cui offerta era di 520 000 sterline, invece che Ridley, che aveva proposto una cifra di 490 000 sterline. Per un compito così impegnativo, disse Bazalgette, l’impresa Ridley, era soprattutto in costruzioni ferroviarie, non dava sufficienti garanzie della buona riuscita dell’opera.
Ironie amare: se esaminate i dati sulla costruzione dell’inceneritore di Acerra e stilate le vostre dieci istantanee per un disastro, potete notare come quest’ultime siamo – per mancata di metodologia di controllo e furberie varie – straordinariamente simili a quelle dieci istantanee che hanno portano al fallimento dello sventramento di Napoli, più di 150 anni fa.
Forse nella ricostruzione del caso dell’inceneritore di Acerra bastano solo tre punti per evidenziare le similitudini metodologiche e le differenze non dico con i moderni metodi di controllo ma con quelli messi in atto, in pieno Ottocento da Bazalgette:
– Come da contratto veniva affidato all’impresa vincitrice il compito di scegliere il sito dove costruire gli inceneritori. Il commissario straordinario se ne lavava le mani. Il vincitore opterà per due siti, Acerra e Santa Maria la Fossa, a meno di 20 chilometri in linea d’aria tra loro e nelle zone più colpite dalle discariche illegali della camorra. E piazzerà nelle vicinanze anche 4 impianti del CDR (cioè: 6 impianti in meno di 40 chilometri). Questa scelta causerà molti conflitti, e si rivelerà uno degli errori fatali, perché i ricorsi ai tribunali da parte dei comuni interessati rallenteranno le autorizzazioni e la costruzione degli inceneritori.
– Nel presentare il proprio progetto, il vincitore sapeva di non poter rispettare alcune clausole del bando (cioè il limite del 50 per cento dei rifiuti trasformati in CDR e lo smaltimento obbligatorio nell’attesa degli inceneritori). Se le avesse rispettate non avrebbe potuto fare un’offerta così.
– Il metodo di finanziamento del progetto era il project financing, ossia la realizzazione del progetto doveva avvenire senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione. In parole povere: l’impresa anticipava i soldi che avrebbe poi recuperato con la concessione, per dieci anni, della gestione del sistema di smaltimento e degli inceneritori. A questo finanziamento partecipava anche un consorzio di banche che prestavano i soldi al vincitore, ma che a un certo punto, visto che le cose si mettevano male, chiusero i rubinetti. Alla fine il commissario straordinario sarà costretto ad anticipare (e perdere) 100 miliardi di vecchie lire (cosa non prevista dal contratto).
Ecc.
Se poi, sempre in vena di ironia, fate un conto: se calcolate il costo della più straordinaria opera di ingegneria civile, cioè, la rete fognaria costruita da Bazalgette, nella Londra di metà Ottocento (che è tuttora la spina dorsale del sistema londinese), scoprirete che si aggira intorno a 4,6 milioni di sterline dell’epoca traducibili, a seconda dei metodi impiegati per attualizzare questa cifra, in una somma tra i 3,5 e gli 8 miliardi di euro. La stessa somma che, fatti i calcoli, si è speso per l’emergenza rifiuti a Napoli: una delle più straordinarie opere dell’ingegno umano è costata quanto l’assurda e fallimentare emergenza napoletana.
Sono storie di insuccesso che vale la pena ricordare affinché ci siamo futuri successi.
- Il libro di Frank M. Snowden, Naples in the Time of Cholera, 1884-1911 Cambridge University Press: è il migliore (e completo, affascinate) resoconto di questa storia ora lontana ma ancora, purtroppo, particolarmente istruttiva. È strano notare che quasi tutte le ricerche storiche sul colera a Napoli sottovalutano o liquidano le due epidemie, soprattutto quelle del 1910-12 come un incidente sanitario di proporzioni insignificanti. Frank M. Snowden alcuni anni fa ha rivisto molto approfonditamente i dati su queste epidemie, utilizzando anche nuove fonti come quelle del Dipartimento di Stato statunitense, che riceveva sia i rapporti del consolato americano di Napoli, sia i bollettini segreti delle autorità. Il suo libro non è mai stato tradotto in italiano e la gran parte delle informazioni in queste post sono state da questo libro riassunte.
- Autoritratto dell’immondizia di Lorenzo Pinna, Bollati Boringhieri: è una lunga e dettagliata cavalcata nei nostri 10 mila anni di storia, attraverso le città pestilenziali di un tempo. Esamina e analizza sia le soluzioni sia gli errori che abbiamo trovato o compiuto per liberarci dai rifiuti. Vi trovate sintesi efficaci e veloci, come le dieci istantanee per un disastro. Per ammissione dell’autore, anche questo libro, nella ricostruzione del colera a Napoli, è debitore a Snowden.
- La Regia commissione d’inchiesta per Napoli. Relazione sull’amministrazione comunale, di Giuseppe Saredo – Curatore S. Marotta, Editore La Scuola di Pitagora: è bellissima, un vero esempio di inchiesta tecnica, approfondita e indipendente. In sintesi e tra le altre cose tra cui la gestione del risanamento di Napoli a seguito epidemia colera, si trovano questi concetti: la Commissione definì “alta camorra” quella praticata “dai più scaltri e audaci borghesi”, i quali, approfittando della ignavia e della miseria, riuscivano a ricavare lauti guadagni brigando nelle adunanze politiche, nelle pubbliche amministrazioni, nei circoli e nella stampa cittadina per ottenere appalti e praticare commerci.