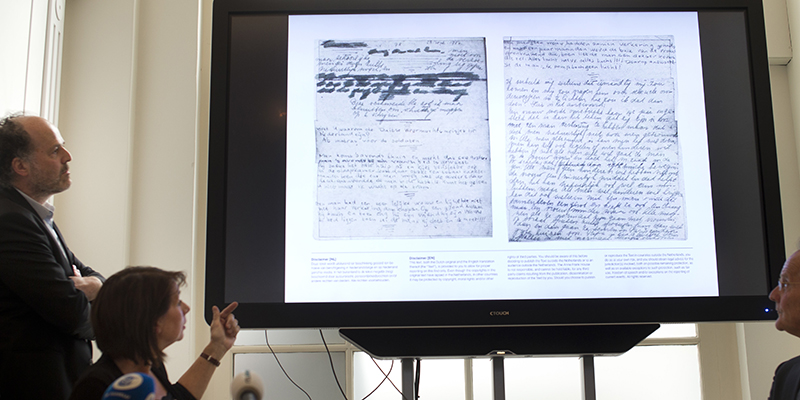Concentrarsi su sé stessi non rende necessariamente più felici
È un approccio sempre più diffuso anche in contesti di psicoterapia, ma che non può valere per tutto

In una loro canzone del 1966, “I am a rock”, Simon & Garfunkel cantavano: «Se non avessi mai amato, non avrei mai pianto. Sono uno scoglio, sono un’isola». Tutto il testo era una citazione ironica della poesia dell’autore inglese John Donne Nessun uomo è un’isola, un titolo spesso usato anche colloquialmente per ricordare che le vite umane sono interconnesse, ed è giusto e inevitabile che sia così.
Alcuni approcci terapeutici che riscuotono da anni grande successo, sui social, nei libri di auto aiuto ma anche nei percorsi di psicoterapia, sembrano però fondati su un’idea opposta: che sia utile imparare a prendersi cura di sé liberandosi delle aspettative, delle pressioni e delle fatiche che derivano dalle relazioni con gli altri. Se non proprio rinchiudersi nella «fortezza», per dirla con Simon & Garfunkel, quantomeno imparare a «lasciare andare» gli altri, per dirla con il titolo di uno dei libri di auto aiuto di maggiore successo recente.
Dell’opportunità di interrompere o meno alcune relazioni sociali si è parlato di recente anche a proposito di storie di figli di persone famose che non parlano più con i loro genitori, come il primogenito di David e Victoria Beckham, Brooklyn. Quelle storie sono diventate sui social dei pretesti per discutere e nella maggior parte dei casi comprendere e giustificare le scelte di chi, per varie ragioni, si allontana volontariamente dalla propria famiglia. Spesso sono scelte descritte come forme di autodifesa dolorose ma sane e, in una qualche misura, inevitabili.
Alla base c’è effettivamente un’idea sana, e cioè che certi sacrifici e certe sofferenze non vadano sopportate a prescindere solo perché lo impongono alcune convenzioni sociali ormai datate: e quindi che se il rapporto con un genitore è causa di sofferenze continue non sia giusto sopportarlo solo perché la famiglia deve venire al primo posto. Così come è raccomandato interrompere una relazione di coppia quando non ci si sta più bene, anche se si teme che possa deludere i figli.
– Leggi anche: Qualsiasi cosa facciano gli altri, lasciali fare
Questa idea si è però diffusa al punto da essere applicata a volte indiscriminatamente, facendo passare il concetto che la felicità sia almeno in parte il risultato di una indipendenza emotiva e di un’autoindulgenza maggiori di quelle che saremmo portati a praticare. E che possa derivare sempre da una prioritaria attenzione a sé stessi e ai propri bisogni più che da tentativi faticosi e spesso infruttuosi di trovare un equilibrio e un compromesso tra i propri bisogni e quelli di altre persone.
La psicologa e psicoterapeuta americana Lindsay Gibson, per esempio, scrisse nel 2015 il libro di auto aiuto Figli adulti di genitori emotivamente immaturi, poi diventato uno dei più venduti del suo genere. Scrisse di aver preso spunto dalle conversazioni con suoi pazienti i cui familiari si comportavano come dei bambini, e di volere dimostrare a persone come quei suoi pazienti che la responsabilità di tutti i loro problemi non era loro.
È possibile che molti destinatari dei consigli di Gibson siano in effetti figli di «genitori distanti, respingenti o egocentrici», come dice il sottotitolo del libro. Ma è improbabile, anche solo statisticamente, che le persone che comprano il libro perché si rivedono in quel tipo umano abbiano tutte genitori immaturi. Così come non è detto che certi approcci concentrati sul sé siano adatti a individui che già di loro hanno una scarsa capacità di empatia verso le altre persone o fanno fatica a mettersi in discussione.
Su internet circola da tempo un meme che fa ironia su questo, che dice più o meno: «in questo momento la persona più egoriferita che conosci si sta sentendo dire dal proprio psicoterapeuta che deve pensare di più a sé stessa».
Il rischio principale di vari approcci psicoterapeutici o pseudoterapeutici molto concentrati sulla felicità individuale e promossi su larga scala, attraverso libri e social, è che consigli potenzialmente adatti a condizioni e casi umani specifici siano elevati da chi li riceve a consigli universali e validi in ogni circostanza. Interpretarli in modo radicale rischia di alimentare un culto dell’autosufficienza spesso impraticabile e controproducente, e che ha alla base un’idea di felicità molto riduttiva. Anche solo metterla sul piano della felicità, secondo alcuni specialisti, è una scelta discutibile.
«Credo che quello a cui dobbiamo ambire non sia tanto la felicità, quanto vivere una vita che sia il più gratificante possibile, nei limiti della situazione che ciascuno vive», dice Serena Borroni, docente di psicologia clinica all’Università Vita-Salute San Raffaele a Milano. Cita un aforisma attribuito a Sigmund Freud, secondo cui la sanità mentale è la capacità di amare e di lavorare: aforisma che secondo lei aiuta a mettere meglio a fuoco la questione e a capire quanto sia fondamentale per la salute mentale avere relazioni di reciprocità con altre persone.
La capacità di lavorare implica essere in grado di porsi degli obiettivi e di raggiungerli. Ha a che fare con le gratificazioni professionali e personali, e con l’avere un’identità e un’autostima solide e stabili: tutte cose che richiedono sia un riconoscimento del proprio lavoro da parte di altre persone, sia di riconoscere il lavoro altrui. La capacità di amare è la capacità stessa di avere delle relazioni con gli altri, il che implica considerare il punto di vista dell’altro. Una relazione sana è una relazione basata sulla reciprocità: «non una relazione che ho perché così soddisfo dei miei bisogni, o perché altrimenti mi sento perso o persa», dice Borroni.
Diversi libri di auto aiuto degli ultimi anni hanno titoli infantilmente egocentrici, come Il coraggio di non piacere o La sottile arte di fare quello che c***o ti pare. E a giudicare dal loro prolungato successo internazionale si direbbe che essere indulgenti con sé stessi o anche «un po’ stronzi», come ha scritto il New York Times, sia un consiglio sempre molto popolare e una scelta assolutamente accettabile, anche a costo di ignorare eventuali difficoltà delle altre persone.
– Leggi anche: Si può essere amici di uno stronzo?
Gli approcci basati sull’idea che l’autosufficienza produca benefici si scontrano però con la realtà clinica. Alimentare la tendenza a deresponsabilizzarsi e a colpevolizzare gli altri non è funzionale in ambito terapeutico, spiega Borroni. Concentrarsi sul sé e sul proprio passato ha senso se aiuta «a comprendere perché si attivino certe dinamiche relazionali o di altro tipo», non se portano a giudicare gli altri come responsabili di ciò che non funziona e a interrompere qualsiasi relazione nella convinzione illusoria che si starà meglio.
Inoltre, un conto è mettere in pratica i consigli letti in un libro di divulgazione, magari anche valido, e un conto è fare psicoterapia. Non è detto che una persona in grado di mettere in dubbio o in crisi il proprio rapporto con i genitori, per esempio, sia poi in grado di gestire da sola quella crisi.
L’ipotesi che pensare prima a sé stesse faccia stare meglio le persone è contraddetta anche dai risultati di diverse ricerche. Alcune di queste, condotte tra popolazioni diverse sia per cultura sia per reddito, mostrano per esempio che le persone che spendono soldi per gli altri tendono a essere più felici di quelle che li spendono per sé stesse. E questi benefici, oltre che dichiarati, sono osservabili anche sul piano neurofisiologico. Altre ricerche ipotizzano che il comportamento altruistico sia stato e sia un fattore evolutivo fondamentale alla base della cooperazione sociale.
– Leggi anche: Le persone per bene sono più felici
È infatti una questione che ha anche una dimensione politica e sociale. Mettere al centro i propri bisogni in ogni circostanza è un approccio che rischia di ridurre comportamenti orientati invece all’altruismo, alla solidarietà, al sacrificio e ai compromessi: comportamenti che, a parte far stare bene chi li mette in pratica, di fatto tengono unite le comunità.
La ricerca dell’indipendenza emotiva ha successo in culture perlopiù competitive e individualiste, che tendono a rimuovere la prospettiva altrui o a non ritenerla influente sulla propria felicità, anziché incentivare il singolo a trovare un significato nell’essere legato ad altre persone.
Come scrivono anche lo psicologo spagnolo Edgar Cabanas e la sociologa franco-israeliana Eva Illouz nel libro Happycracy, «la ricerca della felicità è uno dei “prodotti di esportazione” più tipici degli Stati Uniti, nonché uno dei principali obiettivi politici», diffuso e promosso da molti attori non politici (life coach, esperti e psicologi, ma anche imprenditori, celebrità e produttori cinematografici). Ma la convinzione che gli individui siano i soli responsabili del loro successo o della loro miseria è una prospettiva che si è diffusa molto anche in altri paesi occidentali.
Per loro «la felicità non andrebbe vista come un’astrazione innocua e benevola», o come una nozione scientifica esente da gravi pregiudizi culturali, morali e antropologici. Il rischio è non capire «perché proprio questo valore, e non per esempio la giustizia, la prudenza, la solidarietà o la lealtà, abbia finito per occupare un ruolo così preponderante nelle società del capitalismo neoliberista».
– Leggi anche: Dovremmo essere meno d’accordo con noi stessi