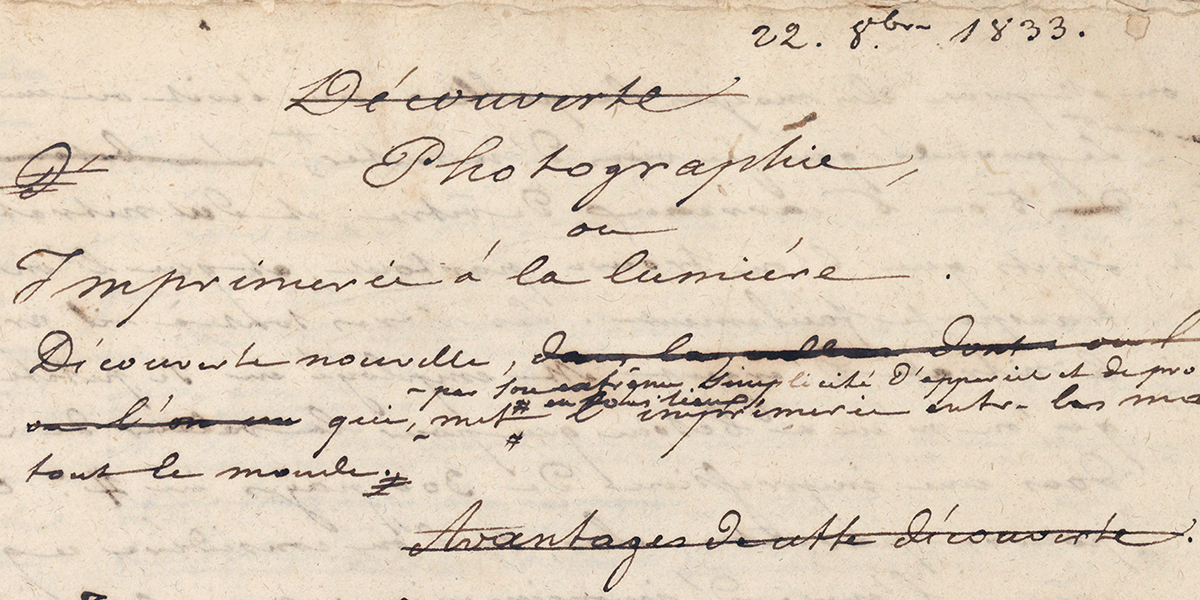Istruzioni per (non) cambiar vita
«Sono arrivata in Grecia senza conoscere nessuno, dopo aver fatto piroettare uno dei miei mappamondi. Quando è iniziata la pandemia, ero lì a disfare gli scatoloni, tutta contenta di non essere a Milano nel mio bilocale al quarto piano senza ascensore. Mi sentivo un po’ in colpa perché potevo scorrazzare nel verde. Il coprifuoco è stato un po’ una noia ma va be’. Non ho imparato a panificare, ho vissuto nutrendomi di patate al forno e pastasciutta. Appena arrivata mi sono detta: “Evviva, faccio l’orto, imparo tutto sui pistacchi”. Al secondo anno mi ero già stufata»

Quando mi sveglio e apro le finestre mi pare di essere caduta nel disegno di un bambino: il sole tondo che brilla, una grande striscia verde – pini di Aleppo e pistacchi persiani – una linea azzurra di mare, tanti uccellini in cielo – upupe e cicale in concerto. Mi devo ancora dare dei pizzicotti per assicurarmi che sia tutto vero perché quattro anni fa la mia finestra restava sempre chiusa visto che dava sui palazzi beige di un viale trafficato.
Da quando mi sono trasferita su un’isola greca molti sconosciuti mi scrivono (su Messenger, sul mio sito, via email) chiedendomi consigli su come cambiare vita: quali sono gli step necessari e gli ostacoli per aprire un conto in banca, trovare un notaio o un avvocato, quante tasse si pagano, come scegliere una casa, come si vive su un’isola, come si ci sente a svegliarsi tutti i giorni in mezzo all’Egeo o in qualsiasi altro luogo sperduto del mondo.
Per capire se questo salto nel buio fa per voi, la prima cosa è escludere che sia il classico colpo di testa tipo «basta, mollo tutto e me ne vado via» a cui hanno pensato in molti durante la pandemia. La seconda è prendere coscienza che se scrivete «Ehi, vorrei venire sulla tua isola, come si raggiunge?» già non va bene. Perché prima c’è Google. Oppure un libro del 1983, purtroppo mai tradotto in italiano (ehi, editori, eccomi!), che potrebbe essere utile a dissuadervi: Far out isn’t far enough di Tomi Ungerer, un designer e illustratore francese capace di pubblicare contemporaneamente albi per bambini, fumetti sovversivi contro la guerra e un libro per adulti intitolato Erotoscope. Far out isn’t far enough è una sorta di saggio fatto di appunti illustrati in cui Ungerer ricorda l’anno esilarante e complicato trascorso con sua moglie sulla selvaggia costa atlantica della Nuova Scozia, un oscuro lembo di Canada di cui sono descritte con arguzia le persone, le tradizioni curiose e le difficoltà incontrate fino alla decisione, presa dopo un anno, di tornare ai comfort del mondo urbano (esiste anche un bellissimo documentario con lo stesso titolo). Il classico sogno vs. realtà.
Quanto a me, sono arrivata in Grecia per la prima volta senza conoscere nessuno, così alla carlona, dopo aver fatto piroettare uno dei miei mappamondi ed essermi chiesta «dove posso andare per cambiare un po’ il panorama?». Sapendo che i colpi di testa mi piacciono un sacco, però, avevo chiesto agli amici più cari di monitorarmi. Anche perché quattro anni fa, a cinquant’anni esatti, ero in piena menopausa e quindi dovevo fare ancora più attenzione. È uno stato che la scrittrice Mary Ruefle, che proprio in quel periodo stavo traducendo per NN, descrive così:
In altre parole, impazzisci. Quando impazzisci non hai la minima propensione a leggere quello che Foucault ha scritto a proposito di cultura e pazzia […] Sei una tredicenne con l’esperienza e la vita quotidiana di una quarantacinquenne. […]
Potresti decidere di buttarti in un’impresa assurda e disperata. Tipo andare in Canada a piedi, o cominciare a collezionare porcellane antiche, tremila pezzi che ti lasceranno piena di debiti. All’improvviso ti sembra che la soluzione di tutti i problemi sia vendere l’orologio d’oro di tua nonna o bere tanto aceto di mele quanto pesi. Nelle vene ti scorre il sangue selvatico della foresta.
Mi sentivo proprio così, con la differenza che a me il sangue selvatico – della foresta o della megalopoli che è un po’ la stessa cosa a parte gli umani – scorreva nelle vene già da molto tempo. Ho sempre fatto fatica a stare ferma in un posto. Negli anni avevo fatto casa in parecchi paesi, anche se in un modo o nell’altro avevo sempre tenuto un piede in Italia (o meglio, un pied-à-terre o un garage o una stanza a casa di un fidanzato). Avevo abitato due anni in Scozia, uno a Londra, per molti inverni avevo vissuto a Bombay e Delhi, nell’India urbana, per un gran totale di otto anni e, dopo, in Asia – con la scusa di cercare libri da tradurre, cosa che in effetti ha funzionato –, poi un anno al Cairo, uno in Israele e molte stagioni tra New York e Upstate, intesa come parte settentrionale del medesimo stato USA.
Per tutte queste ragioni la mia decisione di trasferirmi in Grecia non poteva essere definita un colpo di testa. Diciamo che ero arrivata alla medaglia d’oro nelle olimpiadi imprevisti o disavventure. Avrei potuto scrivere il Manuale delle Giovani Marmotte per adulti. Gli ostacoli che avevo superato in vita mia includevano: come infilarsi in un bunker in caso di razzi (Tel Aviv), come vivere per mesi in una stanza con soltanto un letto e una sedia, e il bagno comune (il mio alberghetto di Bombay), come guidare nelle megalopoli («Atene è caotica!», mi dicono. A me sembra Ginevra), come evitare il panico in caso di blackout (accade molto spesso in India), come imparare a fare a meno di certi beni di lusso tipo la carta igienica (ovunque in Asia), come lavarsi con un solo secchio d’acqua (in Asia e in certe isole del Mediterraneo), come mantenere la calma in caso di bombe (Karachi, Pakistan), come convivere con topi di tutte le taglie. E il fatto che qui in Grecia ci siano soltanto topi di taglia media e formiche giganti rende tutto più semplice.
Mi rendo conto di sembrare una scapestrata, ma la verità è che bisogna studiare molto. Oggi che ho due case in Grecia mi sento una fazendera in Brasile, ma per arrivare a questo livello del videogame ho passato ore e ore a compulsare siti in italiano, inglese e francese per capire quali fossero gli ostacoli burocratici per un compratore straniero e soltanto quando avevo le idee chiare ho contattato un avvocato per porgli poche domande specifiche. Questo non significa, però, che occorra programmare tutto. Vista la mia passione per gli imprevisti, io per esempio non leggo le guide. Lascio fare molto al caso.
Da qualche punto, però, bisogna partire. La prima domanda potrebbe essere come si trovano gli interlocutori? E qui passiamo al livello delle relational skills che sono, banalmente, la capacità di parlare ed essere gentili con tutti, falegnami o filosofi, in qualsiasi lingua, specialmente quelle che non si conoscono. L’importante è fingere di capire e sorridere molto, e soprattutto imparare in fretta una serie di parole pronunciandole benissimo. Mal che vada, pensando a un rapido caffè, ti ritrovi a casa dei vicini ubriachi fradici e passi due ore davanti a montagne di carne alla griglia a chiederti cosa stanno dicendo. Mal che vada, nel tuo greco maccheronico, dici agli operai che stanno scartavetrando un montante, «bravi, ottimo lavoro, è tutto bello liscio», ma al posto di «liscio» dici una parolaccia orribile che ha solo un accento diverso, diventando lo zimbello dell’isola.
Per riuscire nelle relational skills è importante fidarsi e io ho grande fiducia negli esseri umani. Conosco quasi sempre persone molto simpatiche. Dopo un mese ad Atene, per esempio, sapevo i nomi di tutti i pusher della mia via, cosa utile non tanto per le droghe, ma per essere protetti anche nelle zone peggiori. La prima volta che ci sono arrivata avevo prenotato una camera a Exarcheia, una zona che mi sembrava abbastanza centrale, senza sapere che fosse un covo di anarchici, con lanci di molotov e cassonetti in fiamme (quattro anni dopo è piena di polizia e molto gentrificata). Avevo scelto una stanzetta frugale, perché quando viaggio devo stare in camere monastiche, se no non riesco a lavorare, ma con il balconcino per fumare.
Sono arrivata sul tardi una sera, ma non trovando gli occhiali non vedevo i numeri perché era tutto – tutto, non un centimetro libero – ricoperto di graffiti. Intorno a me intuivo la presenza di parecchi personaggi che non riuscivo a mettere a fuoco, ma che continuavano a chiedermi se volevo hashish e io continuavo a dire: «Scusi, buon uomo, mi sa dire dove è il numero 92 di Themistocleus?». Avrei scoperto soltanto il giorno dopo, grazie al sole, agli occhiali e al tizio che mi affittava la camera – un vispo e coltissimo 75enne che sarebbe diventato Zio Kostas – che i vari buon uomo erano scaltri pusher afgani, siriani e albanesi con cui avrei presto fatto amicizia, dopo aver spiegato che non posso drogarmi altrimenti svengo perché ho la pressione bassa. Quando succedeva qualcosa di fastidioso in zona, tipo risse o molotov, i pusher mi avvisavano – «Stai attenta, signorina Giogia» – ed era molto utile. Non conoscevo ancora nessuno a parte zio Kostas, ma quella città mi piaceva da pazzi. Mi ricordava la mia amata Bombay ma anche Il Cairo, e tantissimo Tel Aviv e Parigi in certe vie, e Istanbul ovviamente. Così ho deciso di dare un’occhiata all’immobiliare e tombola, costava tutto pochissimo.
Dopo aver studiato la burocrazia ho cominciato a vedere case, ma solo online. Centinaia, un’ora al mattino e una di sera, con metodo. Dopo tante megalopoli, però, avevo voglia di provare a vivere in campagna (dopotutto sono nata nelle tristi risaie del novarese, il panorama poteva solo migliorare). Su consiglio di Zio Kostas ho visitato l’isola di fronte ad Atene dove sua figlia gestiva la casa di famiglia. L’ho affittata per un mese, mi sono innamorata dell’isola, ho visto una casa a 70K e l’ho comprata. Così, di colpo, senza soldi. Come si fa a comprare una casa con mille euro in banca? Si fa un’ipoteca. Negli anni ho acceso mutui a gogo. La mia prima casa era a Torino, dove ero capitata per caso a 27 anni, orfana, ma con 15K di eredità, che per un traduttore erano una montagna di soldi. Fumavo tantissimo e non capivo niente di banche, ma mi ero buttata. Dopo otto anni l’ho rivenduta al doppio e ho comprato 50mq a Milano, zona Farini pre boom, che poi ho ipotecato e rivenduto al doppio etc. E così, a un certo punto mi sono ritrovata sull’isola in una casa vera e propria con mille metri quadri di terreno, ma da ristrutturare, a partire dal tetto.

Vista dall’isola di Aegina (Gioia Guerzoni)
Saper parlare con tutti ha fatto sì che in un minuto avessi amici e operai. Il fatto che mio padre facesse il valutatore e da piccola mi chiedesse – «Secondo te quanto vale questa sedia? Quanto costa al produttore una pizza? Quanto ci vuole per fare questo vaso di ceramica» – mi ha fatto sviluppare una buona capacità di valutare le cose, utile a non farsi infinocchiare quando si ricevono i preventivi. Per seguire i lavori ho affittato una stanza vicino a casa, pensando che, abituata all’India, sarebbe stato tutto semplicissimo. Andavo a controllare ogni giorno, facevo il cinema e fingevo di essere arrabbiata perché se mancavo un giorno facevano pasticci. Succede in tutto il mondo, lo so, ma di più nei paesi di mare o in Asia. Penso che trasferirsi a Berlino o a Losanna sia più semplice. D’altra parte in lingua hindi kal significa sia ieri che domani, e guarda caso kaal vuol dire sia tempo che morte. Insomma, bisogna essere pazienti e io, tranne che nella traduzione, sono la regina dell’impazienza (ma forse sarei diventata una pazza isterica senza tutti quegli anni passati ad attendere – treni persone cose – in Asia). Alla fine sono stata abbastanza fortunata e in pochi mesi ho avuto una casa con un tetto nuovo di tegole al posto dell’amianto e due bagni e un giardinone con i pini di Aleppo e i pistacchi della Persia e il caprifoglio e le arance amare.
Quando è iniziata la pandemia ero lì a disfare gli scatoloni, tutta contenta di non essere a Milano nel bilocale al quarto piano senza ascensore con vista su via Farini. Mi sentivo anche un po’ in colpa perché, pur non conoscendo molta gente e non potendo uscire dall’isola, potevo scorrazzare nel verde. Il coprifuoco è stato un po’ una noia ma va be’. Non ho imparato a panificare, ho vissuto nutrendomi di patate al forno e pastasciutta. Appena arrivata mi sono detta: «Evviva, faccio l’orto, imparo tutto sui pistacchi». Al secondo anno mi ero già stufata. Perché passare ore a innaffiare e togliere erbacce quando il verduriere mi vende ottimi pomodori e cetrioli a 1 euro al chilo? Le mie velleità da contadinella sono scemate in pochi mesi. Lo stesso per i pistacchi. Il primo anno, nelle date consigliate per tradizione, ho fatto un mini raccolto, li ho stesi a essiccare sulla terrazza con l’ansia che piovesse, li ho accuditi e portati a tostare. Dal secondo li ho comprati in paese. Vivere sull’isola in inverno richiede capacità di sopravvivenza notevoli oppure un ottimo sistema di riscaldamento, che non ho. Ho solo la stufa a legna. E non è facile. Così dopo due inverni pandemici ho venduto a Milano – tanto non ci torno di certo (non avere famiglia è un gran vantaggio nei trasferimenti) e poi la Grecia mi fa sentire a casa – e zac, in un batter d’occhio ho chiuso il mutuo ipotecario, visto cinque o sei appartamenti ad Atene e ne ho comprato uno minuscolo, ma con i termosifoni. Adesso potrei scrivere anche io nelle biografie «vive tra Atene e Aegina» (non lo faccio, eh).
Sono molto felice in Grecia, quando vado via mi manca, cosa che non mi era mai successa prima. Non è tutto rose e fiori, ouzo e grigliate, come sembra dalle mie allegre fotine su Instagram, ma è fattibile. Però bisogna partire da un livello intermedio, studiare, informarsi, non tampinare gli sconosciuti su Internet, buttarsi, rischiare. Lo scorso inverno, finalmente, con quattro anni di ritardo, sono salita all’Acropoli. Una delusione, anche se non c’erano turisti. Preferivo vederla da Filopappou, la collina vicino a casa. A volte è meglio osservare le cose da lontano, o leggerne, o vederle sfocate. La vecchia massima yiddish «Mann tracht un Gott lacht» mi è cara da sempre. «L’uomo pianifica, Dio ride».

Il tempio di Afaia sull’isola di Aegina in primavera (Gioia Guerzoni)