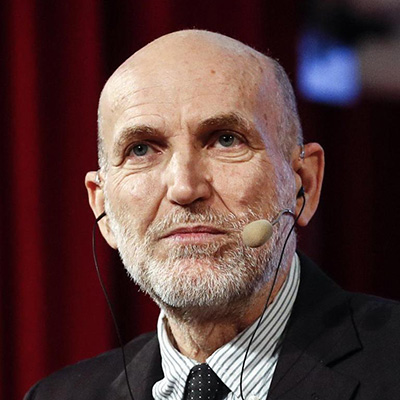La Resistenza delle persone
«Nella storia di una nazione non sono molti i momenti in cui ci si trova tutti insieme dentro un dramma che consuma vite in gran numero e per lungo tempo, cambia spazi e tempi di ogni esistenza, penetra nelle emozioni più intime fino ai sogni, altera le persone e le relazioni»

“Guarda che per uno nemmeno troppo giovane è come parlare della proclamazione del Regno d’Italia”, dice un amico. Eh sì, se in una assemblea del ’68 qualcuno andava a parlare di Vittorio Veneto finiva fischiato a prescindere, mica per pacifismo ma già perché se ne usciva con una storia di cinquanta anni prima. Ad alzare l’asticella della difficoltà è poi la pandemia, uno di quei traumi che spaccano il tempo, restringono gli orizzonti non solo fisici ma storici. La Resistenza sembra venire da un altro mondo, da un tempo di cose, idee e persone troppo diverse e lontane dal nostro presente, dai nostri sentimenti e dai nostri problemi.
A quasi ottanta anni dai venti mesi gloriosi in cui almeno una parte degli italiani scelse di resistere alla dittatura, alla deportazione, alla guerra, quell’epoca pare vitale solo per la sua capacità di suscitare polemiche, peraltro da tempo sempre uguali a se stesse. E se la situazione epidemiologica e politica, insieme allo schiacciamento sul presente di qualunque discussione e a un governo di quasi completa unità nazionale attenuano perfino la strumentale spirale di manipolazioni e semplificazioni, l’unico destino sembra il silenzio. Sul quale si depositano le celebrazioni più o meno retoriche che anch’esse sembrano proseguire per una sempre più pallida coazione a ripetere.
Se è possibile provare a rovesciare questo destino è invece proprio a partire dall’esperienza che stiamo vivendo, un trauma lungo che sembra non finire mai, che colpisce tutti, e tutti però in modo diverso, che genera idee e reazioni che cominciano irrimediabilmente a sfibrarsi e ci indeboliscono, come persone e come comunità, qualunque dimensione si attribuisca a questa parola.
Ogni paragone ha qualcosa di illecito, nessuna guerra è uguale a un’altra e una pandemia non è nemmeno una guerra. Ma nella storia di una nazione non sono molti i momenti in cui ci si trova tutti insieme dentro un dramma che consuma vite in gran numero e per lungo tempo, cambia spazi e tempi di ogni esistenza, penetra nelle emozioni più intime fino ai sogni, altera le persone e le relazioni. Ancor meno quelli in cui la reazione non è solo la soluzione o l’aggiustamento personale ma una qualche azione collettiva aperta e responsabile. Nella storia degli italiani ce n’è uno solo, di questi momenti, ed è la Resistenza. Alcune centinaia di migliaia di uomini e donne (i numeri ormai ci sono, si può almeno liquidare la misera polemica su quanti furono: non moltissimi ma abbastanza) in maniere e forme diverse, mettendo in gioco e rischiando la vita intera o qualcosa di meno fatale scelsero il modo giusto per affrontare il dramma collettivo. Che vuol dire il modo giusto? Quello che consentì tanto il riscatto individuale quanto la costruzione di una società migliore per tutti: la liberazione morale (e personale) e quella politica collettiva.
Perché fu possibile? Perché ciascuno mise dentro quella lotta se stesso com’era e come poteva diventare. Se c’è qualcosa di prezioso nei progetti che fanno parlare italiani e italiane di allora (l’ultimo e più ampio, destinato a “chiunque abbia dato il suo contributo, piccolo o grande, alla lotta di Liberazione nei venti terribili mesi che vanno dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945”, ha appena generato una piattaforma con 150 interviste che diventeranno 500 prima dell’estate) è che consentono di accedere alla infinita diversità delle storie e delle motivazioni. Si arrivava a combattere per destino personale o familiare, come antifascisti o figli di perseguitati da sempre, oppure per una conversione improvvisa, che di colpo rompeva con tutto quello che si era stati e in cui si aveva creduto: la famiglia, la fede, l’educazione. Si arrivava con la gioia di liberarsi o con il dolore di vendicarsi, con l’orgoglio di prendere in mano il proprio destino o con la disperazione di chi non ha alternative. Per ragioni diverse e diversamente alte: come scrisse a 28 anni il partigiano Emanuele Artom, “siamo quello che siamo: un complesso di individui in parte disinteressati e in buona fede, in parte arrivisti politici, in parte soldati sbandati che temono la deportazione in Germania, in parte spinti dal desiderio di avventura, in parte da quello di rapina. Gli uomini sono uomini. Bisogna cercare di renderli migliori e a questo scopo per prima cosa giudicarli con spregiudicato e indulgente pessimismo” (Questo disincantato realismo non impedì a Emanuele Artom di fare la sua parte, per la quale, catturato dai fascisti e consegnato ai tedeschi, fu straziato e ucciso il 7 aprile del 1944).
Queste motivazioni comuni non indeboliscono l’immagine della Resistenza ma ne esaltano l’umanità. Restituiscono la sua verità di fenomeno complesso, tutt’altro che compatto ma pieno di diversità e di contraddizioni (una dimensione raccontata molto bene in un libro recente, utile anche come sintetica ricostruzione generale) e lo strappano a qualunque mitizzazione. Evitano che diventi qualcosa di inaccessibile, quasi di inconcepibile. Non lo fu: fu una esperienza coraggiosa e in qualche caso eroica di uomini e donne comuni. La cui generosità si esercitò in primo luogo verso se stessi: darsi la possibilità di non subire, di agire, di trasformarsi e di trasformare. La vera violenza della Resistenza fu la radicalità che i partigiani imposero a se stessi e poi a una intera nazione. Di fronte a eventi così giganteschi non ci si può nascondere e contare sulle piccole certezze e le grandi falsità vigenti, fino ad allora accettate o che si è contribuito a perpetuare. Un esempio lontano dai campi di battaglia ma non meno netto è la Costituzione, la nostra famosa “Costituzione nata dalla Resistenza” come recita un mantra che rischia anch’esso di generare assuefazione e indifferenza. Da dove vengono i valori della Costituzione? Ma ancora prima, da dove vengono le sue parole, quella lingua lucida e luminosa ma sobria, del tutto priva di enfasi, smisuratamente lontana dalla veemenza magniloquente cui erano state educate generazioni intere? (quelle stesse destinate a scrivere o almeno a leggere e attuare quelle parole) Solo la profondità e la disponibilità a una grande trasformazione genera una lingua così nuova. Solo cambiando molto si possono cambiare così molte parole.
Assunzione di responsabilità, ricerca della verità, necessità della trasformazione sono le sfide che una generazione si è trovata di fronte quasi ottanta anni fa. Sono lontane e imparagonabili ma così diverse dalle sfide che stiamo affrontando più o meno consapevolmente in questo nostro tempo? Dimenticando la Resistenza perdiamo troppo. Non solo quel filo di impegno e di riconoscenza che non rende inutile il sacrificio di molte e molti ma l’eredità che ci lascia meno soli. Non come esempio impossibile da imitare (una vittoria impossibile da infangare e, ahimè, da replicare), ma come una esperienza che è stata di tante e tanti, simili a quelli che siamo o potremmo essere. Senza liquidarla con indifferenza e distrazione chiamandola antica, inaccessibile, inattuale.