La solitudine di Edward Hopper
Raccontata da Olivia Laing, che ha scritto un libro sulle storie di artisti, musicisti e fotografi alle prese con l'isolamento e l'abbandono

La solitudine è qualcosa che tutti proviamo prima o poi, finendo per impantanarvici tristemente, fuggire con terrore, rimpiangerla, inseguirla con sollievo. Olivia Laing, scrittrice e critica culturale britannica di 41 anni, ci ha scritto un intero libro, Città sola, dove a partire da un momento solitario e infelice della sua vita esplora le solitudini di artisti, scrittori e musicisti, nella vita e nelle opere, e di come le hanno rappresentate, sofferte e combattute nell’affollatissima New York.
Ci sono quelle di Andy Warhol e di Valerie Solanas, la scrittrice femminista che gli sparò; quella dell’artista David Wojnarowicz che la placava nel sesso con gli sconosciuti ai moli di New York; della fotografa Nan Goldin e delle immagini dei suoi amici che si baciano e si bucano; del pittore Henry Darger, isolato in una vita ordinaria in cui dipingeva bambini torturati. Il primo a essere raccontato è Edward Hopper, il pittore della solitudine americana, con le sue figure desolate e assenti, come nella sua opera più famosa, I Nottambuli, di cui Laing parla a lungo per spiegarne il fascino, come potete leggere nell’estratto che segue.
Città sola è stato pubblicato in Regno Unito nel 2016 col titolo The Lonely City; in Italia è uscito da poco per il Saggiatore.
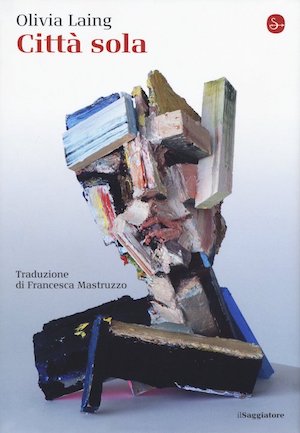
***
Cos’ha di speciale Hopper? Ogni tanto appare un artista che dà voce a un’esperienza, non per forza in maniera conscia o voluta, e lo fa con una tale prescienza e intensità che li si associa per sempre. Hopper non amava che le sue opere fossero inquadrate in un certo senso o che il tema della solitudine fosse considerato la sua specialità, l’asse portante della sua arte. «Questa storia della solitudine è esagerata» dice all’amico Brian O’Doherty in una delle pochissime interviste di una certa lunghezza che abbia mai concesso. E ancora, nel documentario Hopper’s Silence, alla domanda di O’Doherty «I tuoi quadri riflettono l’isolamento della vita moderna?», Hopper, dopo una pausa, risponde laconicamente: «Forse sì. O forse no». Più avanti, quando gli chiedono cosa lo porta a dipingere le tetre scene da lui predilette, dice sibillino: «Deve essere una cosa mia».
Allora perché insistiamo ad associare la solitudine alle sue opere? La risposta più ovvia è che i quadri di Hopper sono generalmente popolati da persone sole, raffigurate al massimo in gruppi di due o tre individui che emanano disagio e incomunicabilità, imbrigliati in pose sofferenti. Ma c’è qualcos’altro, ed è il modo in cui concepisce quei paesaggi urbani. Come osserva il curatore del Whitney Museum Carter Foster nel libro Hopper’s Drawings, Hopper riproduce costantemente «certi spazi ed esperienze spaziali tipici di New York, dove si osserva tra le persone una vicinanza sica e allo stesso tempo una separazione, dovuta a diversi fattori tra cui il movimento, le strutture, le finestre, i muri, la luce o il buio». Questo punto di vista viene spesso descritto come voyeuristico, ma le scene urbane di Hopper riproducono anche uno degli aspetti principali della solitudine: il senso di separazione – di essere murati dentro o fuori – si combina con un senso di esposizione quasi intollerabile.
Questa tensione si rintraccia anche nei quadri newyorkesi più clementi, quelli che rappresentano una solitudine più piacevole e rasserenante. Mattino in città (Morning in a City), per esempio, dove troviamo una donna nuda in piedi alla finestra con un telo di spugna in mano, rilassata e in pace con se stessa, il corpo dipinto da delicate pennellate color lavanda, rosa e verde chiaro. Un’espressione di quiete, eppure si distingue un impercettibile fremito di disagio sul lato sinistro, là dove la cornice della finestra aperta cede spazio agli edifici all’esterno, e effusi del rosa tenue del cielo mattutino. Nel palazzo di fronte si vedono altre tre finestre, con le tapparelle verdi mezze alzate, gli interni solo dei quadrati nero pece. Se le finestre sono da considerarsi gli equivalenti degli occhi, come suggeriscono sia la funzione che l’etimologia inglese (window viene da wind-eye, «occhio per l’aria»), allora questa ostruzione, questo grumo di pittura, esprime l’incertezza di essere visti – forse di richiamare lo sguardo, ma anche di allontanarlo, ovvero di essere ignorati, inosservati, trascurati, tralasciati, rifiutati.
Nel sinistro Finestre di notte (Night Windows) queste preoccupazioni sfociano in un’intensa inquietudine. Il dipinto raffigura un piano alto di un palazzo, con tre aperture, tre squarci, che danno su una stanza illuminata. Dalla prima finestra una tenda si gonfia verso l’esterno, nella seconda una donna con una sottoveste nei toni del rosa si piega, le anche contratte, su un tappeto verde. Nella terza una lampada risplende attraverso un pezzo di stoffa, anche se l’effetto è quello di un incendio.
Si nota qualcosa di strano anche nella prospettiva, che è chiaramente dall’alto – vediamo il pavimento, ma non il soffitto –, però a giudicare dalle finestre siamo almeno al secondo piano, quindi l’osservatore, chiunque sia, si dovrebbe trovare sospeso in aria. La spiegazione più verosimile è che stia guardando dal finestrino del treno sopraelevato che Hopper amava prendere di notte, armato di taccuino e di matita a carboncino fatta in casa, per spiare avidamente dietro i vetri alla ricerca di lampi di luce, momenti che si fissassero, incompleti, nell’occhio della mente. In ogni caso, lo spettatore – cioè io e voi – viene cooptato in questo atto di straniamento. La sua privacy è stata violata, ma ciò non rende la donna meno sola, esposta nella sua camera ardente.
Ecco cosa caratterizza le città, il fatto che anche al chiuso si è sempre alla mercé dello sguardo altrui. Comunque mi muovessi – in andirivieni dal letto al divano, in giro per la cucina a esaminare le confezioni di gelato dimenticate in freezer – potevo essere vista da chi abitava nell’Arlington, il gigantesco complesso in stile regina Anna che dominava il panorama, coi suoi dieci piani di mattoni rinchiusi nei ponteggi. Potevo interpretare anch’io la parte dell’osservatore, come nel film La finestra sul cortile, e spiare decine di persone con cui non avrei mai scambiato una parola, ognuna presa dalle proprie piccole faccende private. Caricare la lavastoviglie senza niente addosso, staccheggiare in cucina per preparare la cena per i figli.
In circostanze normali non credo che tutto ciò mi avrebbe suscitato più di una pigra curiosità, ma quello non era un autunno normale. Fin quasi dal mio arrivo, avevo sentito crescere una certa ansia attorno alla faccenda della visibilità. Volevo essere vista, compresa e accettata, come succede quando incontriamo lo sguardo d’approvazione di un amante. Mi sentivo al contempo pericolosamente esposta, timorosa delle critiche, soprattutto nelle situazioni in cui essere soli sembrava poco appropriato, se non sbagliato, per esempio quando ero circondata da coppie o gruppi. Sensazioni che erano di certo ingigantite dal fatto di trovarmi a New York per la prima volta – città di vetro, di sguardi avidi – ma che nascevano dalla solitudine, la quale muove sempre in due direzioni, verso l’intimità e a debita distanza dalle minacce.
Quell’autunno continuavo a tornare ai quadri di Hopper, attratta da loro come se fossero stati piani di evasione e io una prigioniera; come se contenessero qualche indizio vitale sulla mia condizione. I miei occhi visitavano dozzine di stanze, ma tornavo sempre nello stesso posto: il ristorante newyorkese dei Nottambuli (Nighthawks), un dipinto che Joyce Carol Oates definisce «l’immagine romantica della solitudine americana più toccante e più riprodotta».

I Nottambuli a una retrospettiva su Edward Hopper a Colonia, in Germania, nel 2004
(AP Photo/Frank Augstein)
Devono essere ormai pochi gli occidentali che non hanno mai ammirato quella fredda ghiacciaia verdastra che è I nottambuli, o che non ne hanno visto almeno una lercia copia nella sala d’attesa di un medico o in un ufficio. È stato fatto oggetto di una diffusione così indiscriminata da aver ormai acquisito quella patina che affigge gli oggetti troppo familiari, simile allo sporco su di una lente, eppure conserva il suo potere disturbante, la sua forza.
L’ho guardato per anni sullo schermo di un portatile prima di vederlo di persona, al Whitney Museum, in un afoso pomeriggio di ottobre. Eccolo in fondo alla sala, coperto da un banco fluttuante di visitatori. «I colori sono fantastici» dice una ragazza, e mi ritrovo improvvisamente spinta davanti alla folla. Da vicino, il dipinto cambia forma, scomponendosi in anomalie e smagliature che non avevo mai visto prima. Il triangolo luminoso del soffitto si incrina. Tra gli scalda-caffè cola una lunga linea gialla. La pittura è sottilissima e non copre completamente la tela, la superficie è violata da una profusione di impercettibili spilli e minuscoli li bianchi.
Faccio un passo indietro. Sulla strada ricadono ombre verdi a forma di guglie e diamanti. Non esiste colore capace di comunicare in modo così potente l’alienazione urbana, l’atomizzazione degli esseri umani all’interno degli edifici da loro stessi creati, come questo verdino tossico, che non esisteva prima dell’avvento dell’elettricità, e che è associato indissolubilmente alla città di notte, la città delle torri di vetro, degli uffici vuoti illuminati e delle insegne al neon.
Arriva una guida turistica, i capelli scuri in una crocchia sulla te-sta, con un gruppo di visitatori al suo seguito. Indica il dipinto: «Notate che non c’è la porta?» e tutti la attorniano, mugugnando delle esclamazioni. Ha ragione. La tavola calda è un rifugio, sì, ma non si vede un ingresso, nessun modo per entrare o uscire. Su una parete in fondo si distingue una vivace porta color ocra che conduce forse in una cucina sudicia. Ma dal lato della strada la stanza è sigillata: un acquario urbano, una cella di vetro.
E dentro, nella loro livida prigione gialla, i quattro famosi personaggi. Una coppia equivoca, un barista in uniforme bianca, i capelli biondi tirati dentro un berretto, e un uomo seduto con le spalle alla finestra, la mezzaluna della tasca della sua giacca è il punto più scuro della tela. Nessuno parla. Nessuno guarda gli altri. La tavola calda è un rifugio per chi è solo, un luogo di soccorso, o illustra la disconnessione che prolifera nelle città? La genialità del dipinto sta nella sua instabilità, nel suo rifiuto di sbilanciarsi.
Osservate per esempio il barista, il suo viso forse a abile, forse freddo. Si trova al centro di una serie di triangoli, dove presiede al rito notturno del caffè. Ma non è anche lui intrappolato? Uno dei vertici del bancone è fuori dalla tela, ma è chiaro che si restringe troppo bruscamente, senza lasciare spazio per la ribaltina di passaggio che ci si aspetterebbe. È questo il sottile turbamento geometrico in cui Hopper eccelleva e che usava per accendere l’emozione dello spettatore, per produrre sensazioni di intrappolamento e circospezione, di profondo disagio.
Cos’altro? Mi appoggio al muro, sudata nei miei sandali, studiando ogni elemento della tavola calda. Tre tazze da caffè bianche, due bicchieri vuoti bordati di blu, due porta-tovaglioli, tre saliere, una pepaiola, dello zucchero forse, o ketchup. Luce gialla che si allarga sul soffitto. Livide tessere verdi («brillanti pennellate verde giada» le definì la moglie di Hopper, Jo, sul quaderno in cui catalogava i suoi quadri), lievi ombre triangolari a pioggia, il colore di una banconota da un dollaro. Sul tetto, l’insegna pubblicitaria dei sigari Phillies, la scritta «Only 5cs», delineata con un tratto beigiolino. Sull’altro lato della strada, un registratore di cassa verde dentro un negozio, la vetrina vuota. Verde su verde, vetro su vetro, uno stato d’animo inquieto che più restavo lì e più si espandeva.
La finestra è la cosa più strana: una bolla di vetro che separa il ristorante dalla strada, ripiegandosi sinuosamente su se stessa. Un caso isolato nell’opera di Hopper. Avrà dipinto centinaia, forse migliaia, di finestre nella sua vita, ma di solito si tratta di semplici aperture, spiragli che lo sguardo può attraversare. Alcune magari catturano i riflessi, ma questa è l’unica circostanza in cui Hopper ha dipinto il vetro, in tutta la sua ambigua fisicità. Solido e trasparente, materiale ed effimero, il vetro riunisce ciò che Hopper ha disseminato altrove in elementi singoli, fondendo in un unico simbolo sconvolgente i meccanismi inscindibili del confinamento e dell’esposizione. Impossibile guardare l’interno luminoso della tavola calda senza avvertire un’improvvisa paura della solitudine, di come ci si deve sentire a essere tagliati fuori, lì da soli, sotto l’aria condizionata.
(© Olivia Laing, 2016
© il Saggiatore S.r.l., Milano 2018)



