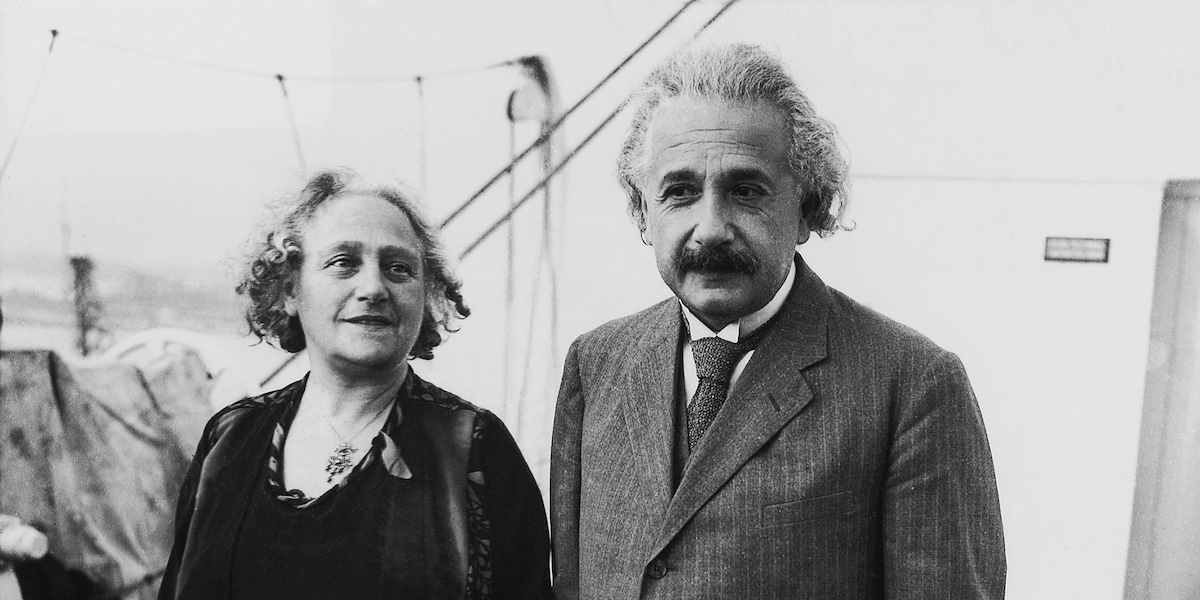Cosa dice la Costituzione sul matrimonio
E anche cosa dicono il codice civile e la Corte Costituzionale nella sentenza di cui si parla in questi giorni: le basi per una discussione informata, insomma

Da giorni si parla della proposta di legge sulle unioni civili che inizierà a essere discussa il prossimo 28 gennaio. Sono state scritte molte cose, che hanno a che fare con la Costituzione e diverse sentenze della Corte Costituzionale, ma non sempre esatte o precise. Il punto di partenza di ogni discussione giuridica dovrebbe essere: né la Costituzione né il codice civile – che comunque possono essere modificati, con modalità diverse – al momento definiscono il matrimonio.
Costituzione
La Costituzione parla di matrimonio all’articolo 29. Dice:
«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».
Si parla di matrimonio in modo neutro: si citano la «famiglia» e i «coniugi» senza però specificarne il sesso.
Codice civile
Nel diritto italiano il termine matrimonio è usato sia per indicare l’atto stesso del matrimonio che il rapporto che ne consegue. È un “negozio giuridico” regolato dagli articoli 79-230 del Titolo VI del Primo Libro Codice Civile intitolato “Delle persone e della famiglia” e specifica i requisiti per sposarsi e i vari impedimenti. Il codice civile non indica espressamente la differenza di sesso tra i requisiti per contrarre il matrimonio (né dice che un impedimento al matrimonio è lo stesso sesso dei contraenti) e per gran parte degli articoli si parla genericamente di “coniugi” e “sposi”, ma diverse norme – gli articoli 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis – citano il “marito” e la “moglie” come attori della celebrazione:
«Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio».
«La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione».
«Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
«La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».
«Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio».
Corte Costituzionale
Qualche giorno fa un articolo su Repubblica di Claudio Tito diceva che uno degli argomenti di chi si oppone alla legge è che una parte del ddl Cirinnà rischierebbe di essere incompatibile con una sentenza della Consulta e che di conseguenza, se approvata così com’è, la legge rischierebbe di non essere firmata dal presidente della Repubblica o di essere bocciata dalla stessa Corte Costituzionale a seguito di un eventuale ricorso. La pronuncia della Corte Costituzionale è la 138 del 2010: il ricorso era stato presentato da due uomini contro il rifiuto di un ufficiale di stato civile del comune di Venezia di procedere alla loro pubblicazione di matrimonio. Il funzionario aveva ritenuto illegittima la pubblicazione perché in contrasto con la normativa vigente, dato che l’istituto del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano «è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi».
La Corte Costituzionale ha sostanzialmente dato ragione al funzionario e respinto il ricorso della coppia: fa un esplicito richiamo al codice civile e dice che nonostante «i concetti di famiglia e di matrimonio» non si possano «ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali», l’interpretazione di tali concetti «non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata». E ancora:
«La questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.
Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.
Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto».
In un passaggio della sentenza si dice anche che nella nozione di “formazione sociale”, intesa come comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, va certamente inclusa anche l’unione omosessuale, intesa «come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri». E si dice anche che «spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali». Riassumendo: la sentenza dice che non c’è alcun limite, ostacolo o prescrizione nella Costituzione, ma che la decisione relativa alle unioni fra persone dello stesso sesso dipende interamente dalla volontà del legislatore. A questa decisione si richiama esplicitamente anche un’altra sentenza, più recente, del 2015.
Il Parlamento può insomma legiferare sulle unioni civili e i matrimoni gay modificando le norme che serve modificare, nelle leggi e nel codice civile, senza timori di incostituzionalità. Stefano Rodotà scrive oggi sulla prima pagina di Repubblica che la sentenza del 2010 della Corte Costituzionale è «discutibile e discussa», che quell’interpretazione «dovrebbe essere seriamente riconsiderata a partire dal nuovo contesto istituzionale europeo» e che una sentenza della Cassazione non è in ogni caso «un baluardo inespugnabile»:
«Non posso intervenire perché avrei bisogno di una legge costituzionale. Non posso intervenire perché devo ancora considerare il codice civile come un riferimento ineludibile. Non posso muovermi nel nuovo contesto costruito dai principi e dalle regole europee. Non posso intervenire perché l’opportunità politica variamente mascherata me lo preclude. Nessuno di questi argomenti regge».