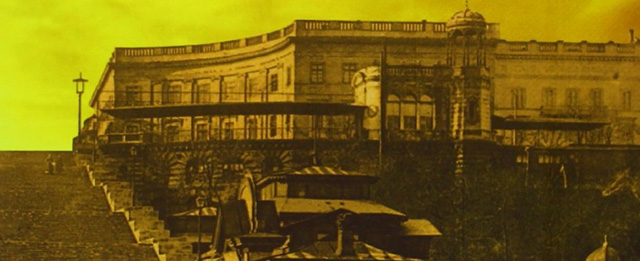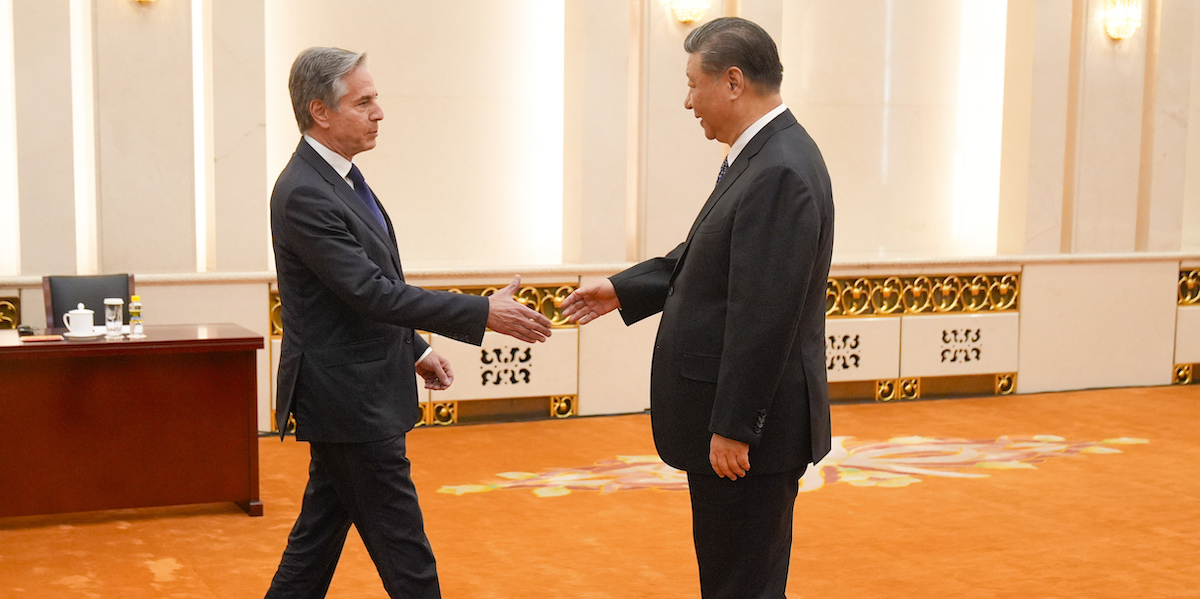La patria Odessa
La città da cui sta passando ancora una volta un pezzo di storia del mondo, descritta e raccontata in un bel libro uscito subito prima che le cose precipitassero
Einaudi ha pubblicato alla fine del 2013 un affascinante libro dedicato alla storia di Odessa, la città dell’Ucraina tornata protagonista delle vicende mondiali con la secessione della Crimea e gli scontri tra filo-russi e filo-ucraini nel marzo e nell’aprile del 2014. L’autore del libro (che si chiama semplicemente Odessa ed è uscito negli Stati Uniti nel 2011) è l’esperto di geopolitica e di Europa Orientale Charles King, che insegna alla Georgetown University.
Quando, alla fine dell’estate del 1867, Mark Twain visitò Odessa, ebbe subito l’impressione di essere a casa.
Aveva fatto scalo nel celebre porto russo durante quella che si può definire la prima crociera di piacere intorno al mondo, un viaggio nel Medio Oriente, che in seguito raccontò nel suo libro Gli innocenti all’estero. Dopo un giro di ventiquattr’ore intorno al Mar Nero sul battello a vapore americano Quaker City, Mark Twain scese a riva per visitare la cascata di gradini di pietra di Odessa – una delle scalinate piú famose al mondo – che, dal bacino portuale, conduce alla città alta. Una volta in cima, come ogni altro visitatore intento ad ammirare il panorama del porto, incappò nella piccola statua del duca di Richelieu, uno dei primi monumenti della città, che sembrava tendergli la mano accennando a un saluto. Mark Twain si diresse verso le colline e contemplò i silos di grano e il molo in lontananza. Dietro di lui, sorgeva il centro della città, immerso nell’incessante ronzio delle mille attività di scambio, commercio e navigazione.
Ampie strade ben tenute si incrociavano ad angolo retto. Casette basse di due o tre piani costeggiavano i viali. Facciate disadorne intonacate di giallo e azzurro riflettevano la luce del sole che, dalle acque immobili del Mar Nero, si diffondeva verso la riva. I rami delle acacie si protendevano sopra i marciapiedi brulicanti di gente intenta a godersi l’aria estiva, mentre nuvoloni di polvere si sollevavano al passaggio delle carrozze. «Guardatevi intorno, in alto o in basso, da una parte o dall’altra, – scrisse Twain, – vedrete solo una copia dell’America!».
Era un modo strano di vedere le cose. Mark Twain si trovava in una città fondata da un mercenario napoletano, battezzata da un’imperatrice, governata dal marito segreto di lei, costruita da due nobili francesi in esilio, modernizzata da un conte educato a Cambridge e celebrata dall’amante russo della moglie di quest’ultimo. Era una delle piú grandi città russe e il porto commerciale piú importante dell’Impero, anche se si trovava piú vicino a Vienna e ad Atene che a Mosca e a San Pietroburgo. Almeno per un quarto, la popolazione era costituita da ebrei.
Non molto tempo dopo il viaggio di Mark Twain, la città fu testimone di uno dei piú terribili episodi di violenza antisemita della storia della Russia. Gli ebrei furono massacrati per strada, in continue esplosioni di odio e di terrore incontrollati. In seguito, in un capitolo dimenticato dell’Olocausto, la comunità ebraica di Odessa (che a quell’epoca costituiva un terzo della popolazione) fu annientata dal piú radicale programma di distruzione bellica perpetrato da un paese che non era la Germania nazista, e cioè la Romania, alleata del Terzo Reich. Ciò che Mark Twain aveva percepito nelle strade e nei cortili di Odessa era la straordinaria capacità di unificare nazionalità diverse e di ricreare in tal senso la propria identità, generazione dopo generazione, proprio come succedeva nella sua patria americana. Quello che invece non era riuscito a vedere era la tendenza della città a immergersi con agghiacciante regolarità nel precipizio dell’autodistruzione.
All’epoca della sua visita, Odessa stava ancora cercando di sviluppare la sua peculiare fisionomia, che i sostenitori caldeggiavano e che invece i detrattori svilivano: un gusto per l’arguto e per l’assurdo, una patina di cultura russa applicata alle tradizioni yiddish, greca e italiana, un’economia caratterizzata da continui alti e bassi, una passione per la figura del dandy negli uomini e per la fanciulla spregiudicata nelle donne, uno stile nella musica e nella scrittura che associava l’abbandono di tipo libertino alla sperimentazione ben controllata e un modo di abbordare la politica che oscillava con audacia dalle posizioni piú
Molti di questi valori e di queste abitudini finirono per essere assorbiti dai nuovi locali che fiorivano un po’ ovunque, dai club di jazz di Leningrado ai saloni per banchetti dei borschtbelt delle montagne Catskillso di Brighton Beach. Rispetto ai quattro stati che l’avevano governata – l’Impero russo, l’Unione Sovietica, la Romania (come potenza occupante) e ora l’Ucraina – Odessa si era distinta per il suo carattere unico di città cosmopolita e multicolore, uno sfaccettato microcosmo arroccato tra il mare e la steppa e tuttavia minacciato dalla sua stessa policroma personalità. «Odessa non possedeva una sua tradizione, ma non aveva timore di sperimentare nuove forme di vita e nuove attività», rammenta Vladimir Jabotinskij, attivista sionista nativo della città. «Questa condizione ci ha permesso di sviluppare piú temperamento e meno passione, piú cinismo forse, ma meno amarezza».
A partire dalla sua fondazione, nel 1794, fino a oggi, Odessa ha lottato per sopravvivere tra i due opposti poli del successo e dell’autodistruzione. Come molte altre vivaci città portuali e come molti tessuti urbani multiculturali, essa ha sempre liberato i suoi demoni piú vitali, quegli spiritelli che incarnano le muse palpitanti della società metropolitana e i creatori instancabili dell’arte e della letteratura. Spesso, tuttavia, ha lasciato emergere anche i lati piú oscuri, quelli che stanno in agguato nei vicoli e bisbigliano parole di odio religioso, invidia di classe e vendetta etnica. Quando tutto andava per il meglio, Odessa era in grado di formare artisti e intellettuali il cui talento seppe illuminare il mondo. Quando invece tutto crollava, il nome della città divenne sinonimo di fanatismo, antisemitismo e bieco nazionalismo.
***
I visitatori non arrivano a Odessa nel vero senso della parola, ci capitano quasi di sorpresa. Dal lato terra, la città si staglia all’improvviso sull’immensa steppa pontica, un’antica prateria ora disseminata di fattorie ucraine e di detriti dell’agricoltura industriale sovietica. Finché non ci si entra direttamente, la città è nascosta da un lieve incresparsi nel paesaggio, costituito da alvei di torrenti asciutti e da gole che finiscono in mare. «Qui sono le steppe, e un passo piú oltre è la città», scriveva un viaggiatore tedesco piú di un secolo fa. «Si crederebbe che essa giaccia interamente segregata dal suo circondario, né abbia alcuna influenza su ciò che le è attorno».
Dal mare invece Odessa sorge in cima a una catena di basse scogliere e il suo centro appare visibile soltanto quando la nave doppia il promontorio che nasconde la baia. La periferia è disseminata da blocchi di alti caseggiati, ma non c’è traccia della città vecchia, per lo meno finché la nave non dirige la prua verso il piccolo faro sul molo. «Una volta di piú ecco apparire l’Europa», cosí disse un visitatore francese nel 1840, quando vide comparire le sagome dei palazzi che si stagliavano contro il cielo. Si ritrova lo stesso sentimento in tutte le descrizioni della città, che siano di osservatori stranieri o locali. I tetti bassi e gli alberi piegati dal vento preannunciavano una città di sogno, che sembrava sorgere dal nulla, uno strano lampeggiare sull’orizzonte vuoto formato da steppa, mare e cielo.
Il modo migliore per giungere a Odessa è via mare, come fecero i primi visitatori che hanno lasciato traccia del loro passaggio sul Mar Nero, gli antichi greci. La costa appare alla vista quasi di nascosto, con un basso crinale di scogliere di calcare grigiastro che, nella piena luce del giorno, assumono in certi punti tenui sfumature arancioni e perfino rosa. Sicuramente fu un panorama mozzafiato per i navigatori che provenivano dall’Egeo e che, per giorni, avevano scrutato un orizzonte piatto in cui si susseguivano pianure ondeggianti e flutti increspati, indistinguibili le une dagli altri. Ancora oggi è un paesaggio straordinario. Dal mare aperto blu cupo, si apre l’ampia baia azzurrina, circondata da promontori frastagliati e scoscesi che si innalzano sopra il litorale per piú di una trentina di metri.
In alcuni punti, la costa del Mar Nero si muta in erti picchi alpini ricoperti di boschi che sembrano cadere verticalmente sul mare. In altri tratti invece si trasforma all’improvviso in sterminate scogliere di calcare, dove le onde nerastre lambiscono fragorosamente le muraglie di pietra grigioverdi. Intorno a Odessa, invece, sul lato a nord-ovest, il mare non bagna la terra, ma la completa. Il litorale piatto si infila sinuosamente nei bassi fondali salmastri. La distesa marina, di tanto in tanto soffocata dalle alghe, rappresenta l’ideale continuazione della steppa: un tempo era una prateria sconfinata la cui vegetazione era costituita esclusivamente dalla stipa ucrainica e dalla festuca, oggi si presenta allo sguardo con ordinate strisce di terra arate e coltivate, un collage di pezze brune e nere.
Nell’antichità le scogliere della moderna Odessa forse sono state oggetto di ammirazione, ma nessuno ne ha lasciato traccia scritta. Sicuramente la sua immensa baia era nota agli antichi, ma nessuno dei documenti di cui disponiamo fa menzione di insediamenti a lungo termine su questo lembo di terra. Altre città moderne sul Mar Nero e nei dintorni – il sudicio porto di Costanza in Romania, la leggendaria Sebastopoli, oppure il gioiello del Mar Nero, Istanbul – posseggono tutte un pedigree antico. Sotto il cemento e l’asfalto di oggi, giacciono rovine greche, romane e bizantine. Odessa invece non possiede nulla di tutto ciò. Oltre alla baia aperta agli aspri venti da nord-ovest, il luogo ha ben poco da offrire. Quando si guarda la città da una nave da crociera o dal traghetto, si vede una creazione recente, un luogo che per duecento anni si è vantato di non avere storia, ma lo ha anche amaramente rimpianto.
***
Odessa sotto molti aspetti è una città crepuscolare, che con un certo disagio sorge in una nazione nuova e ha piú facilità a vendere il suo lontano passato che a presentarsi come città del futuro. Ma per piú di due secoli è riuscita a produrre una cultura locale profondamente pervasa di malessere, uno stile di vita che potrebbe dare una lezione sul potere creativo, ma anche distruttivo, del destino di nascere tra due sponde. Richelieu e Voroncov in Odessa videro la tavolozza completa grazie a cui realizzare le loro concezioni illuminate della modernità e della cultura. Puškin vi trovò un sentore di esotismo. Jabotinskij e Babel cercarono entrambi di sfuggire alle loro origini e di ricrearle. Quelli simili ad Alexianu fecero di tutto per cambiare i suoi connotati, tentando di dominare su una città attraente e nel contempo di svuotarla degli abitanti che la disturbavano. Mark Bernes, Leonid Utesov e moltissimi altri comici e musicisti fecero della nostalgia una forma d’arte. Le frontiere sono spazi che vengono continuamente rimodellati, in base agli ideali, meravigliosi o atroci, di chi cerca di controllarle. In questi luoghi, tuttavia, c’è qualcosa che continua a resistere anche ai progetti piú tenaci che mirano a stravolgerli.
Odessa sta subendo oggi un’altra trasformazione. È il piú importante porto passeggeri di una nazione relativamente nuova, l’Ucraina, che è emersa dalle macerie dell’Unione Sovietica nel 1991. Gli amministratori cittadini sono molto piú benevoli di quelli di altre epoche. Sotto molti aspetti, si sono impossessati del suo passato variegato e complesso invece di cancellarlo. Come i loro predecessori sovietici, hanno scoperto che la nostalgia permette di fare affari. Ma i vecchi impulsi non sono scomparsi. I testi scolastici, anche in questa città che è la quintessenza della multietnicità, raccontano una storia fatta di linee rette e di punti fissi: il popolo ucraino è comparso sin dall’antichità, è stato oppresso dai russi e dai sovietici e il suo glorioso riemergere come nazione indipendente saluta la fine del xx secolo.
Odessa, proprio come ci si sarebbe aspettato, ha resistito. La popolazione russa preferisce parlare la propria lingua invece di apprendere la lingua ufficiale dello Stato, l’ucraino. I musei continuano a ritrarre una visione decisamente locale del passato, che stride con le versioni trionfanti e nazionalistiche che si trovano nella capitale. Mentre la popolazione di Kiev è insorta contro i politici corrotti e le elezioni truccate del 2004, un cambiamento pacifico di governo ora definito «la rivoluzione arancione» (per le sciarpe e le magliette che indossavano i manifestanti), gli odessiti sono rimasti relativamente tranquilli. Hanno sostenuto gli oppositori, ma sono rimasti scettici. In ogni caso, non hanno prestato molta attenzione a quel che è successo a Kiev.
Il fatto è che gli odessiti, alle sfide del cosmopolitismo, hanno preferito il fascino della nostalgia. A ricreare il loro passato adoperano ancora la stessa energia che un tempo venne usata per creare la città dal nulla della prateria costiera. I cittadini hanno un’affinità naturale, forse addirittura un’ossessione, per quello che in russo si chiama kraevedenie, una combinazione di storia locale, just-so stories e passione per l’antichità.
Nessuna città supera Odessa per la quantità di guide storiche tascabili, libri di barzellette e monografie su strade, palazzi, quartieri, famiglie, negozi, visitatori famosi e oscuri personaggi storici. Nei week-end estivi lungo la Deribasovskaja e nel parco polveroso che circonda la cattedrale Preobraženskij, ricostruita e ribattezzata, si possono trovare poeti del luogo che vendono le loro raccolte di odi alla città che si sono pubblicati da soli, kraevedy che sventolano le ultime collezioni di saggi sulla produzione di grano nel xix secolo o sul sistema idrico della città e librai che propongono una grande scelta di dizionari di «lingua odessita» (una sorta di russo che combina parole ucraine, pronuncia yiddish e gergo della mala). Una casa editrice, Optimum, è diventata famosa ristampando opere introvabili, come le memorie del socio di De Ribas, l’architetto Franz de Voland, e un almanacco del 1894, oltre a una collana spiritosa di libri come 100 grandi odessiti, che comprende tutti, da Vasilij Kandinskij e dal violinista David Ojstrach (che vi trascorsero entrambi l’infanzia) sino a Puškin, Caterina la Grande e la spia britannica Sidney Reilly.
Odessa colleziona personaggi famosi, tra cui per esempio un entusiasta istruttore di campo estivo che sciorina la lista dei divi ebrei oppure una serie di celebri atleti di Cleveland. Con sufficienti ricerche e un po’ d’immaginazione, si può scoprire che molti personaggi famosi hanno avuto qualche genere di rapporto con la città. Negli ultimi vent’anni, tuttavia, anche lo Stato si è immischiato in questo torneo di memoria, con risultati che sono alternativamente ridicoli o imbarazzanti.
Si scavi nel profondo del passato della città, vuole la logica, e si troveranno le vere origini di Odessa. Nel 2005 i resti dei membri della famiglia Voroncov sono stati riesumati dal cimitero in periferia (dove il conte e la contessa erano stati relegati dai sovietici) e, dopo una solenne processione in città, sono stati di nuovo sepolti nella cattedrale SpasoPreobraženskij. Tre anni dopo, alcuni archeologi locali hanno inaugurato un’esposizione permanente che ha il porto come oggetto e si trova sul boulevard Primorskij. Una tettoia di vetro copre le vestigia di un muro di pietra, una vecchia àncora di nave, l’osso mascellare di una vacca, alcuni frammenti di ceramiche e di anfore rotte, e il teschio di un cane. Secondo le insegne, in ucraino e in inglese, sono i resti di un’antica cultura fiorita qui dal v al iii secolo a. C. (forse greci o romani, oppure greco-sciti, o forse protocosacchi). Il visitatore potrà decidere. Ma si tratta di pura fantasia: non è uno scavo a cielo aperto, ma la ricostruzione di un sito archeologico, una scena immaginaria destinata a mettere in connessione il presente con un passato non russo. Il nuovo atteggiamento incline a cercare radici, per quanto immaginarie, si contende il primato con il cosmopolitismo senza patria che è stato all’origine di Odessa, ma ha anche contribuito a distruggerla.
In termini demografici, Odessa è soprattutto ucraina a partire dagli anni Settanta. Al censimento del 1979, gli ucraini rappresentavano la maggioranza assoluta, cioè il 49,97 per cento della popolazione della regione di Odessa. Ma fino a poco tempo fa, questo fenomeno non ci ha illuminato sul modo di sentire della città in termini culturali. Perfino dopo la Seconda guerra mondiale la città è rimasta uno spazio dagli incerti confini, sia per i demografi sia per i sociologi. Nel 1959 era il posto piú misto dal punto di vista linguistico di tutta l’Ucraina. Quasi tutti pensavano che la loro lingua materna fosse diversa dalla lingua del gruppo etnico corrispondente, molto piú che in altre zone della Repubblica. La maggioranza degli ebrei e piú della metà degli ucraini in città parlavano russo. Quasi un terzo dei moldavi parlava ucraino. Le comunità minoritarie di bulgari, bielorussi e altri si servivano del russo, dell’ucraino e delle loro lingue. Il sistema sovietico era basato sulla convinzione che la modernità avrebbe reso inutili le linee divisorie tra i popoli. Ma a Odessa queste linee diventarono degli scarabocchi indecifrabili e i segni fondamentali dell’etnia, della lingua e della religione si combinarono e si sovrapposero in modi imprevedibili.
La popolazione ebraica rimane esigua. C’erano meno di 70000 ebrei in tutta Odessa nel 1989, all’epoca dell’ultimo censimento sovietico; la maggior parte viveva in città. La loro percentuale, meno del 4 per cento, si abbassò ulteriormente quando gli ebrei, come gli altri, poterono emigrare liberamente dopo la caduta del comunismo. Oggi nessuno sa quanti ebrei costituiscano la piccola comunità di una città di 1,2 milioni di abitanti; alcuni dicono 36 000, anche se è probabile che sia una cifra troppo alta, poiché l’ultimo censimento ucraino del 2001 ne registrava soltanto 13 000 in tutta la città. La sinagoga principale, la Glavnaja, è stata tuttavia restaurata in tutta la sua magnificenza, con un ristorante kosher nell’ampio seminterrato. C’è una presenza ebraica (o una memoria popolare) ancora sufficientemente diffusa perché le agenzie di viaggio offrano gite nell’«Odessa ebraica», che includono una sosta nel centro ipermoderno della comunità ebraica.
Gli ucraini, almeno coloro che ne rivendicano l’etnia nel censimento, sono ora la maggioranza assoluta, e formano i due terzi della popolazione totale. Ma con una consistente minoranza russa e l’adesione quasi completa al russo come lingua franca, le fazioni politiche hanno trascorso gli ultimi due decenni a intraprendere una lotta per avere la priorità della memoria pubblica. Un isolato dopo la scalinata di Odessa, l’amministrazione cittadina ha rimosso una statua dell’epoca dei soviet che commemorava l’ammutinamento della corazzata Potëmkin. Al suo posto è stata eretta una statua restaurata della fondatrice della città, Caterina la Grande, che era stata un tempo tolta dai bolscevichi (che l’avevano sostituita con un busto di Karl Marx). La mano sinistra di Caterina ora indica non solo il porto, ma anche il Nord, la Russia, che molti odessiti, indipendentemente dalla loro provenienza etnica, considerano ancora come patria culturale e spirituale. Prevedibilmente, il giorno in cui la statua è stata inaugurata, ci sono state dimostrazioni sia a favore sia contro.
Altrove, gli ucraini hanno portato avanti una battaglia da retroguardia. È stata eretta una statua al poeta Ivan Franko, icona del nazionalismo ucraino con scarsi rapporti con la città, e un memoriale ad Antin Andrijovič Holovaty, un capitano cosacco del xviii secolo e, in quanto tale, eroe protoucraino. Un’insegna di strada in falso antico è stata posta all’estremità della Deribasovskaja, annunciando che il nome sarebbe diventato ufficialmente Deribasivs´ka, una versione ucraina che pochi odessiti sarebbero in grado di pronunciare. Dalla fine dell’Unione Sovietica, il governo della città ha rimosso 148 monumenti pubblici (104 dei quali celebravano Lenin) e ha ribattezzato 179 strade con i nomi imperiali russi, di solito con la grafia ucraina oppure con nomi nuovi. «La mia nazionalità è odessita!» dice uno slogan che viene spesso ripetuto negli opuscoli turistici e nelle guide locali. Ma nel bel mezzo delle lotte interne per la collettività, l’identità e la memoria, la città si aggrappa ancora in modo confuso a un mito fondativo in grado di legittimarla.
In definitiva, il passato di Odessa, compreso correttamente e interpretato nel modo giusto, potrebbe essere il patrimonio comune dei governanti, il vecchio e il nuovo, la Russia e l’Ucraina. Per l’Ucraina, Odessa potrebbe trasformarsi in un vantaggio, ora che la giovane nazione cerca di diventare membro dell’Unione europea e vuole essere pienamente riconosciuta come Stato europeo, dal punto di vista geografico, culturale e politico. Per gran parte del secolo scorso, l’Europa fu il campo di battaglia principale di conflitti per la terra, il potere e l’identità. Oggi, l’ideale di comunità religiosa ed etnica che riesce a convivere dopo le ferite della guerra, le penurie, il nazionalismo e le ambizioni imperiali fallite, malgrado i richiami delle sirene di una repulsione reciproca e di un biasimo di facciata, è la risposta dell’Europa alla realtà del passato recente. Gli europei ora immaginano se stessi come esseri ricchi di umanità, tolleranza e cosmopolitismo, proprio perché i loro nonni hanno trascorso gran parte del secolo scorso a sbandierare i valori opposti. Se gli ucraini vorranno affrontare il passato nello stesso modo (facendo rivivere gli antichi talenti pur osando guardare in faccia le atrocità della Seconda guerra mondiale), la vecchia immagine di Odessa come porta d’ingresso d’Europa vivrà ancora.
Alla Russia, Odessa offre un modello di sviluppo che premia ciò che è strano e inusuale, una capacità di ridere di se stessi e uno scetticismo sulla retorica della grandezza nazionale (valori che la Russia, come il suo precursore sovietico, sembra aver abbandonato). Durante l’èra comunista, Odessa perse la sua precedente posizione di anticamera della Russia. Diventò una città regionale assai curiosa, non piú il porto internazionale che era stata al tempo della storia imperiale. Ma anche la Russia ha perso una delle sue maggiori speranze di definirsi in quanto paese multinazionale e nel contempo umile e sicuro di sé. Per una nazione che sta scoprendo ora la sua influenza regionale e anche quella globale (che esibisce la sua forza di produttore di petrolio e di gas, la sua potenza navale e si propone come polo alternativo all’Occidente), Odessa ricorda che il declino del vecchio porto, in un certo senso, ha rappresentato il declino di un certo modo di essere russi.
Molte città stanno in bilico sul sottile crinale tra i conflitti quotidiani, che suscitano momenti di genio autentico, e le esplosioni periodiche, in cui si spaccano le vetrine e si dividono le comunità. Molte altre, soprattutto nell’Europa orientale, riscrivono attivamente il loro passato, cercando di dissimulare i momenti in cui le convenzioni della civiltà urbana hanno ceduto alle pressioni delle differenze culturali. Che Atene ora abbia una forte presenza musulmana, Salonicco una pluralità ebraica e Tbilisi un nucleo armeno, nel migliore dei casi oggi sono solo note a margine, sottovalutate nei musei e sottratte alla memoria popolare. Gli stessi impulsi di pulizia etnica esistono anche a Odessa, malgrado la sua reputazione ribelle e multiculturale. Dopo la Seconda guerra mondiale, è una città che ha rappresentato un centinaio di modi diversi di essere ebreo o cristiano e non ha sostituito l’onore di avere modi di vita multipli con i valori piú semplicistici della memoria e della nostalgia.
Ci vuole uno sforzo particolare per ricordare senza distogliere lo sguardo le epoche in cui l’impulso autodistruttivo ha sopraffatto l’essenza dell’uomo. Visitando Odessa oggi, respirerete un luogo che, alla metà del xx secolo, fu capace di praticare l’arte di divorare se stesso – consumato da alcuni aspetti del proprio passato, ma dolorosamente ignorando tutti gli altri. Nelle strade di Odessa, tuttavia, c’è ancora un’identità che comprende persone che pronunciano accenti diversi e parlano troppo forte, ma sono comunque vicini di casa, anche nel bel mezzo del kitsch postsovietico, nell’ossessione ucraina per la mitologia nazionale e nel nuovo fascino della Russia per la sua vocazione imperiale. Con un’attenzione rivolta ai tempi oscuri come all’età d’oro, gli odessiti potrebbero di nuovo immaginare come creare dai resti dell’Impero un patriottismo nuovo. Dopotutto, i figli e i nipoti degli ucraini, dei russi e di quelli che si sono insediati in città dopo la Seconda guerra mondiale, accanto agli immigrati dalla Turchia, dal Caucaso, dal Medio Oriente e all’Asia orientale, ora hanno la possibilità di costruire la loro versione di «Mamma Odessa», diversa da quella degli scorsi due secoli, ma non meno completa. Come i parigini, i berlinesi, i viennesi e i newyorkesi, essi possono perfino convincersi di qualcosa che le generazioni passate di odessiti sapevano istintivamente: che con la giusta combinazione di cordialità e di caos, le città possono rappresentare il massimo livello di patria.