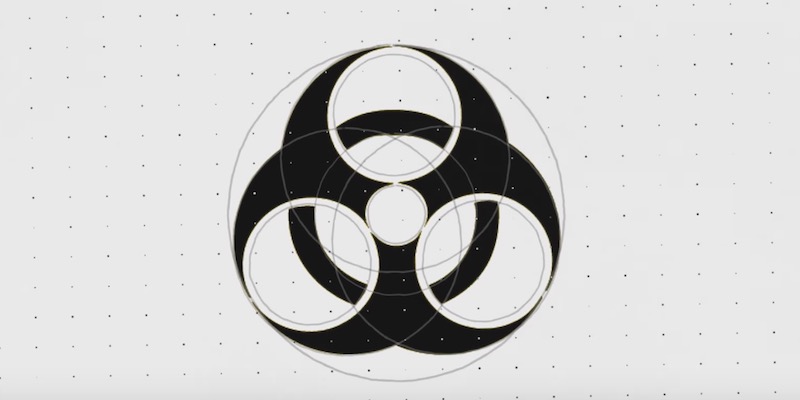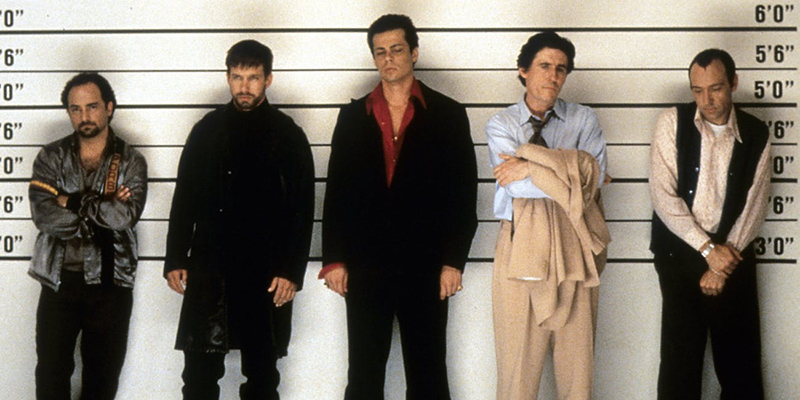Come funziona il finanziamento pubblico dei partiti
Dal referendum che lo ha abolito ai "rimborsi" che lo hanno ripristinato, fino alle modifiche introdotte durante il governo Monti (e nel resto del mondo?)

Fare politica costa, spiegano sempre i partiti. Costano gli affitti delle sezioni, e dei teatri e delle sale in cui tenere le iniziative politiche, costano i telefoni e i manifesti, costano i viaggi, le campagne di propaganda, costano gli spot, costano gli uffici per organizzare l’attività di un partito, costano i dipendenti. Per pagare queste cose i partiti italiani hanno tre fonti principali di sostentamento economico: le quote versate dai propri iscritti e dai propri dirigenti (in diversi partiti i parlamentari versano parte del proprio stipendio al partito, e devono pagare una cifra al momento della candidatura), le donazioni ricevute (sia direttamente che indirettamente, si pensi per esempio agli stand delle feste dell’Unità), e i soldi pubblici assegnati per legge: il famigerato “finanziamento pubblico dei partiti”, oggi di nuovo molto discusso.
Il finanziamento pubblico dei partiti arrivò in Italia nel 1974 con una legge promossa dalla Democrazia Cristiana – e votata da tutti i partiti presenti in parlamento, PCI compreso, ed escluso il PLI – allo scopo, teoricamente, di ridurre il rischio di tentativi di corruzione. Si disse, infatti, che limitare ai fondi dei privati il sostentamento dei partiti avrebbe avuto possibili conseguenze negative. Che si fa, per esempio, se una o più persone ricchissime mettono le loro finanze a disposizione di un partito? Come si mette il sistema politico al riparo di quello che può accadere se un grande gruppo industriale o una lobby o anche un ente pubblico si mette a finanziare massicciamente uno più partiti per ottenerne in cambio dei vantaggi? O, simile e inverso, se un partito non ha fondi e deve trovare il modo di ottenere contributi privati?
La legge, approvata dopo alcuni scandali allo scopo di limitare la corruzione, obbligava i partiti che ricevevano il denaro pubblico a dare conto delle donazioni ricevute in bilanci trasparenti e a non ricevere donazioni da enti e strutture di proprietà pubblica (come l’ENI, per esempio) ma non ottenne il suo scopo. Nel 1976 l’industria statunitense Lockheed ammise di aver pagato tangenti a politici italiani per vendere i propri aerei militari. Sempre in quegli anni attorno al banchiere Michele Sindona emerse un grosso e torbido giro di corruzione e tangenti legato alla Democrazia Cristiana. Nel 1978 un referendum proposto dai Radicali non raggiunse il quorum per pochi punti ma raccolse il 97 per cento dei voti per l’abolizione del finanziamento pubblico. Nel 1993, dopo le inchieste di “Tangentopoli”, un nuovo referendum ottenne il quorum e con il 90,3 per cento dei Sì il finanziamento pubblico ai partiti venne abrogato.
Dopo il referendum
Le leggi in vigore vennero quindi aggiustate e modificate in modo tale da eliminare, teoricamente, il finanziamento pubblico: ripristinandolo però sotto altre forme. Una vecchia legge sui rimborsi elettorali fu prima allargata e poi rimpiazzata nel 1999 da una nuova che, a cominciare dalle elezioni politiche del 2001, destina dei fondi a tutte le liste che superano l’1 per cento dei voti, per tutta la durata della legislatura. Nel 2006 la legge venne ulteriormente modificata e attribuì il finanziamento per cinque anni dal voto, anche se la legislatura dovesse finire prima. Parliamo di molti soldi: 468 milioni di euro per ogni legislatura, quasi mezzo miliardo di denaro pubblico.
Le moltiplicazioni del finanziamento
La legislatura iniziata nel 2006, quella con le elezioni vinte di pochissimo dal centrosinistra, finì nel 2008. I partiti che ottennero almeno l’1 per cento dei voti (quindi anche alcuni che non sono in parlamento, avendo ottenuto meno voti della soglia di sbarramento per eleggere parlamentari) continuano però a percepire i “rimborsi” per tutto il 2011, e a quelli si sommano i “rimborsi” relativi alle elezioni politiche del 2008, quelle che hanno dato inizio alla legislatura in corso. Questa è la prima sovrapposizione paradossale: per non essere “finanziamento pubblico dei partiti” devono essere rimborsi elettorali, ma questo rende priva di senso la loro assegnazione in anni non elettorali, e doppiamente privo di senso il loro raddoppio. Poi c’è un’altra questione.
Nel 2008 i due principali partiti politici, Popolo della Libertà e Partito Democratico, erano appena nati dalla fusione di quattro partiti politici: Alleanza Nazionale e Forza Italia, il primo, Democratici di Sinistra e Margherita, il secondo. Quindi succede che Popolo della Libertà e Partito Democratico ricevano i rimborsi elettorali per le elezioni 2008 mentre Alleanza Nazionale, Forza Italia, Democratici di Sinistra e Margherita continuavano a percepire i rimborsi per le elezioni del 2006. Questi partiti, infatti, formalmente esistono ancora: non fanno attività politica – alcuni sono diventati amministrativamente delle fondazioni – ma hanno sedi, uffici, dipendenti, patrimoni. E soldi.
Che cosa è cambiato durante il governo Monti
Con l’insediamento del governo Monti, si disse che il Parlamento avrebbe dovuto approfittare di quella fase politica per risolvere alcune questioni: la legge elettorale, le riforme istituzionali, i costi della politica. Sul fronte del finanziamento pubblico ai partiti, dopo lunghe discussioni – e molte sedute parlamentari con pochi presenti in aula – i partiti hanno raggiunto un’intesa su un testo non condiviso soltanto da Italia dei Valori e Lega Nord, che giustificavano il disaccordo chiedendo l’eliminazione completa dei rimborsi piuttosto che la riduzione. A luglio del 2012 è stata infine approvata la legge n. 96/2012 (PD e PdL favorevoli, IdV contraria, Lega astenuta) che ha dimezzato i contributi pubblici per l’anno 2012 – da 182 a 91 milioni – e stabilito delle riduzioni per gli anni successivi. I fondi risparmiati con le riduzioni del 2012 e del 2013, circa 165 milioni di euro, sono stati destinati alle amministrazioni delle regioni colpite dai terremoti dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna).
Nella prossima pagina: le altre modifiche approvate durante il governo Monti,
e come funziona il finanziamento pubblico ai partiti nel mondo.
La legge ha anche introdotto nuove condizioni per accedere ai fondi. I partiti devono ora ottenere il 2 per cento dei voti alla Camera o avere almeno un parlamentare eletto. Occorre inoltre che i partiti siano dotati di un atto costitutivo e di uno statuto “conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti”. La legge ha anche stabilito alcune misure per regolare la trasparenza nell’assegnazione dei rimborsi. Una commissione composta da cinque magistrati (tre della Corte dei Conti, uno del Consiglio di Stato e uno della Corte di Cassazione) è stata istituita per vigilare sui bilanci dei partiti. E tutti i tesorieri di partito devono pubblicare redditi e patrimonio, anche dei familiari. Altre novità sono: la riduzione del 5 per cento sui rimborsi dei partiti le cui liste siano composte per più di due terzi da candidati dello stesso sesso; il divieto per i partiti di prendere in affitto o acquistare immobili da persone elette in parlamento, in Europa e nei Consigli regionali.
I rimborsi elettorali per la legislatura che sta per iniziare – previsti per i prossimi cinque anni – ammontano a 159 milioni di euro, di cui 46 milioni spetterebbero al PD, 43 milioni al M5S, 38 milioni al Pdl e 15 milioni alle liste Monti (Scelta Civica, Udc e Fli). Il Movimento 5 Stelle ha già annunciato che rinuncerà alla sua quota e oggi Beppe Grillo ha invitato Bersani e il PD a fare lo stesso.
Come funziona nel mondo
La situazione è molto eterogenea. Come riporta uno studio dell’Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), sono 96 i paesi che prevedono il finanziamento pubblico annuale (totale o parziale) dello Stato ai partiti, ossia circa il 44 per cento dei paesi del mondo. Invece, sono 57 i paesi che prevedono fondi pubblici ai partiti in relazione alle spese sostenute in campagna elettorale, ossia il 26,4 per cento sul totale (alcuni paesi del primo gruppo sono presenti anche in questa lista perché prevedono entrambi i sistemi di finanziamento pubblico).
Gli stati che invece non prevedono il finanziamento pubblico ai partiti in nessuna forma sono 55 (ossia il 25,5 per cento del totale). In Europa sono una manciata (Malta, Andorra, Svizzera, Bielorussia, Ucraina), molti sono paesi dell’Asia (come India, Bangladesh, Libano, Singapore), dell’Africa (come Senegal, Mauritania, Sierra Leone), diversi paesi centroamericani e sudamericani (quali Bolivia e Venezuela) e piccoli stati dell’Oceania.
Gran parte dei paesi europei, dunque, tra cui anche quelli economicamente più forti o con una grande storia democratica alle spalle, prevedono il finanziamento pubblico ai partiti e in varie forme. In Francia, la legislazione francese prevede due tipi di finanziamento pubblico: il primo, in forma di contributo annuale (circa 70 milioni di euro), viene calcolato in base ai voti ottenuti alle precedenti elezioni dell’Assemblea Nazionale, il secondo, in forma di rimborsi, in proporzione ai rappresentanti di ogni partito eletti nelle due Camere (in genere, per ogni elezione nazionale, oscillano intorno ai 40 milioni di euro all’anno). Un meccanismo simile vige in Spagna, dove si sommano gli stanziamenti annuali dello Stato a rimborsi elettorali in base ai voti ottenuti alle elezioni precedenti, per un totale di circa 130 milioni all’anno di finanziamento pubblico ai partiti.
In Germania, invece, non ci sono rimborsi, ma dal 1958 solo un finanziamento pubblico fisso ai partiti, in base ai voti che prendono alle elezioni precedenti per un tetto massimo complessivo di circa 133 milioni. In Regno Unito, la situazione è più complessa: lo Stato fornisce direttamente due milioni complessivi a una decina di partiti, a cui vanno aggiunti i fondi della Camera dei Comuni che premiano i partiti all’opposizione (per esempio, il Partito Conservatore ha ricevuto circa 4 milioni e 700mila sterline per la “stagione politica” 2009-2010) e quelli della Camera dei Lord, destinati sempre ai partiti di opposizione (ma qui si arriva a un massimo di 500mila sterline all’anno per partito). Negli Stati Uniti, invece, il finanziamento pubblico è previsto solo durante le campagne elettorali per le elezioni presidenziali (anche per le primarie), ma i modesti finanziamenti dello Stato obbligano chi li riceve a rinunciare ai soldi dei privati, dunque la maggior parte dei candidati americani li rifiuta.