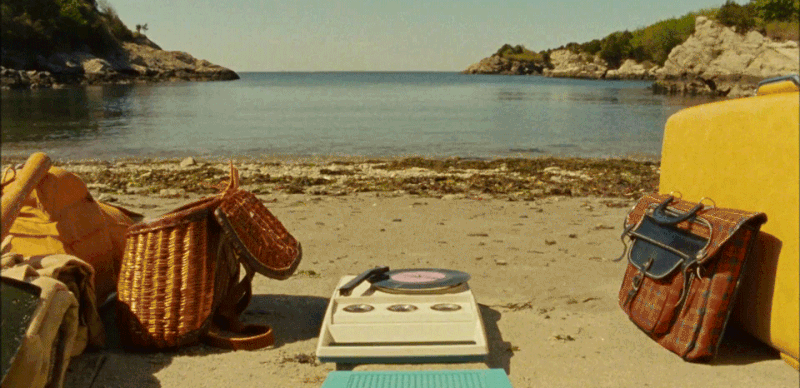Il modello svizzero
Studiare il dibattito democratico tra la festa della Confederazione e la commemorazione della strage di Bologna
di Filippomaria Pontani

Esistono buoni argomenti per sostenere che il 2 agosto sia un giorno centrale nella storia del nostro Paese, ben degno (certo non meno del 9 maggio, data dell’assassinio di Aldo Moro) di assurgere al ruolo di “giorno della memoria” per le vittime dei vari terrorismi che hanno costellato il Dopoguerra. De facto è già così, poiché da trent’anni la commemorazione della strage della stazione riempie Bologna di folle consapevoli e arrabbiate, in una cerimonia che non ha molti confronti all’interno della declive ritualità italiana. È soprattutto questo valore simbolico a rendere deplorevole l’inusitata totale assenza di esponenti del governo nella manifestazione dell’altroieri: la scelta di mancare a quell’occasione – così come, per altro verso, non presentarsi alle celebrazioni del 25 aprile – non indica solo scarso rispetto nei confronti della memoria collettiva, ma svela anzitutto l’incapacità di una classe politica dinanzi alla “democrazia diretta”, quella dell’assemblea.
Si tratta di un confronto che ha i suoi rischi, e che li ha sempre avuti, sin da quando Pericle e Cleone calcavano le tribune della Pnice, e ogni cittadino poteva prendere la parola, in grazia dell’indiscusso principio dell’isegoria. Agitare oggi a mo’ di spiegazione la presunta ostilità programmatica dei manifestanti al governo in carica (come hanno fatto esponenti dell’esecutivo, a cominciare dal signor Giovanardi), significa confessare la propria impotenza dialettica, travisare la realtà storica (negli anni, i fischi del 2 agosto sono stati indirizzati a ministri d’ogni colore), e soprattutto operare un singolare rovesciamento secondo il quale la colpa sarebbe di chi fischia e non di chi – direttamente o indirettamente – ha contribuito a depistare le indagini, a ritardare l’accertamento delle responsabilità, a confondere le acque. Parliamo – è bene ricordarlo – di sentenze passate in giudicato, a carico di esponenti e apparati dello stato, di generali dei servizi segreti come di loschi adepti della loggia massonica P2; parliamo anche di sconcertanti “rivelazioni” compiute a molti anni di distanza da chi allora era primo ministro, il sig. Cossiga, e tese a rispolverare, riveduta e corretta, la cosiddetta “pista internazionale”, o meglio “palestinese”. Se non è legittimo prendersela con chi ha rappresentato e rappresenta al più alto grado istituzioni così reticenti e corrive, quando altro si potrà protestare? E se le istituzioni si nascondono, contro chi si sfogherà la rabbia?
Tra i vari riassunti della vicenda di Bologna comparsi in questi giorni sulla stampa internazionale (trenta è un numero tondo, e stimola le riflessioni), basterebbe leggere quello pubblicato da Nikos Tzermias sulla «Neue Zürcher Zeitung» del 31 luglio per scoprire tra le righe l’impressione di un Paese ancora in balìa degli stessi fantasmi di trent’anni fa, aggravati da un marciume solipsistico cui l’ormai mutata situazione internazionale non fornisce nemmeno un quadro di riferimento e giustificazione. L’articolo di Tzermias è, si badi, assolutamente sobrio, così come gli altri due dedicati all’Italia nello stesso numero della NZZ, l’uno sulla crisi fra Berlusconi e Fini, l’altro sull’ingannevole tenuta dei conti del nostro sistema pensionistico. E allora rimaniamo in Svizzera, per una singolare sovrapposizione di date.
Il 1 agosto si celebra ogni anno la nascita della Confederazione Elvetica, ovvero il giuramento antiasburgico prestato nel 1291 dai rappresentanti dei cantoni di Uri, Schwyz e Unterwalden, i tre cantoni che nel 1315 avrebbero sconfitto gli Austriaci a Morgarten con l’apporto di Guglielmo Tell. Per una nazione che non ha una lingua propria (né, secondo molti dei suoi stessi artisti, da Dürrenmatt a Frisch, un vero nerbo etico e culturale), si tratta di un momento di aggregazione fondamentale, che viene tradizionalmente suggellato in ogni comune da un lungo, festoso scampanío e da un discorso pubblico tenuto da un esponente della “classe dirigente”, che si tratti di un giudice, di un militare, di un uomo politico, o simile. In queste Augustreden, va da sé, ampio è lo spazio destinato alla retorica e alle affermazioni di principi come rispetto, libertà, consenso, responsabilità; ma di norma non mancano mai prese di posizione esplicite in relazione ad alcuni aspetti del vivere comunitario, critiche e autocritiche, tentativi di sensibilizzare i cittadini a problematiche di interesse generale, o anche solo all’importanza prioritaria del loro ruolo come protagonisti dello Stato.
Capita così che a Zurigo il capo di stato maggiore dell’esercito, il gen. André Blattmann, rifletta sul valore della (lunga, e come noto obbligatoria e ricorrente) ferma militare degli Svizzeri quale fonte d’integrazione sociale ed etnica; o che nella regione di Friburgo un membro del Consiglio federale, Didier Burkhalter, insista sulla necessità della pur crescente spesa sociale per i senza lavoro (per finanziarla Martin Waser, direttore degli affari sociali del comune di Zurigo e non certo un bolscevico, giunge a invocare sobriamente una nuova tassa di successione); oppure che in un paesino dell’Alta Engadina un giudice amministrativo federale, la sig.ra Salome Zimmermann, denunci con inquietudine la rapidissima scomparsa dei ghiacciai del Bernina o la speculazione edilizia che, dopo avere irrimediabilmente devastato St. Moritz, rischia di compromettere anche altri paesaggi incantevoli. Capita che il dibattito si sviluppi al livello delle singole comunità, “dal basso”, e non sia un confronto predeterminato (come avviene per es. nel plebiscitarismo della Jamahiriya libica), bensì stimoli la gente a riflettere su temi che la toccano da vicino. In questi discorsi si realizza, in un certo senso, quell’ideale di democrazia diretta e partecipata di cui la Confederazione fa una bandiera, anche nell’uso largo dello strumento referendario.
Che il confronto non sia posticcio lo dimostra il ricorrere nelle Augustreden di quest’anno delle questioni più scottanti, che coinvolgono la stessa natura e impalcatura statale della Confederazione: il segreto bancario, fonte del recente conflitto con gli Stati Uniti, risolto solo al prezzo di consegnare di fatto alle patrie galere alcuni correntisti americani dell’UBS; la politica delle estradizioni, salutata con sollievo dagli amici di Roman Polanski, ma ora (per mera analogia giurisprudenziale) suscettibile di mandare libero il pericoloso furfante ceco Tomas Pitr, arrestato la settimana scorsa proprio a St. Moritz e atteso in patria da severe condanne per truffa, evasione e traffici oscuri; il rispetto delle altre religioni, particolarmente attuale in un Paese che ha appena proibito per referendum l’erezione di nuovi minareti, ma nel contempo ospita un 20% di cittadini stranieri e affida la direzione di una Facoltà teologica a un Ebreo (Alfred Bodenheimer presso l’Università di Basilea); l’ingresso nell’Unione Europea, vexatissima quaestio che pone agli Svizzeri basilari problemi identitari e funzionali, specialmente in questi anni che sembrano vedere il fallimento del progetto d’integrazione nato con i Trattati di Roma.
Da fuori, si suole considerare l’aspetto meramente economico della “neutralità” svizzera; è indubbio che questo tema abbia il suo peso (per esempio l’introduzione dell’IVA è per gli Elvetici un autentico spauracchio), ma negli ultimi anni molte cose sono cambiate: il segreto bancario è stato intaccato, sul piano monetario la convenienza del franco sull’euro è altamente opinabile, e – con o senza le quote-latte – i mercati nei quali si inserisce l’economia elvetica sono di fatto determinati dalla politica dell’Unione. È per questo che molti, dai pur cauti politici del Partito Socialdemocratico ai più decisi opinionisti come Markus Spillmann o il filosofo della politica Georg Kohler, spingono per una revisione del “bilateralismo” che ha fin qui presieduto alle relazioni fra Svizzera e Unione Europea, e per una forma di avvicinamento che porti a un’adesione sul modello inglese; dopotutto, a Losanna ha sede la Fondation Jean Monnet pour l’Europe, uno degli organismi più attivi per far conoscere il pensiero dei padri fondatori come Monnet stesso, Altiero Spinelli e Robert Schuman.
Ma tra i fattori che inducono diffidenza in gran parte degli Svizzeri c’è anche un principio di autodeterminazione che riguarda non solo il leggendario sistema postale – egualitario par excellence – ma anzitutto il meccanismo della democrazia diretta, quello che prevede che ogni cittadino sia direttamente partecipe delle decisioni, e direttamente informato e consultato dai suoi rappresentanti non solo in occasione delle allocuzioni del 1 agosto. Come argomenta Christoph Blocher, numero due dell’euroscettico Partito Popolare, l’ingresso nell’Unione comporterebbe per i cittadini svizzeri una perdita secca di potere: e su questo anche Kohler deve riconoscere che la minaccia alla «besondere politische Kultur», alla speciale cultura politica degli Svizzeri, al «Sonderfall» (caso particolare) che essi impersonano, rappresenta l’ostacolo più serio all’integrazione nella comunità («NZZ-Folio», 2 agosto 2010).
La Svizzera è un Paese pieno di problemi, e nato con scopi e ambizioni così diversi da quelli delle potenze europee che sarebbe puerile ergerlo a modello. Tuttavia, per chi abbia vissuto il 1 agosto lassù e il 2 agosto quaggiù, la differenza nella qualità (o nell’esistenza tout court) della comunicazione all’interno dell’espace public potrebbe aver lasciato una vertigine pari a quella indotta dagli spettacolari viadotti della Ferrovia Retica tra Ospizio Bernina e Tirano – una linea leggendaria, che fu costruita giusto cent’anni fa con immane fatica da tremila operai venuti da un’allora povera Padania.