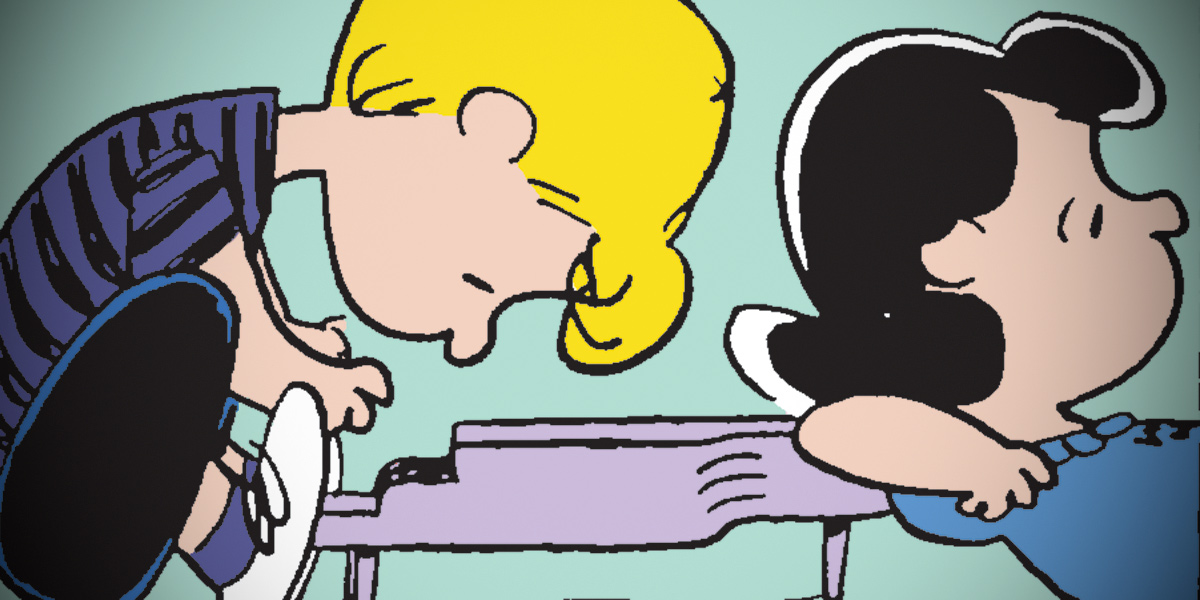C’è bisogno di più
Il risultato politico sul breve termine non era in discussione, e infatti la direzione del Pd non ha riservato sorprese.
La frase finale del segretario, sul pieno affidamento nelle mani del capo dello stato, mette la proposta democratica per la formazione del governo Bersani nella sua giusta prospettiva. È la linea condivisa dal gruppo dirigente del partito, non è né potrebbe essere un ultimatum.
Da questo punto di vista l’unico spunto che maliziosamente si potrebbe cogliere è in quell’accenno finale di Bersani alla forza parlamentare del Pd. È sembrato voler dire: se non ce la faccio io non ce la farà nessun altro contro di noi, e nel caso abbiamo i numeri per eleggere un capo dello stato mettendoci d’accordo solo con Monti.
La lunga discussione di ieri però è stata piena di altri segnali, tutti interessanti anche se non tutti incoraggianti.
Che non si sia svolto lo psicodramma di un partito sconfitto è una buona prova di saggezza e di tenuta nervosa. Probabilmente però sia la platea dei simpatizzanti che l’opinione pubblica più vasta avrebbero apprezzato una esplicita assunzione di responsabilità sui «limiti soggettivi» (come li ha perfettamente definiti Walter Tocci) del gruppo dirigente. Non necessariamente dimissioni o cose del genere (non sarebbe stata neanche l’occasione giusta), ma qualcosa di più e di diverso della tesi che invece è stata ripetuta da tanti: il Pd ha perduto le elezioni per colpa delle politiche europee e dell’austerità di Monti.
A parte l’impossibilità di far dimettere la Merkel, Draghi o anche semplicemente Monti, il Pd dovrebbe stare attento alle implicazioni di una simile lettura del voto. Tre volte rischiosa.
Perché implica la sconfessione totale delle scelte di Bersani dal novembre 2011 a oggi.
Perché smonta l’impianto della campagna elettorale, che è stata incentrata proprio sulla sofferenza dei ceti deboli stretti dalle politiche di austerità.
Perché infine, rinviando a processi epocali e continentali le cause della perdita di tre milioni e mezzo di voti, può suggerire che non ci siano margini di recupero se non passando dall’altra parte della barricata che separa responsabili e populisti, europeisti e antieuropeisti.
Le analisi che nel salone del Nazareno hanno richiamato la crisi globale della democrazia e della fiducia popolare verso le istituzioni hanno tutte un solido fondamento. Anche la lettura dell’ultimo anno di politica italiana non può sorvolare sull’improba fatica di difendere il rigore di Monti sotto il fuoco incrociato di compagni di strada infidi e di opposizioni populiste arrembanti.
L’importante è che non ci si rifugi nei fenomeni sovranazionali o nelle manovre altrui per non guardare in faccia gli errori propri.
Gli otto punti di Bersani, come tutti hanno rilevato, hanno una valenza che va oltre sia la prospettiva (improbabile) che si trasformino in programma di un vero governo, sia l’utilità tattica di rivolgerli contro Grillo quando non saranno accettati come base di discussione.
Dentro quei punti, per la parte relativa al radicale rinnovamento delle istituzioni e dei partiti, c’è un impegno di rifondazione del Pd che, questo sì, rappresenta l’unica speranza di riconnettersi al proprio popolo deluso.
Il momento migliore di Bersani, ieri, è stato quando ha preannunciato – nei pochi minuti della sua replica finale – che questo sarà il nocciolo del confronto congressuale che si aprirà non appena saranno chiari i termini e i tempi della soluzione (o non soluzione) per il governo.
Già in passato, del resto, il segretario aveva dimostrato di aver chiaro che il Pd correva i rischi più grandi proprio sul versante del discredito della politica agli occhi dei cittadini. E che la sofferenza sociale è un contesto che aggrava la tensione nel paese ma non la spiega.
Aver capito, ha avvertito Bersani ieri in quei pochi minuti, «è un’aggravante». A me questo passaggio è sembrato il momento più intenso e carico di significato, guardando a ciò che dovrà o potrà accadere nel futuro.
Perché se è vero che il distacco era stato colto; che le ragioni della rabbia erano state capite; che il montare dello tsunami grillino era stato visto; e che contromisure anche traumatiche erano state prese (basti pensare allo sforzo micidiale imposto ai militanti per il filotto di primarie fra novembre e fine dicembre), allora vuol dire che il Pd ha un problema interno molto ma molto più serio che non il rapporto con Monti. Una inadeguatezza strategica, comprovata da questo vorrei ma non riesco, da un’impotenza che pesa molto sul segretario in questi giorni: ieri è parso, in quello squarcio, fra i pochi ad aver colto l’enormità del problema.
L’altro che l’ha colto, ça va sans dire, è Matteo Renzi.
Lui naturalmente può permettersi di affrontare la montagna con un’agilità diversa da quella del leader del centrosinistra ora condannato a offrirsi per la soluzione della crisi di governo.
La mossa di lasciare la direzione senza parlare è piaciuta poco a coloro che invece sono rimasti lì dentro. Ma è stata una mossa giusta, salutare nell’interesse non di Renzi ma di tutti.
Se è vero, come gli dicono anche gli ex avversari, che lui è una carta decisiva per il prossimo futuro del centrosinistra, Renzi non può farsi associare a dibattiti inevitabili che però non comunicano nulla di brillante e positivo all’opinione pubblica delusa ed esigente. La sua partita è tutta nel campo del centrosinistra, ma ne oltrepassa abbondantemente gli attuali confini e scavalla l’attuale fase di schermaglia tattica su governi e presidenze. Cosa che del resto vale anche per il suo più forte rivale per la leadership del centrosinistra.
Un altro che ieri al Nazareno non c’era. Assente giustificato in questo caso, perché Fabrizio Barca non è iscritto al Pd.