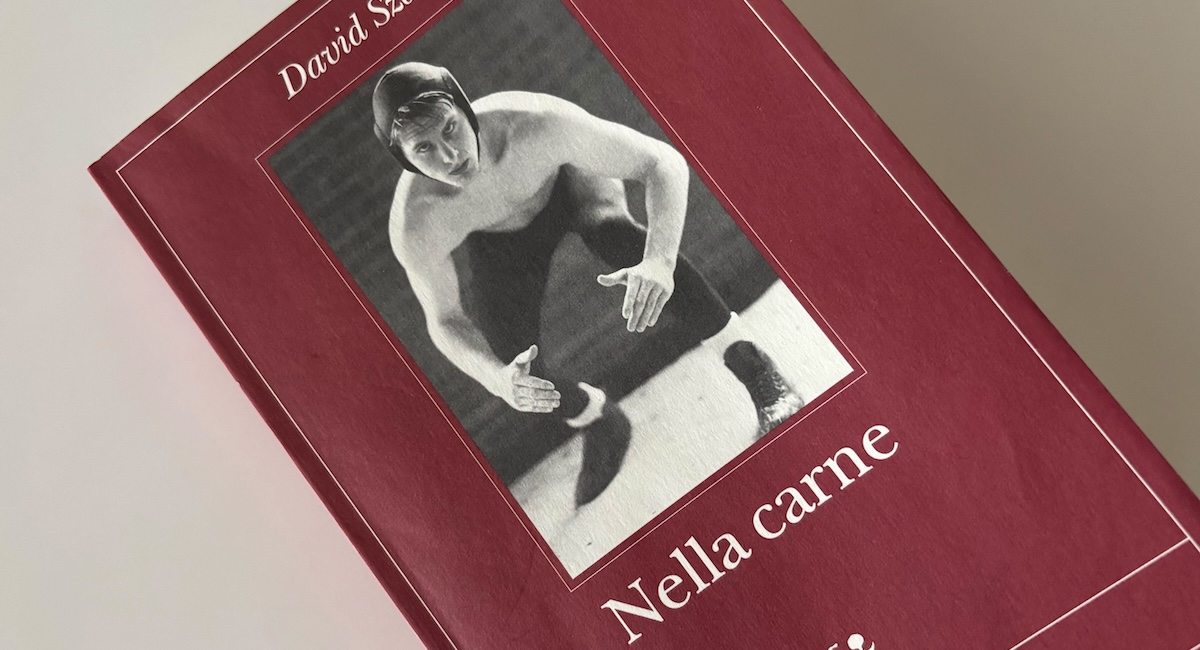Il Leoncavallo e compagnia bella
«Nella stragrande maggioranza delle città italiane le difficoltà dei centri sociali sono evidenti. Sembra però che lo sgombero anticipato di Milano stia agendo nella direzione di un rinnovamento. È un fatto politico che ha mobilitato le persone tradizionalmente e dichiaratamente antagoniste, ma è anche un avvenimento emotivo che sta riunendo chi da quelle sale in oltre trent’anni ci è solo passato, chi ci ha discusso, organizzato, ballato, suonato, recitato, vissuto»

La prima volta che ho messo piede in un centro sociale avevo 14 anni, era il 1993. Il CSOA Tiburzi – dal brigante che infestava la Maremma dell’800 – era un capannone nella zona industriale di Grosseto, occupato da collettivi e cani sciolti: pezzi di Rifondazione comunista e dell’Arci; collettivi antagonisti; il Coordinamento studentesco antifascista, di cui facevo parte; orfani di Democrazia proletaria, disciolta da un paio di anni; punk; anarchici; tossici; frikkettoni; cinefili; più e meno giovani dalle piazze di mezza città; studenti fuori sede che avevano ripreso a tornare da Roma, Bologna, Firenze.
Grosseto era venuta su quasi per caso negli anni ’50, nello sprofondo della provincia, separata dal resto del mondo da campi, paludi e poi ancora campi. Prima del Tiburzi i giorni galleggiavano tra la noia, lo struscio per il corso e la campagna. E improvvisamente c’era un posto pieno di gente che correva avanti e indietro perché c’erano un sacco di cose da fare. Tutto ruotava attorno a quattro o cinque concerti a settimana. Con qualche raggiro riuscii a vederne qualcuno perché i miei non mi lasciavano uscire la sera tardi. Ero però lì tutte le domeniche mattina, a fare le pulizie. Ed ero lì quando c’erano le assemblee, quando venivano dipinti i muri giganteschi, quando venivano preparati i volantini, quando venivano presentati libri e riviste. Quando la tua aspettativa è passare il pomeriggio su una panchina fino a che non viene ora di cena, l’apertura di un centro sociale è una vera rivoluzione della vita quotidiana.
Dopo pochi mesi il Tiburzi fu sgomberato. Per i più grandi fu l’inizio di un percorso di denunce e processi, per gli altri uno slancio verso la rete di spazi occupati in giro per l’Italia. Per noi, e per migliaia di altri ragazzi che gravitavano nell’orbita dei movimenti, viaggiare iniziò a voler dire soprattutto spostarsi da un centro sociale all’altro.
A Roma il Villaggio Globale e il Forte Prenestino, a Firenze il CPA e l’Ex-Emerson, a Bologna il Link e il Livello 57, a Milano il Laboratorio anarchico e il Torchiera, a Torino il Delta House, a Genova il Terra Di Nessuno. Alcuni centri sociali arrivavano direttamente dai Circoli del proletariato giovanile degli anni ’70, altri erano stati occupati nella fase più sotterranea degli anni ’80, altri ancora erano nati dopo la Pantera del 1990, e molti di più dopo la nuova occupazione del Leoncavallo in via Watteau del 1994, che per noi fu un evento cruciale sia sul piano simbolico che su quello organizzativo.
– Leggi anche: Storia dei centri sociali in Italia
Era un mondo di viaggi senza biglietto nei bagni dei treni, di sacchi a pelo e perquisizioni della Polfer, odore di tag e di fusti di birra, muri sepolti da scritte e strati di volantini. Tantissima musica, reggae, hip hop, punk e noise. Aiutare i gruppi a scaricare gli strumenti, dare una mano in cucina, trovare da dormire sul palco o a casa di qualcuno conosciuto quella sera. Svegliarsi perché la sala serviva per un incontro del collettivo internazionalista o di quello antipsichiatrico.
Negli anni ’90, con la deindustrializzazione, fabbriche vuote e officine dismesse costellavano le città aspettando solo di essere abitate. E molte pulsioni cercavano case antagoniste, stanche dell’edonismo reaganiano-berlusconiano del decennio appena concluso. Quelle sopravvissute al riflusso del ’68-’77 e quelle cresciute nei fortini-ghetto della controcultura degli anni ’80. Quelle antiautoritarie che arrivavano dal crollo del Muro di Berlino del 1989, e quelle dell’autogestione delle università occupate dalla Pantera. Quelle del nuovo internazionalismo innescato dalla rivolta dell’EZLN in Chiapas del 1994 e dagli eccidi nell’ex Jugoslavia.
A cavallo del 2000 arrivò una nuova ondata di occupazioni, in continuità ma anche diverse da quelle della generazione precedente: Bulk e Cantiere a Milano, XM24 a Bologna, Elettropiù a Firenze, Strike a Roma ospitavano una rete di laboratori hacker, ciclofficine, spazi per il writing, web radio, infoshop, ostelli autogestiti, collettivi queer, incontri dei lavoratori precari, stamperie, gallerie d’arte. E tantissima musica, techno, drum and bass, trance.
Erano spazi dove si discuteva quello che succedeva in quegli anni, con l’urgenza di uscire e raggiungere altre persone materiali o virtuali. Attraverso esperienze come San Precario, nato per innovare le organizzazioni sindacali di base, in risposta al precariato strutturale introdotto dalle nuove leggi sul lavoro. Un’esperienza che dai centri sociali italiani, nel 2006 arrivò a portare nelle piazze delle città europee centinaia di migliaia di persone, con la manifestazione Euro MayDay. O la costruzione di piattaforme come Autistici/Inventati, un sistema di servizi informatici indipendenti che forniva – e fornisce tuttora – caselle mail, siti web, blog e newsletter a migliaia di realtà alternative. O, ancora, l’incontro con il mondo dei rave, che portò avanti grandi manifestazioni antiproibizioniste e politiche sulla riduzione del danno da stupefacenti nelle strade di tante città.
Dopo la metà degli anni 2000 quel mondo è entrato in crisi.
C’entra, certo, la sconfitta del G8 di Genova del 2001 – con la sua violenza e la repressione che ne seguì – ma le cause sono più ampie e strutturali. Hanno a che fare, innanzitutto, con la crisi generale della sinistra, che a quarant’anni dal maggio ’68 ha iniziato a fare sempre più fatica a rinnovare alcuni dei suoi tratti principali, mantenendoli al tempo stesso identitari. I centri sociali hanno iniziato a essere percepiti sempre più come luoghi per gente di mezz’età ed è divenuto più difficile agganciare le nuove generazioni. Temi come l’antisessismo e la lotta all’omofobia hanno trovato platee molto più vaste, che hanno iniziato ad affollare i Pride, spesso senza più traccia di antagonismo.
Ma ha giocato un ruolo cruciale anche la crisi delle controculture. Con la diffusione dell’Internet di massa e del consumismo globale, il ruolo che le controculture avevano giocato nella definizione delle identità individuali e collettive è cambiato bruscamente. Per lungo tempo, passare attraverso esperienze antagoniste aveva voluto dire frequentare fisicamente spazi alternativi, auto-organizzare concerti, raccogliere e distribuire musica, testi, immagini e video su supporti materiali di scarsa qualità, dalla circolazione lenta e incerta. A un certo punto, in pochissimo tempo, è divenuto invece possibile fare zapping sulle piattaforme del web 2.0 tra generi musicali agli antipodi, consumando i contenuti e ignorando i contesti. Il tutto – sempre più spesso – senza muoversi da casa o concentrando quelle esperienze, che prima richiedevano anni, in pochi festival dedicati, predigeriti e monetizzati.
Non si è trattato, ovviamente, di una sparizione. Anzi, molti spazi “storici” hanno continuato a esistere, conservare e trasmettere la propria eredità politica e culturale. A Roma, in particolare, spazi come il CSOA Forte Prenestino sono ancora in grado di mobilitare energie e persone. Così come nuovi centri sociali hanno continuato a essere occupati dai più giovani, ibridando in molti casi le istanze classiche con quelle più contemporanee del transfemminismo e del decoloniale. E non bisogna neanche dimenticare che all’inizio degli anni ’10 c’è stata la nuova stagione delle occupazioni legate all’arte e al teatro (come Macao a Milano, Ex Cavallerizza a Torino, Ex Asilo Filangieri a Napoli, Teatro Valle Occupato a Roma) che ha introdotto nuove pratiche radicali, da quelle sui beni comuni a quelle sulle nuove forme di autoproduzione artistica.
Nonostante questo, oggi, nella stragrande maggioranza delle città italiane le difficoltà dei centri sociali sono evidenti. Il loro numero e la loro visibilità sono diminuite drasticamente e le nuove sporadiche occupazioni non riescono a contrastare lo stillicidio degli sgomberi. Spesso i centri sociali faticano a intercettare le nuove generazioni e, talvolta, anche i nuovi movimenti e le nuove sottoculture, che finiscono per prediligere luoghi più neutri e meno gravati da tradizioni, linguaggi e consuetudini. In molti casi stentano a costruire alleanze con altri mondi culturali e sociali, vicini e lontani, di fatto isolandosi. E come i loro omologhi negli altri paesi europei, faticano a posizionarsi nella dialettica tra illegalità a tutti i costi e riconoscimento istituzionale. Faticano, soprattutto, a produrre nuovi immaginari e pratiche che indichino cambiamenti sistemici, estetici, esistenziali.
Sembra però che lo sgombero anticipato del Leoncavallo stia agendo proprio nella direzione di un rinnovamento. È un fatto politico che ha mobilitato – prevedibilmente – le persone più tradizionalmente e dichiaratamente antagoniste, ma è anche un avvenimento emotivo che sta riunendo chi è passato da quelle sale in oltre trent’anni, chi ci ha discusso, organizzato, ballato, suonato, recitato, vissuto.
– Leggi anche: Che storia ha il centro sociale Leoncavallo
Il fatto che mi sembra cruciale, tanto da essere riconosciuto anche da molti che al Leoncavallo e in spazi simili non ci sono mai andati o quasi, è che oggi c’è più che mai bisogno di quello che i centri sociali possono dare alle città. Innanzitutto, perché possono essere spazi di produzione, distribuzione e consumo di cultura dal basso – o se preferite “alternativa”, “indipendente”, “underground”, “di base”, “grassroots”.
Ma anche perché i centri sociali incoraggiano il do-it-yourself: se una cosa che serve non c’è, non aspettare che qualcuno la faccia per te o che te la venda; falla tu, assieme ad altri. E incoraggiano la sperimentazione: la ricerca oltre i codici e i linguaggi dominanti – il mainstream, se si vuole – non solo perché sono scontati, ma anche perché incorporano forme di potere che è bello imparare a smontare e contrastare. Una cultura, insomma, che aspira a essere popolare nella sua accezione più radicalmente democratica. Accessibile per ogni tasca, anche per chi non ha i documenti (anche grazie a pratiche illegali come l’occupazione – non pagare lo spazio – e l’autorganizzazione – non pagare le tasse). Per questo sarà interessante guardare a quello che succederà questo autunno, a partire dalla manifestazione contro lo sgombero del Leoncavallo di sabato 6 settembre.
– Leggi anche: Le opere d’arte dentro il Leoncavallo