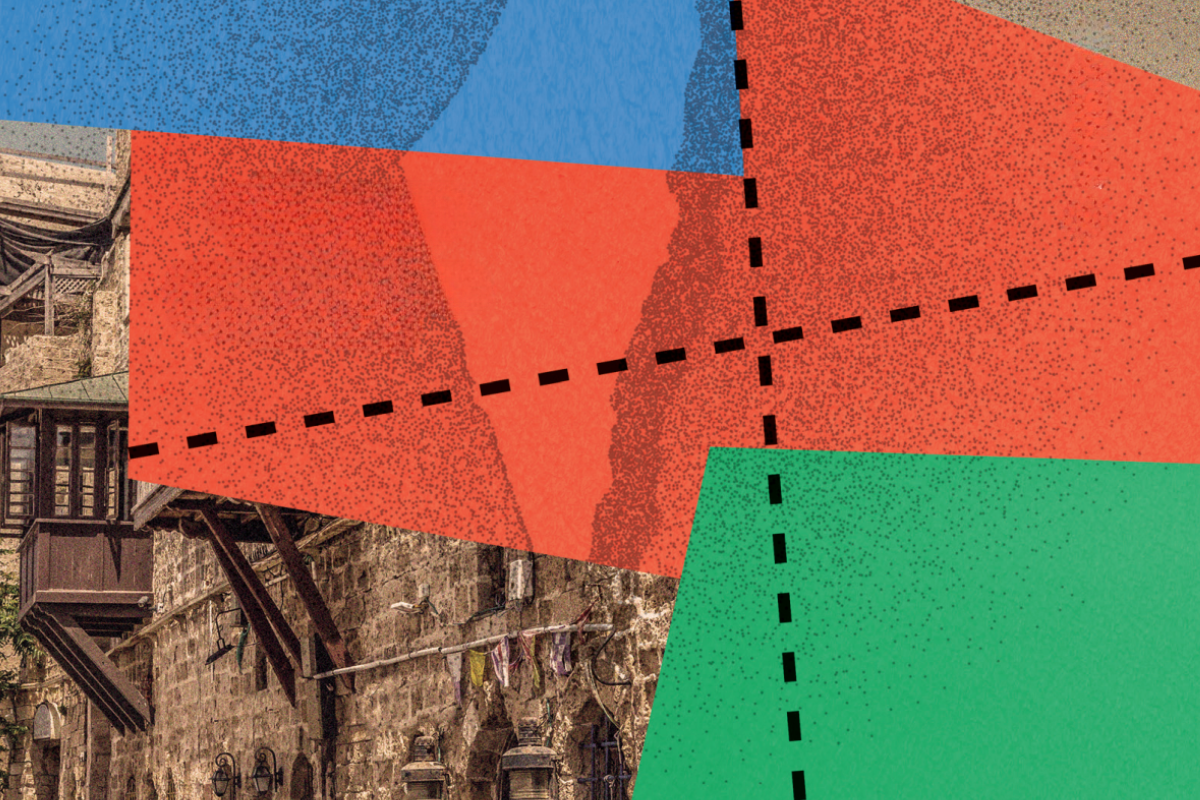Il palestinese che aspetta la guerra civile in Israele
È Imad Abu Awad, giornalista di Al Jazeera incarcerato per nove mesi: ne parla Cecilia Sala nel suo nuovo libro “I figli dell’odio”

Israele non è un paese, sono due: la società, la politica e le istituzioni sono spaccate tra chi crede nello stato di diritto e le fazioni più estremiste e ostili verso la popolazione palestinese. Lo racconta la giornalista Cecilia Sala nel suo nuovo libro, I figli dell’odio, pubblicato da Mondadori e uscito il 2 settembre. Il libro si occupa di tre storie intrecciate fra loro: la guerra in corso da quasi due anni nella Striscia di Gaza, la radicalizzazione di Israele e la condizione delle persone che vivono in Iran, dove Sala stessa è stata incarcerata senza accuse per circa tre settimane lo scorso inverno.
Cecilia Sala sarà ospite della prossima edizione di Talk, a Faenza dal 19 al 21 settembre, e parlerà del libro e di queste storie con Francesco Costa. Il programma è disponibile qui. Di seguito un estratto di I figli dell’odio.
***
Mi sposto in macchina con un guidatore palestinese che conosce la mappa intricata e sempre in aggiornamento di posti di blocco, strade aperte, strade chiuse, code e imprevisti che tocca navigare quando ci si muove in Cisgiordania. È un’ottima cosa, perché a volte per fare trenta chilometri in linea d’aria ci vuole una mattinata di viaggio. Il tempo sotto occupazione si misura in un modo diverso. Il guidatore ha anche un fiuto infallibile per le stazioni di servizio con il carburante al prezzo più basso e per i fruttivendoli con la frutta migliore, che poi alla sera porta ai figli. Ascolta la radio militare israeliana, nella versione trasmessa in arabo.
Prima del 7 ottobre lasciava cadere nei discorsi che aveva amici israeliani come se avesse bisogno di rassicurare gli interlocutori occidentali: guardate che sono un tipo tranquillo. Adesso segue le notizie con la faccia cupa. Anche lui, come un numero infinito di altre persone qui, è rimasto incastrato in una situazione più grande di tutti, fatta di enormità, dove conta chi si posiziona alle ali estreme e non chi sta nel mezzo, anche se chi sta nel mezzo sono milioni. Una maggioranza che più che silenziosa è ammutolita dal dolore. E cerca di barcamenarsi da un anno all’altro, da un posto di blocco all’altro. I ragazzi che fanno parte dei gruppi armati in Cisgiordania, come il figlio di Firas, sono naïf, perché pensano di poter sconfiggere militarmente lo Stato di Israele.
Ma anche Firas, convinto che la diplomazia possa risolvere il problema dell’occupazione, si fa portavoce di una linea che ha già fallito. Entrambi non hanno torto quando criticano la strategia degli altri, ma non riescono a vedere la debolezza della propria. A dirmelo è Imad Abu Awad, quando arrivo nel suo piccolo ufficio al secondo piano di una palazzina di Ramallah. Abu Awad è un giornalista e un analista che lavora per al Jazeera, il canale qatariota che è il più seguito in tutto il mondo arabo. O meglio, lavorava, perché alla fine di settembre del 2024 i soldati israeliani sono entrati nella redazione di al Jazeera a Ramallah per chiuderla. Imad è laureato in Scienze politiche e sta studiando per prendere un dottorato in Filosofia. È un esperto di mondo ebraico, si è specializzato all’università ebraica di Gerusalemme, dice con tono sarcastico che parla l’ebraico meglio dell’arabo, e il suo ruolo dentro al Jazeera era proprio raccontare al pubblico arabo che cosa succede in Israele, cosa dice e cosa fa Benjamin Netanyahu, come i media coprono gli eventi.
Non ha potuto farlo per tanto, però: il 19 ottobre 2023, un paio di settimane dopo i massacri di Hamas nel sud di Israele, un gruppo di soldati si è presentato a casa sua mentre era collegato in diretta con gli studi di al Jazeera in Qatar. Hanno bussato, sono entrati e molto educatamente un militare ha detto che gli dispiaceva ma erano costretti ad arrestarlo. Erano imbarazzati, mi racconta Imad, che ha ancora la faccia scavata, un’eredità della galera da dove è appena uscito. Erano imbarazzati perché avevano l’ordine di trattarlo come un terrorista, ma lo conoscevano e sapevano che considerarlo alla stregua di un uomo di Hamas era ridicolo.
Dieci giorni dopo l’arresto, Imad è stato messo in detenzione amministrativa nella prigione di Nafha, vicino a Beersheba, nel sud di Israele. Detenzione amministrativa significa limbo, reclusione senza accuse e senza un processo, rinnovabile di sei mesi in sei mesi potenzialmente all’infinito: è una pratica utilizzata spesso dalle autorità israeliane, giustificata con il fatto che chi vi è sottoposto sarebbe un pericolo per la sicurezza nazionale e che le informazioni usate per arrestarlo sarebbero troppo confidenziali per essere rivelate in tribunale.
Nei territori occupati la detenzione amministrativa può essere ordinata direttamente dalle autorità militari locali e i criteri sono talmente evanescenti che la sola minaccia è uno strumento d’intimidazione: tutti i palestinesi hanno paura di finire in detenzione amministrativa. Ma ogni tanto anche gli israeliani finiscono in detenzione amministrativa, è successo ad alcuni attivisti, ad alcuni coloni legati alla fazione degli impuniti e, più di recente, a un collaboratore stretto del primo ministro Netanyahu – sotto indagine da parte dello Shin Bet.
Quando è toccata a lui, Imad è rimasto in prigione per nove mesi, è entrato con le guance paffute ed è uscito con le ossa degli zigomi che sporgono di due centimetri e le occhiaie blu. In cella ha perso diciotto chili. Erano in quattordici in uno spazio pensato per ospitare sei detenuti. A pranzo veniva servita una tazzina da caffè piena di riso condito che non avrebbe sfamato un gatto. In quasi un anno non ha mai potuto vedere qualcuno della sua famiglia e ha incontrato il suo avvocato soltanto una volta.
Ma di tutto questo parla con distacco, come se stesse raccontando l’esperienza di qualcun altro o un fatto storico del secolo scorso e non un trauma che ha vissuto in prima persona fino a poche settimane fa. Non so se questo tono gli venga naturale, perché è un analista, o se si sforzi di accantonare le emozioni per non compromettere l’autorevolezza quasi scientifica che conta di avere – quella di chi non vuole parlare di un sistema perché ne è vittima ma perché, dopo anni di studio, ne è esperto. Imad dice che è finito in carcere per colpa di un pezzo di Israele e ne è uscito grazie all’altro pezzo di Israele, che il paese è spaccato in due e che i palestinesi dovrebbero prestare più attenzione a questo stato di cose.

Procedendo per ragionamenti asciutti, Imad mi dice che in carcere si è fatto un’idea di un altro tipo di soluzione, diversa e «più concreta, più realistica, più attuale» rispetto a quella diplomatica di Firas e a quella violenta in cui credeva il figlio Samih. Secondo Imad, la soluzione più probabile a tanti problemi dei palestinesi arriverà da una guerra civile in Israele. Perché «quando si punteranno i fucili addosso gli uni contro gli altri avranno meno fucili da usare contro di noi» – il tono è sempre quello impassibile da analista, ma adesso è meno chiaro se stia formulando una previsione o un desiderio. I palestinesi hanno pochi mezzi, poco spazio di manovra, all’estero hanno molti simpatizzanti ma pochi sostenitori veri, poche alleanze internazionali. Israele invece ha le risorse e un’energia devastante, che però fa male anche a se stesso – prosegue nel ragionamento.
Il collasso di Israele non verrà da fuori ma da dentro, così s’immagina Imad, dalla collisione con gli alleati e soprattutto dalla collisione secondo lui inevitabile tra i due Israele, tra il paese che crede nello Stato di diritto e il paese degli estremisti. E i palestinesi forse sapranno cogliere l’occasione e usarla a proprio vantaggio. Non è una cosa che pensa soltanto Imad, è un presagio apocalittico che coltivano anche alcuni israeliani.
Un anno dopo il 7 ottobre, più o meno quando Imad è stato liberato dalla detenzione amministrativa, il quotidiano più critico dello status quo, «Haaretz», ha scritto che «la guerra ha fermato la guerra civile». L’analisi è la seguente: per tutto il 2023 il paese è stato spaccato in due dalle proteste contro la riforma giudiziaria voluta da Netanyahu, che non era una semplice riforma, ma una vera ristrutturazione delle istituzioni volta a indebolire la Corte suprema con il risultato di dare più mano libera al potere esecutivo, in un paese che non ha una Costituzione e dove la Corte suprema è l’unico argine. I manifestanti chiamavano la riforma «il colpo di Stato». Per la gente in piazza significava essere a un bivio storico tra la democrazia (dentro i confini del 1948) e lo scivolamento verso un tipo di nazione un po’ autocratica e un po’ messianica.
Entrambe le parti erano pronte a uno scontro e dopo il 7 ottobre tutta questa energia ha trovato una valvola di sfogo a Gaza. Ma prima o poi, ha scritto un’editorialista di «Haaretz», la guerra a Gaza deve finire e tutta quell’energia dovrà tornare a scatenarsi dentro Israele. A quel punto il conflitto potrebbe trasformarsi. Secondo un sondaggio dell’agosto 2024, quasi la metà degli israeliani, il 46 per cento, teme una guerra civile nel proprio paese. Gli stessi intervistati indicano come figure «divisive» che hanno portato a un’esasperazione violenta dentro alla società israeliana il primo ministro Netanyahu e i leader della fazione degli impuniti Ben-Gvir e Smotrich.
Secondo Imad Abu Awad, che su questo tema sta scrivendo un libro, Israele non è un paese solo, ma due paesi in uno. C’è Israele, e poi c’è un altro Israele più piccolo al suo interno che è intenzionato a espellere e sostituire il primo. Il primo è l’Israele a cui appartengono Daniel Seidemann e Gershon Baskin, ma anche il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e i vertici delle forze di sicurezza che credono nello Stato di diritto di cui parlava Ronen Bergman, l’Israele che vede l’ascesa degli impuniti come una minaccia esistenziale. Il secondo è l’Israele dei ministri Ben-Gvir e Smotrich, dei poliziotti e dei soldati loro seguaci, che festeggiano quando, dopo i massacri a Gaza, migliaia di israeliani progressisti con la doppia cittadinanza lasciano il paese perché si sentono a disagio. «Non vogliono liberarsi soltanto di noi palestinesi, ma anche di tutti quegli israeliani che non accetterebbero mai il loro progetto e mettono i bastoni tra le ruote del loro sogno» mi dice Imad. Il loro Israele è quello sognato da Meir Kahane. Vuole prendersi le istituzioni per poi prendersi tutto «dal fiume al mare».

Una protesta a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi e contro il governo di Benjamin Netanyahu, il 23 agosto del 2025 (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
Non è una divisione tra destra e sinistra, è una divisione tra chi crede nelle regole e i fanatici, tra pragmatici e messianici, tra apparati che mettono al primo posto la sicurezza e apparati che mettono al primo posto la supremazia. Il primo Israele è ai vertici dell’intelligence, il secondo controlla la polizia e ha dalla sua parte i coloni con i fucili. Entrambi i fronti sono armati, nota Imad. La stessa liberazione di Imad Abu Awad è stata un esempio dello scontro tra i due Israele.
Il solo modo per opporsi alla detenzione amministrativa è fare ricorso a un tribunale militare o alla Corte suprema – Imad ha usato l’unico incontro che gli è stato concesso con il suo avvocato per chiedergli di fare esattamente questo. La Corte suprema ha chiesto allo Shin Bet, il servizio d’intelligence interno, se Imad e tanti altri fossero giustamente sospettati di avere legami con Hamas e se fossero pericolosi. Lo Shin Bet del direttore Ronen Bar ha risposto di no, e ha detto: liberateli subito. Imad è uscito assieme a una cinquantina di altri prigionieri palestinesi, tra cui Mohammed Abu Salmiya, il medico direttore dell’ospedale al Shifa, il più grande di Gaza, oggi distrutto dall’artiglieria israeliana.
Con il suo cranio lucido e la faccia sempre mogia, Bar è un uomo dei servizi segreti, non è un pacifista, non è un prete o un umanitario. Però non è un kahanista e chiama «terroristi» gli estremisti che sparano ai palestinesi in Cisgiordania e appiccano il fuoco alle loro case mentre dormono. Dopo le liberazioni, Bar ha fatto di più. Ha spedito una lettera al primo ministro Netanyahu e al ministro della Sicurezza nazionale Ben-Gvir in cui dice una cosa pesante e precisa: i 21 mila palestinesi nelle carceri israeliane sono tenuti in condizioni così brutali che se il primo ministro e il ministro non avessero preso provvedimenti subito si sarebbero trovati con nuove accuse da parte della Corte penale internazionale dell’Aia. La lettera era un modo con cui l’Israele dello Stato di diritto cercava di combattere l’altro Israele. E difatti Ben-Gvir si è arrabbiato, ha protestato, ha minacciato Bar e ha detto che se proprio si dava pensiero del sovraffollamento delle carceri israeliane, allora la soluzione per svuotarle era istituire la pena di morte.
È sui prigionieri palestinesi come Imad che si è visto per ora lo scontro più esplicito tra i due Israele dopo il 7 ottobre. È successo con il caso della base militare convertita in carcere speciale di Sde Teiman: nove soldati sono stati formalmente accusati di avere stuprato un detenuto palestinese. La polizia militare è andata ad arrestarli e i loro commilitoni hanno scatenato una rivolta per impedirlo, hanno disobbedito agli ordini, hanno cominciato a picchiare i loro colleghi che volevano far rispettare la legge. Erano aiutati da civili estremisti, compreso il ministro del Patrimonio culturale, accorsi in armi alla base. Militari del primo Israele da una parte, militari e civili armati del secondo Israele dall’altra. Un episodio che Imad ha letto come una premonizione della guerra civile che sogna.
Imad fa parte della maggioranza più che silenziosa ammutolita dal dolore. Imad, come la maggioranza dei palestinesi, non crede sul serio di poter sconfiggere Israele a pietre e fucilate. Come la maggioranza dei palestinesi, non crede più alla diplomazia. Come la maggioranza dei palestinesi, non si fida dei leader del suo popolo. Ed è sullo scontro tra gli israeliani della tipologia di Ronen Bar e quelli della tipologia di Itamar Ben-Gvir che punta un palestinese senza carte in mano come lui. Tifa l’implosione dall’interno di un nemico troppo forte, perché non sa più in che altro sperare.
© 2025 Mondadori Libri S.p.A., Milano