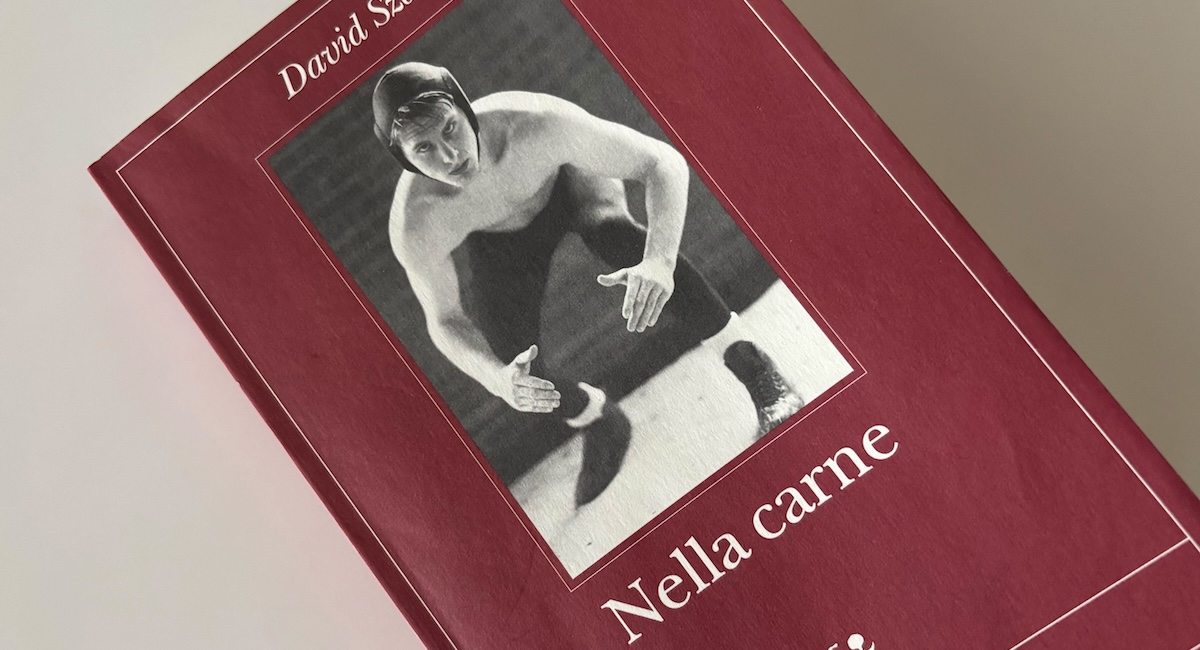Ha senso inserire il reato di femminicidio nel codice penale?
Il governo sta cercando di farlo, e nel frattempo si è sviluppato un ampio dibattito tra esperte ed esperti di diritto
di Giulia Siviero

A marzo su iniziativa del governo è stato presentato un disegno di legge per introdurre nel codice penale, sull’esempio di altre legislazioni, il reato di femminicidio, punito con l’ergastolo. Dopo un passaggio in commissione Giustizia del Senato, giovedì 10 luglio maggioranza e opposizioni hanno raggiunto un accordo sul testo la cui discussione inizierà in aula martedì 15 luglio.
Il disegno di legge (il numero 1433) ha come obiettivo dichiarato quello di «rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne». Fin dal suo annuncio, fatto dal governo lo scorso 8 marzo nella Giornata internazionale della donna, ha aperto un grande dibattito tra giuristi, magistrati, avvocati, associazioni, reti che si occupano di contrasto alla violenza maschile contro le donne e movimenti femministi.
Da una parte la discussione ha riguardato e riguarda punti specifici del testo per come è stato proposto: hanno soprattutto a che fare con la definizione della nuova fattispecie penale, che era stata inizialmente criticata in modo quasi unanime e poi modificata. Dall’altra parte ha avuto invece a che fare con l’opportunità stessa di introdurre nell’ordinamento italiano il reato di femminicidio. E su questo ci sono posizioni molto diverse.

Un’installazione, composta da centinaia di sagome bianche in ricordo delle vittime di femminicidio, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Roma, 23 novembre 2017 (Matteo Minnella/A3/Contrasto)
Chi è contrario all’introduzione della fattispecie di femminicidio nel codice penale ha principalmente due motivazioni: non lo ritiene necessario e pensa che non sia efficace. Anche se non ci sono riferimenti alla violenza di genere, nel codice penale italiano ci sono infatti alcune ipotesi di omicidio aggravato che colpiscono, punendole con le pene detentive più severe, la maggior parte delle uccisioni che possono essere definite femminicidi, come dimostrano il caso di Giulia Cecchettin e l’ergastolo dato al suo femminicida Filippo Turetta.
L’hanno scritto in un appello reso pubblico subito dopo la presentazione del disegno di legge sul femminicidio decine di giuriste di varie università italiane, così come, tra le altre, l’organizzazione non governativa ActionAid. Dicono che i dati sui femminicidi sono rimasti sostanzialmente stabili negli ultimi anni, mostrando che la questione è strutturale e non emergenziale: per questo ritengono che la risposta più adatta non sia l’introduzione di una nuova fattispecie di reato, ma una strategia di prevenzione a medio e lungo termine che ragioni sull’insieme delle pratiche sociali, politiche, pubbliche e istituzionali che di fatto giustificano o favoriscono la violenza maschile. Secondo questo approccio, insomma, si deve partire dall’inizio e non dalla fine: non dalla pena, ma dall’educazione e da una trasformazione sociale.
Dal punto di vista della dottrina penalistica, dunque, la nuova fattispecie non sarebbe giustificata dall’obiettivo di colmare un vuoto di tutela, non funzionerebbe come fattore di deterrenza e non avrebbe alcuna funzione pedagogica. Diversi esperti di diritto ritengono anzi che rischierebbe di avere un valore solo simbolico e di sconfinare nel cosiddetto “panpenalismo”, nella tendenza cioè a delegare al diritto penale (e quindi, in sostanza, alla sola repressione) problemi legati a fenomeni sociali complessi: un approccio che il governo Meloni ha già adottato su molte questioni, e già molto criticato. In un suo recente intervento il giudice del tribunale di Milano Fabrizio Filice ha detto che il panpenalismo e il diritto penale simbolico «sono storicamente indici di una abdicazione della politica al proprio ruolo di risolvere le problematiche più profonde della convivenza civile e di promuovere cambiamenti sociali e culturali».
Puntare sulla prevenzione invece che sulle misure simboliche comporterebbe per il governo anche un altro problema: stanziare dei soldi. Lo ha fatto notare tra gli altri Gian Luigi Gatta, presidente dell’Associazione italiana dei professori di Diritto penale (AIPDP) e direttore delle riviste Sistema penale e Diritto penale contemporaneo, insieme ad altri giuristi.
Uno degli articoli del ddl sul femminicidio stabilisce proprio una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall’attuazione della legge non devono «derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Gatta spiega che la norma non prevede «alcun investimento per la prevenzione del fenomeno che si intende contrastare». E «inspiegabilmente, non vi è nemmeno una copertura finanziaria per le attività formative dei magistrati» sulla violenza contro le donne, nonostante queste siano previste all’articolo 4 del disegno di legge. Molte e molti insomma hanno visto la proposta del governo Meloni come l’espressione di un populismo a costo zero, e hanno criticato l’uso del diritto penale come strumento per aumentare il consenso politico.
Secondo il giudice Filice, l’introduzione del reato di femminicidio potrebbe avere senso oltre all’intento simbolico-promozionale se portasse effettivamente un’estensione di tutela ai tanti casi che ora non ce l’hanno.
In base alla disciplina attuale, per il reato di omicidio aggravato si applicano la pena dell’ergastolo o la reclusione da ventiquattro a trent’anni se autore e vittima erano in un determinato rapporto: di parentela, coniugale, se avevano o avevano avuto una relazione affettiva, o se l’omicidio è stato commesso insieme ad altri reati come la deformazione dell’aspetto della persona con lesioni permanenti al viso o la violenza sessuale. Restano però esclusi diversi casi che non sono riconducibili a queste aggravanti, ma che si possono comunque collegare al femminicidio e ai moventi di genere che ne stanno alla base. Filice cita «gli omicidi di donne incontrate casualmente per strada da uomini che maturavano la “fantasia di uccidere” e che hanno, anche inconsapevolmente, nutrito quella fantasia negli stereotipi di genere, in modo tale da arrivare a scegliere, non casualmente, una vittima donna». E poi cita gli omicidi di donne trans.
Buona parte delle critiche si basa dunque sul fatto che il nuovo reato di femminicidio non dà, come dovrebbe, copertura a tutti i casi di omicidi che hanno motivazioni di genere, creando disuguaglianze rispetto ad altre vittime che, sulla base del genere, possono essere altrettanto discriminate. Il criterio scelto dal legislatore per strutturare il reato di femminicidio, spiega Filice, àncora invece la ragione dell’incriminazione al sesso della vittima, alle donne nate biologicamente femmine. Ma la causa della violenza di genere, prosegue il giudice, «non risiede in una ragione di ostilità pregiudiziale verso le caratteristiche biologiche della donna (…) sta, invece, nella sovrastruttura di genere che è una sovrastruttura sociale di oppressione». E questa non colpisce solo le donne nate biologicamente donne.
Più in generale, molta contrarietà all’introduzione di un reato di questo tipo riguarda il fatto che smantellerebbe la neutralità del sistema giuridico italiano, differenziando le fattispecie di omicidio in ragione del sesso della vittima. Per Gatta, ad esempio, limitare la fattispecie a una persona offesa che sia “donna” «introduce una irragionevole disparità di trattamento rispetto all’uccisione (…) realizzata da un uomo nei confronti di un altro uomo, nell’ambito di relazioni omosessuali», oppure, anche se è più raro, «da una donna nei confronti di un uomo».
Infine, come notato da Giovanni Fiandaca, professore emerito di diritto penale presso l’università di Palermo, «la delega alla giustizia penale, se è politicamente comoda perché deresponsabilizza il ceto politico, presenta per altro verso un serio inconveniente pratico: il continuo aumento dei reati ingolfa sempre più la macchina giudiziaria, contribuendo ad aggravare la lentezza dei processi».
A molte di queste obiezioni ha risposto in modo argomentato e puntuale, tra le altre e gli altri, la giudice di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini, esperta in materia e autrice di diversi libri, che pur non condividendo alcuni passaggi specifici del ddl ne difende la necessità.

La giudice di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini, fotografata all’università La Sapienza, Roma, marzo 2023 (Tania/Contrasto)
Di Nicola Travaglini spiega come il paradigma classico del diritto penale sia la neutralità dei delitti rispetto al sesso. Il diritto continua cioè a professare il principio dell’uguaglianza formale, secondo il quale vi è un medesimo statuto giuridico per tutti i cittadini e per tutte le cittadine di fronte alla legge. Ma questo principio, dice, è un mito da decostruire: da una parte perché le donne sono storicamente soggette a strutturali forme discriminatorie “in quanto donne”, dall’altra perché, mentre questo principio veniva teorizzato e difeso, nel codice penale italiano sopravvivevano «nel silenzio generale» articoli come quelli sul “matrimonio riparatore” e sull’“omicidio per causa d’onore”, cancellati dal codice nel 1981: il primo prevedeva l’estinzione del reato di violenza sessuale in caso di matrimonio tra l’autore del reato e la vittima; il secondo era un’attenuante speciale per chi uccideva la moglie, la figlia o la sorella dopo aver scoperto quella che veniva definita una «illegittima relazione carnale». Entrambi delitti che convalidavano, anche istituzionalmente, un sistema basato su diseguaglianze e oppressioni.
Detto altrimenti: la disuguaglianza nelle relazioni tra donne e uomini costituisce un dato di fatto storico e universale, di cui la violenza e il femminicidio sono una delle più esplicite rappresentazioni. Per Di Nicola Travaglini il diritto non può accontentarsi di una falsa neutralità, ma deve tenere conto di questo dato di partenza che è solo delle donne, le quali devono costituire di conseguenza un soggetto giuridico autonomo diverso da qualsiasi altro. Questo affinché possano ottenere un’effettiva posizione di uguaglianza che attualmente non hanno: «A fronte dei “diritti di carta” delle donne esistono obblighi effettivi e sostanziali dello Stato di attivare azioni positive per garantirli», dice Di Nicola Travaglini. Assumere una prospettiva di genere implica allora «di dare un corpo sessuato ai protagonisti della vicenda giuridica» e di sostenere nel codice penale la tipizzazione del delitto di femminicidio, cosa che le fonti sovranazionali in materia hanno già fatto: il delitto di femminicidio, dice Di Nicola Travaglini, «per la prima volta nella storia giuridica del nostro paese consentirà di rendere visibile la violenza contro le donne e il contesto su cui si consuma, non più celata dietro termini neutri».
Tutto questo secondo lei non viola affatto il fondamentale diritto di uguaglianza e di non discriminazione tra uomini e donne: non costituirebbe insomma una discriminazione al contrario, cioè ai danni degli uomini. L’articolo 4 della Convenzione di Istanbul che l’Italia ha ratificato nel 2013, ricorda Di Nicola Travaglini, non solo impone agli stati di «assumere le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere», ma aggiunge che queste misure «non saranno considerate discriminatorie».
Come riconosciuto anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, si può parlare di discriminazione giuridica nel caso in cui la differenza di trattamento non abbia un’oggettiva e ragionevole giustificazione. Il fatto che vi siano presupposti di fatto disuguali basati sul sesso e che le donne subiscano molto più degli uomini atti di violenza basata sul genere può essere considerata una giustificazione oggettiva e ragionevole per assumere misure che vadano solo a beneficio delle donne vittime di quella violenza.
Per quanto riguarda l’accusa di panpenalismo fatta al ddl, Di Nicola Travaglini dice che tale rischio non è mai stato evocato in occasione dell’introduzione di altri delitti, come quello di associazione di tipo mafioso. La giudice inoltre contesta che venga citato il panpenalismo per un delitto già previsto e punito dal codice penale con l’ergastolo (quello di omicidio), un delitto «di cui il legislatore si sta preoccupando soltanto di specificare il contesto nel quale si consuma».
Rispondendo alle critiche sulla mancanza di finanziamenti presente nel ddl per la formazione dei magistrati o degli altri soggetti istituzionali coinvolti, come avvocati o polizia, la giudice dice che tali soggetti hanno delle scuole proprie «che non hanno bisogno di soldi o di finanziamenti». Secondo la giudice non servono dunque investimenti nelle scuole di formazione, ma piuttosto occorre rendere la formazione obbligatoria.

Uno dei cartelli alla manifestazione femminista di Non Una Di Meno a Roma, 8 marzo 2024 (Tania/Contrasto)
Infine, inserire il femminicidio nel codice penale non creerebbe alcun conflitto con una strategia di prevenzione, per Di Nicola Travaglini: «È evidente che la prevenzione è una priorità assoluta, ma porre in alternativa la punizione con la prevenzione non ha alcun senso e questo in relazione a qualsiasi tipo di fenomeno criminale, come lo sfruttamento in agricoltura o gli incidenti sul lavoro».
Di Nicola Travaglini dice che i femminicidi non diminuiranno dando loro un nome e un riconoscimento specifico nel codice penale, ma in questo modo esisteranno: «Quando si nomina si pensa e, dunque, si costruiscono le categorie indispensabili per prevenire». Di Nicola Travaglini fa il paragone con il reato di associazione di tipo mafioso: «Nessuno ha mai neanche immaginato che la previsione del delitto di associazione di tipo mafioso riducesse la criminalità organizzata in Italia e nel mondo. Ciononostante nessuno può negare che abbia costituito un potentissimo strumento culturale e giuridico». In modo simile l’effetto della tipizzazione del delitto di femminicidio favorirà indirettamente «la crescita della coscienza sociale e culturale del paese», permetterà di avere «connotazioni omogenee del delitto da parte di tutti i soggetti che, a livello istituzionale o sociale, sono chiamati ad occuparsene, imporrà di prevedere altrettanto omogenee linee-guida di formazione di tutti gli operatori (giudiziari, sanitari, scolastici, sociali, eccetera), e renderà evidente il livello di considerazione che di tale delitto ha lo stato».
Per Di Nicola Travaglini, con una fattispecie di femminicidio correttamente tipizzata, «non leggeremo più che una donna è stata uccisa da un uomo che non ha accettato la separazione, ma leggeremo che un uomo ha ucciso una donna perché questa voleva essere libera e lui non glielo consentiva. E questa è un’inversione dei termini epocale».