Il declino del mito di Lenin
Raccontato da Enrico Franceschini nel suo ultimo libro, con gli articoli di quando era corrispondente di Repubblica negli ultimi mesi dell'Unione Sovietica
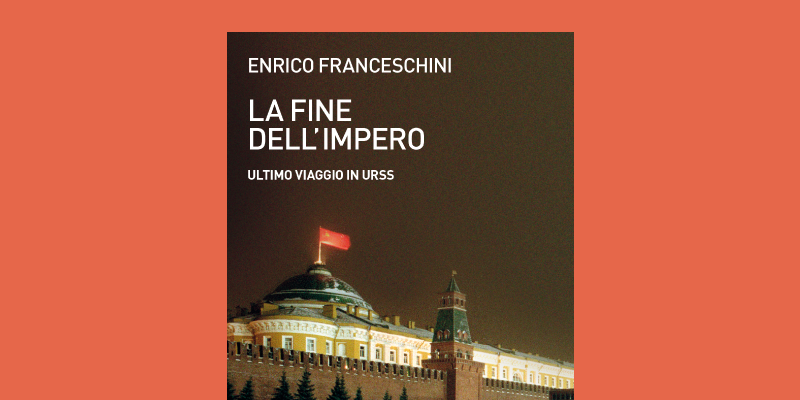
Lo scorso 28 gennaio è uscito La fine dell’impero, l’ultimo libro del giornalista Enrico Franceschini, a lungo corrispondente di Repubblica negli Stati Uniti, in Russia, in Israele e nel Regno Unito. Il libro è della casa editrice Baldini + Castoldi e raccoglie gli articoli che Franceschini scrisse tra l’agosto 1990 e il dicembre 1991, mentre si trovava a Mosca e assisteva al crollo dell’Unione Sovietica. Partendo dai benzinai russi a corto di benzina e passando per l’amore dei lettoni nei confronti di Giuseppe Verdi, il libro racconta le storie e le contraddizioni di un territorio sterminato, quello delle repubbliche socialiste sovietiche.
– Leggi anche: La scissione da cui nacque il Partito Comunista d’Italia
Franceschini partì per Mosca quando aveva 34 anni, attratto dal lavoro che avevano svolto altri giornalisti come Alberto Ronchey, Paolo Garimberti, Arrigo Levi e Vittorio Zucconi. «Ero eccitato, carico di aspettative e anche spaventato dalla prova che mi attendeva», scrive Franceschini. «Eppure, non mi rendevo pienamente conto che stavo per assistere a un evento unico, irripetibile, straordinario». Di seguito pubblichiamo uno dei capitoli del libro, in cui si racconta quando il corpo del primo leader sovietico Vladimir Lenin rischiò di essere portato via dal mausoleo che ancora oggi si trova a Mosca, nella Piazza Rossa.
***
Mosca. Lungamente annunciata, la battaglia per portare via Lenin dalla Piazza Rossa sembra sul punto di esplodere. La coda davanti al mausoleo è sempre più corta, lamenta un articolo su «Stella Rossa», il quotidiano delle Forze Armate sovietiche. E il famoso regista teatrale Mark Zakharov insiste per seppellire altrove il corpo di Vladimir Ilich. Ma spostare il corpo del padre della rivoluzione farebbe franare le già barcollanti fondamenta del socialismo. E per ora nessuno si decide ad abbattere un simbolo così potente. È vero che la fila si è assottigliata. A mezzogiorno, con la Piazza Rossa riscaldata da un pallido sole, ieri non c’erano più di trenta persone in attesa davanti all’ingresso; mentre a pochi metri di distanza, sulla porta dei grandi magazzini Gum, la gente faceva il giro dell’isolato per acquistare una provvidenziale fornitura di scarpe invernali, bene di prima necessità raro da trovare di questi tempi.
Se Lenin potesse vedere il sistema da lui creato settantatré anni or sono, non lo riconoscerebbe. Nell’Urss di questo ottobre 1990, pope ortodossi fanno processioni salmodianti dentro le mura del Cremlino, nascono leggi sulla libertà di stampa e sul pluralismo, Gorbaciov avanza piccoli passi verso un’economia capitalista. E fra i miti infranti, dopo Breznev e Stalin, viene sempre più frequentemente calpestato anche quello del fondatore dell’impero comunista. Le sue statue vengono demolite in decine di piazze di tutta la nazione: venerdì, in Bielorussia, un uomo si è ucciso dandosi fuoco davanti a una. Intellettuali di simpatie radicali, come il regista Zakharov, e i più irreverenti giornali della glasnost, pronunciano appelli a trasferirlo sottoterra, affinché il suo «spirito maligno» non aleggi sulla Piazza Rossa. Quest’anno i sindaci di Mosca e Leningrado non vogliono celebrare la festa più permeata dal nome di Lenin, l’anniversario della rivoluzione d’Ottobre, e un gruppo di deputati del parlamento russo chiede di abolirla per sempre. Uno di loro, Sergej Juscenkov, spiega perché in un durissimo articolo sull’ultimo numero del settimanale «Sojuz»: «Nell’ottobre di settantatré anni fa», scrive, «una minoranza estremistica prese il potere imponendo alla Russia una dittatura che è stata causa di tragedie, massacri, violazioni di massa dei diritti umani e devastazione dell’economia. L’elenco dei crimini commessi in nome del leninismo è infinito. Tutte le idee che portarono il popolo dalla parte dei bolscevichi non sono state realizzate. I contadini non hanno la terra, gli operai lavorano quasi gratis per lo sfruttatore più avaro del mondo, l’apparato partitico-statale, e mancano case, pane, vestiti, medicine. Festeggiare la rivoluzione sarebbe immorale. Forse si dovrebbe celebrare un giorno di lutto e di dolore, perché settantatré anni or sono fu commesso il più grandioso inganno del Novecento».
Gli attacchi sono diventati così aperti e intensi da far credere che Lenin non resterà a lungo nel mausoleo visitato per decenni da milioni di persone. Furono gli esperti della appositamente creata Commissione Immortalizzatrice a imbalsamarlo sei giorni dopo la sua morte, nel 1924, per volere di Stalin, contro il parere di Trotzkij, di Bucharin e della vedova, che fino all’ultimo pregò di non trasformarlo in un’icona. Durante la seconda guerra mondiale, nel timore che i nazisti arrivassero a Mosca, il corpo fu trasferito segretamente a Perm, su uno speciale treno anti-vibrazioni, per evitare che il delicato lavoro di imbalsamazione andasse in frantumi. Da allora, Lenin ha subìto regolari lavori di restauro, l’ultimo nel 1989, quando il mausoleo è rimasto chiuso per tre mesi. Il dottor Sergheij Debov, dal 1950 curatore del sacro corpo custodito sulla Piazza Rossa, non ha mai rivelato quali operazioni siano necessarie per mantenere intatta la sua immagine. «È un segreto di Stato», afferma. A Mosca gira da tempo la voce che il Lenin del mausoleo sia in gran parte ricostruito artificialmente, come ha lasciato intendere l’anno scorso un deputato radicale, Yuri Kariachin, in un appassionato discorso al Congresso del popolo: «Provo orrore», ha detto, «a pensare al corpo di Lenin, ritoccato dalla mano di medici e artisti, trasformato in un’attrazione turistica».
Siamo andati anche noi a vederlo, ieri mattina, con una comitiva di turisti stranieri, qualche sovietico di provincia, l’immancabile coppia di sposi che depone una corona di fiori davanti al mausoleo, una tradizione socialista. Superata la guardia d’onore, si scende una lunga, ripida scala di marmo nero, che sembra portare nelle viscere del Cremlino e della storia. In fondo alla scala, in una stanza buia come la sala di un acquario, circondato da un picchetto di soldati, Vladimir Ilich giace dentro un sarcofago di vetro, il volto illuminato da un fiotto di luce, gli occhi chiusi, una mano leggermente contratta. Talmente perfetto da sembrare finto come le statue del Museo delle cere. È permesso restare a guardarlo per pochi secondi, poi si torna all’aperto, seguendo un percorso obbligato, fra tombe e lapidi, ciascuna adornata da un mazzetto di rose rosse, lungo le mura del Cremlino: Stalin, Kossighin, Breznev, Andropov, Chernenko, decine di eroi grandi e piccoli della rivoluzione, compreso il giornalista John Reed, l’autore di I dieci giorni che sconvolsero il mondo, l’unico americano sepolto in questo sacrario del socialismo. Tra i visitatori, solo un vecchietto con la medaglia di guerra sulla giacca appare sinceramente commosso. «Come è bello, Vladimir Ilich», mormora uscendo. «Ormai è l’unica cosa che ci resta. Speriamo che non lo portino mai via.»
© 2021 Baldini+Castoldi s.r.l. – Milano



