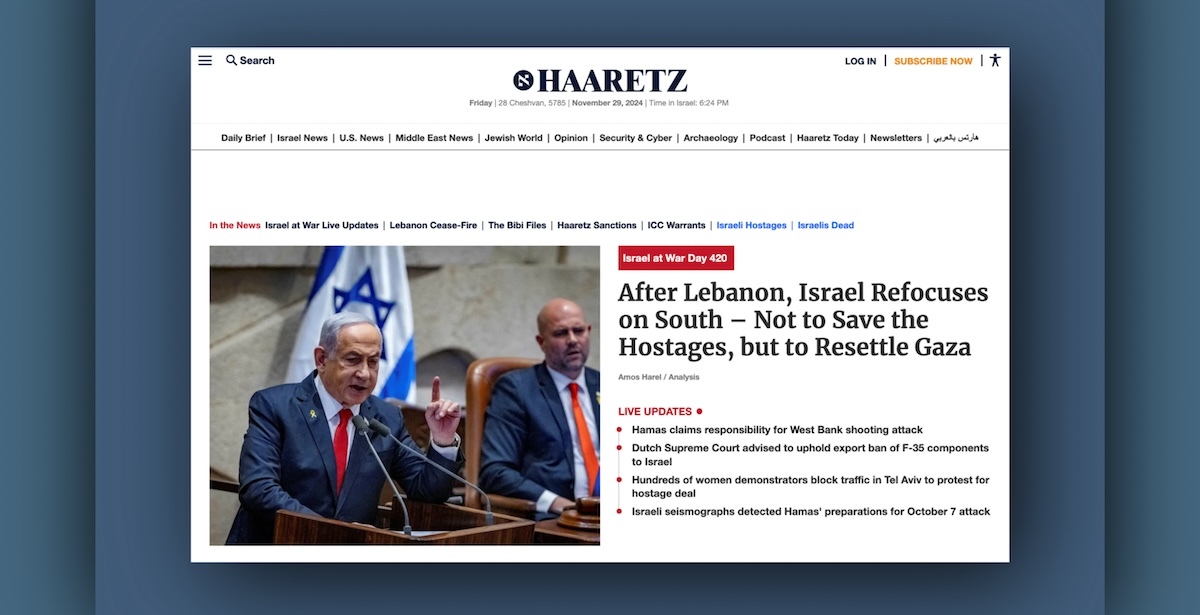L’editoriale di Massimo Giannini dalla terapia intensiva
Il direttore della Stampa, malato di COVID-19, racconta cosa ha visto e cosa ha pensato dopo cinque giorni di ricovero insieme ai pazienti più gravi

Il direttore della Stampa Massimo Giannini, che si è ammalato di COVID-19, ha scritto oggi un editoriale dalla terapia intensiva, dove è ricoverato da cinque giorni. Raccontando com’è la situazione che vede e che sente da medici e infermieri, e riflettendo sulle cose che non sono state fatte per prepararsi alla seconda ondata di contagi da coronavirus, nonostante mesi di discorsi sulla loro urgenza e necessità.
«Oggi “festeggio” quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ospite ingrato che mi abita dentro» dice Giannini, spiegando le sue condizioni: «Gli ultimi cinque giorni li ho passati in terapia intensiva, collegato ai tubicini dell’ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro».
Quando sono entrato in questa terapia intensiva, cinque giorni fa, eravamo 16, per lo più ultrasessantenni. Oggi siamo 54, in prevalenza 50/55enni. A parte me, e un’altra decina di più fortunati, sono tutti in condizioni assai gravi: sedati, intubati, pronati. Bisognerebbe vedere, per capire cosa significa tutto questo. Ma la gente non vuole vedere, e spesso si rifiuta di capire. Così te lo fai raccontare dai medici, dagli anestesisti, dai rianimatori, dagli infermieri, che già ricominciano a fare i doppi turni perché sono in superlavoro, bardati come sappiamo dentro tute, guanti, maschere e occhiali. Non so come fanno. Ma lo fanno, con un sorriso amaro e gli occhi: «A marzo ci chiamavano eroi, oggi non ci si fila più nessuno. Si sono già dimenticati tutto…». Ecco il punto: ci siamo dimenticati tutto.
Giannini racconta poi che dopo un editoriale scritto domenica scorsa sull’impreparazione generale alla seconda ondata aveva ricevuto molte telefonate, tra cui quelle del ministro della Salute Roberto Speranza e del presidente della Campania Vincenzo De Luca, ascoltando «il solito scaricabarile italiano» di responsabilità. Dopo aver elencato vari esempi di meccanismi che non funzionano o stanno per smettere di funzionare, nonostante i mesi di tempo per prepararli, continua raccontando la sua situazione: «Ho infettato anche mia madre, novantenne, malata oncologica, vive sola, come migliaia di anziani, eppure non c’è servizio domiciliare che possa supportarla né medico di base che vada a visitarla».
Non recrimino, non piango. Vorrei solo un po’ di serietà. Vorrei solo ricordare a tutti che anche la retorica del «non possiamo chiudere tutto» cozza contro il principio di realtà, se la realtà dice che i contagi esplodono. Se vogliamo contenere il virus, dobbiamo cedere quote di libertà. Non c’è altra soluzione. Chiudi i locali notturni? Fai il coprifuoco? Aumenti lo smartworking? Ci sarà un conto da pagare, è evidente. Il lockdown totale di inizio 2020 ci costò 47 miliardi al mese e un dimezzamento di fatturato, valore aggiunto e occupazione nazionale. Oggi non dobbiamo e non vogliamo arrivare fino a quel punto. Ma qualcosa in più di quanto abbiamo fatto con l’ultimo Dpcm è doveroso.
Chi subisce perdite ulteriori dovrà essere risarcito. Il governo ha risorse da reperire, se solo la piantasse di tergiversare sul Mes o non Mes. Aziende e sindacati hanno interessi da condividere, se solo la finissero di inseguire un assurdo conflitto sociale a bassa intensità. La pandemia sta accorciando ancora una volta il respiro della nostra democrazia. Provare a impedirglielo tocca solo a noi. Scambiando la rinuncia di oggi con il riscatto di domani.