Il romanzo di Marco Missiroli per disattenti
Come comincia uno dei romanzi più apprezzati e discussi del 2015, di cui venerdì si parla (col Post) al Festival di Pescara
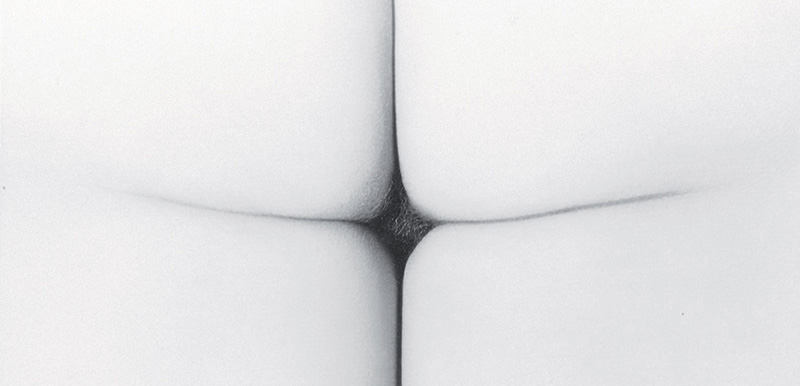
Venerdì al FLA di Pescara – il festival di letteratura e giornalismo organizzato in collaborazione col Post – si parla tra le altre cose del libro di Marco Missiroli, che è stato uno dei romanzi più apprezzati e discussi del 2015: “Atti osceni in luogo privato” (Feltrinelli). E insieme a lui, di come si fa lo scrittore di questi tempi: a intervistare Missiroli è Giacomo Papi, scrittore e giornalista a sua volta (il suo nuovo romanzo I fratelli Kristmas. Un racconto di natale esce il 24 novembre), e collaboratore del Post nella sua sezione Libri. Marco Missiroli ha 34 anni, è di Rimini, e ha pubblicato il suo primo romanzo che ne aveva 24, vincendo il premio Campiello Opera Prima nel 2006.
*****
Era il 1975 e abitavamo a Parigi da poco, X arrondissement, rue des Petits Hôtels. Avevamo lasciato l’Italia perché mio padre era stato trasferito dalla sua azienda farmaceutica. La mamma aveva accettato la Francia perché adorava i luccichii di place Vendôme e le sciccherie libertine. Era una donna elegante, religiosa, maggiorata. Amava Jane Austen e l’agio della sua Bologna. Da ragazza era emigrata a Milano per studiare e conoscere un borghese che la mantenesse mentre giurava fede al proletariato. Aveva quarantadue anni quando le uscì quella tristezza a cena. Bastò per riportarmi al trauma di un mese prima, il giorno del trasloco nella capitale francese.
Quel pomeriggio c’era Emmanuel, l’amico di famiglia. Papà era uscito per comprare un trapano e passare in azienda, io ero nella mia stanza a svuotare gli scatoloni. Mamma aveva detto che avrebbe fatto lo stesso nella sua camera, Emmanuel la aiutava con i pantaloni alle caviglie. Li avevo visti dallo spiraglio della porta. Lui in piedi con gli occhi socchiusi davanti a questa donna sposata e inginocchiata, il grande seno incagliato nel vestito. Il grande seno che sfioravo nell’abbraccio della buonanotte. Ero rimasto immobile, ero tornato in camera mia e avevo continuato a sventrare scatole finché la porta si era aperta.
– Tutto bene, amore mio? – aveva chiesto mamma con il rossetto fresco.
– Tutto bene.
Lei aveva sorriso, amara, nella stessa smorfia della cena dei cappelletti. Poi se n’era andata e solo allora mi ero accorto del gonfiore nei miei pantaloni, conteneva lo spasmo che non ero mai riuscito a sfogare. Quel giorno, per la prima volta, mi ero accarezzato e avevo intuito il movimento di liberazione. Avanti e indietro con costanza. L’inganno di mamma, l’estasi di Emmanuel. La mia gelosia. Mi ero accanito con la mano un’ultima volta, la decisiva, e solo allora avevo saputo come andava il mondo e come sarebbe andata la mia vita.
Dalla liberazione il mio carattere cambiò. Il battesimo erotico mi rese mansueto e intelligente. Mamma mi chiamava Ometto di mondo, papà diceva Cher Libero. Il Caro anteposto al nome sanciva l’entrata ufficiale nel suo circolo di attenzioni. L’equazione fu semplice: la sessualità emancipata aveva prodotto lungimiranza. Iniziai a capire la mia famiglia e il modo esatto di interpretarla. A ogni preoccupazione mi rifugiavo alla toilette e mi liberavo. Venire significava correggere le questioni interiori senza interpellare chi avrebbe dovuto educarmi. Ero un bambino autodepurato. Sereno e magnifico, attento e anticipatore. Un godimento barattava un paio di piagnistei. Ricordo alla perfezione tre elementi di quei primi autoerotismi: le guance paonazze, la fioritura del cuore e un inaspettato ribollire cerebrale. Amplessi di cinque-sei secondi mi provocavano tremori e l’assoluta convinzione che fosse solo la punta dell’iceberg. La realtà intorno a me era diversa e il mio nuovo spirito mi stava aprendo le porte dei grandi:
– Cher Libero, figliolo, ti porto al Roland Garros.
Non ho mai dimenticato il pomeriggio in cui papà mi invitò ad assistere a un match sul Centrale degli Open di Francia, privilegio che negli anni era toccato solo a Emmanuel. Aveva una camicia bianca, il panama sgualcito e due lapislazzuli opachi come occhi. Le donne lo fissavano mentre lui fissava a vuoto Björn Borg che prendeva a pallate Ivan Lendl.
– Perché non sei venuto con Emmanuel? – chiesi a bruciapelo.
Papà rimase in silenzio quel giorno e gli altri che seguirono.
Charmant, protettivo, franco. Papà era questo, secondo mamma. Glielo sentii dire alla sua amica Manuela di Milano quando le chiese perché si fosse innamorata di lui. Mancava qualcosa: era un uomo privo di senso della realtà. Il comandamento che mio padre mi diede a Deauville era figlio della sua verginità d’animo e di una sorta di presagio che percepiva nei miei confronti. Sapeva che dal trasferimento francese mi sarei potuto sentire in bilico. Non tanto per la lingua, quanto per l’affanno del cuore. Affanno che era stato anche il suo.
Lo capii con il liceo. Il primo giorno papà mi accompagnò insieme a mamma. Il Lycée Colbert l’aveva voluto lei perché pubblico, multietnico, culla della nuova classe dirigente progressista. Era una scuola bobò, bourgeois-bohème. L’entrata era di un nugolo di ragazzini con la pashmina al collo, io avevo una camicia di una taglia in più e la certezza che il posto di banco avrebbe deciso la mia adolescenza. Fu così. Dipese dall’ordine alfabetico: Libero Marsell finì tra Antoine Lorraine e Hélène Noisenau. Un nero e una biondina con la treccia e l’odore di mandarino. Le strinsi la mano per presentarmi e mi accorsi che non mi attraeva: troppo magra, troppo fresca. Mi guardai intorno, eravamo in trentatré, diciannove maschi e quattordici femmine. Scartai le troppo avvenenti, rimaneva una morettina con il sedere sporgente. Si chiamava Camille. Mi guardò una volta.
Colpivo alla prima occhiata, diventavo invisibile per il resto della storia. Dal mio banco vedevo i bobò che socializzavano e pensavo a Mario e Lorenzo che se n’erano andati insieme al Beccaria, a Milano. Rivolevo l’affidabilità gentile di Marione e la barbarie di Lorenzo. Rivolevo me stesso. Mi alzai di scatto e andai alla finestra. C’era il traffico parigino e un uomo sbilenco dall’altra parte della strada: papà. Dava uno sguardo a “L’Équipe”, e uno alle finestre della possibile classe di suo figlio.



