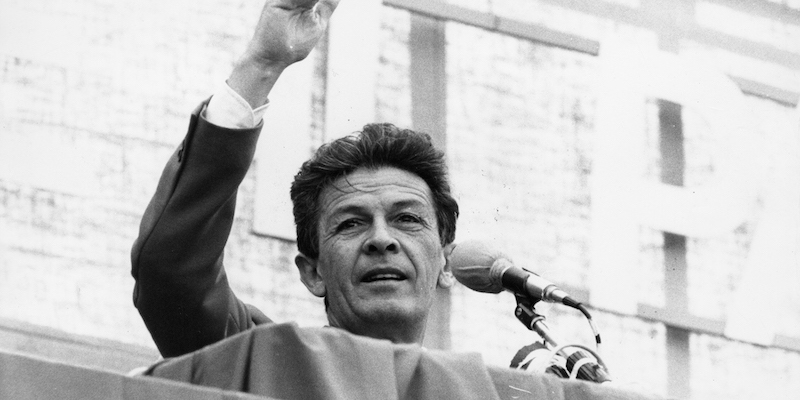Teoria e archeologia degli Hipster
Le cose da sapere su una cultura “che ora sta iniziando a tramontare", nell'ebook di Tiziano Bonini
di Tiziano Bonini
Le edizioni Doppiozero hanno pubblicato un ebook di Tiziano Bonini dedicato alla cultura e allo stile “Hipster”, al ricostruirne la storia del secolo scorso e i ritorni recenti: «L’hipster è di sicuro la cultura giovanile dominante degli anni Zero del Duemila e ora che sta iniziando a tramontare, possiamo finalmente cercare di capirci qualcosa», scrive Bonini. Il libro si intitola semplicemente Hipster e si può scaricare qui al prezzo di 3 euro.
*****
La prima volta che ho sentito la parola hipster è stato durante una vacanza a New York, nel 2003, dopo che il mio “lavoro” (mia madre non l’ha mai accettato come tale) di studente di dottorato mi aveva portato vicino Chicago per un convegno. Ero ospite di un amico di un’amica di mia sorella in una casa di Brooklyn dove il tassista, quando mi riportava a casa, aspettava che fossi entrato prima di ripartire, perché la zona, dopo le dieci di sera, non era per niente tranquilla.
Quella parte di Brooklyn (tra Bedford Avenue e Dean Street) era all’epoca abitata da comunità caraibiche, arabe e afroamericane assieme. Ero lì il giorno che ci fu il blackout di tutta la costa orientale, il 14 agosto 2003 e ricordo venditori di ghiaccio improvvisati per la strada e giocatori di basket al chiaro di luna, tossici agli incroci a dirigere il traffico e vecchi con le radioline a transistor alle orecchie per capire cosa stava succedendo. Dividevo l’appartamento con un barista gay di Time Square che sognava di fare l’attore e una deliziosa ragazza di Los Angeles che diceva di cercare lavoro ma stava tutto il giorno barricata in casa a guardare e riguardare Il Signore degli Anelli. Fu lei che una volta, mentre stavo uscendo di casa, mi disse che le sembravo un hipster, per via dei miei jeans rovinati e della giacca leggera a quadretti che portavo. Io non sapevo che cosa fosse un hipster e ci rimasi male, perché mi vestivo così solo perché, da bravo provinciale, avevo paura di dare nell’occhio. Lei mi rispose che erano quei bianchi che si vestivano un po’ bohémien per somigliare a un musicista jazz afroamericano. Ci rimasi male, perché sembrava che l’avesse detto con un certo tono di rimprovero, come se volessi passare per qualcosa che non ero. Non diventammo mai amici, in quei venti giorni di coabitazione.
La mia coinquilina mi aveva dato la giusta definizione di hipster, quella originale. Ma nel 2003, negli Stati Uniti, già si aggiravano i primi, nuovi hipster. All’epoca non lo sapevo, ma i giovani con le bici a scatto fisso e le barbe lunghe visti a Williamsburg qualche giorno prima, erano già i primi coloni dell’hipsterismo che sarebbe dilagato negli anni successivi. Quando il mio amico americano, Nicholas, mi aveva portato a mangiare in un ristorante messicano di Williamsburg la domenica prima della mia partenza, il quartiere era ancora un ammasso di magazzini abitato dai primi artisti e studenti squattrinati che avevano trovato in Williamsburg un rifugio più economico di Manhattan.
Se fate una ricerca su Google Ngram Viewer scoprirete che la parola ‘hipster’ inizia a comparire nei testi americani dopo il 1940 e subisce un’impennata nella frequenza d’uso tra il 1950 e il 1970, dopodiché cade nel dimenticatoio, surclassata dalla caduta del muro, dall’ascesa degli yuppies e della cocaina. Poi però la parola riprende inaspettatamente quota e torna di moda a fine degli anni ‘90 ed esplode nell’uso comune tra il 2003 e il 2010, diventando un concetto-ombrello usato a sproposito, per lo più in senso dispregiativo, per bollare qualsiasi comportamento giovanile vagamente affettato e fintamente contro-culturale.
Soprattutto la popolarità del termine è dovuta allo stile di abbigliamento che identifica l’hipster contemporaneo: occhiali dalla montatura spessa, barbe incolte e baffi curati, meglio se all’insù stile Cecco-Beppe, maglietta a strisce orizzontali, sciarpe anche d’estate, bicicletta a scatto fisso, accessori vari, passione nostalgica per tutti i media analogici del passato, dal vinile al super8 alle polaroid, meglio se remixati in una app per smartphone.
Una classe di curatori/creativi, come la definisce il più importante critico musicale vivente, Simon Reynolds, “che lavorano in settori come l’Information Technology, i media, la moda, il design, l’arte, la musica e altre industrie dell’estetica. Una classe di quasi creativi – spregiativamente nota come hipster – rintracciabile in qualsiasi città del mondo sviluppato abbastanza grande e ricca da sostenere un’alta borghesia degna di questo nome (…) La posizione geografica non conta più: i membri dell’Internazionale Hipster si somigliano l’un l’altro più di quanto non somiglino a coloro ai quali abitano fisicamente vicino.
Il giovane scrittore canadese Douglas Haddow scrive ironicamente nel 2008 sulla rivista di critica culturale Adbusters che la recente diffusione dello stile hipster rappresenta la fine della civiltà occidentale:
Da quando gli Alleati bombardarono i paesi dell’Asse fino a sconfiggerli, la società occidentale ha visto emergere una successione di movimenti controculturali che hanno energicamente sfidato lo status quo. In ogni decade successiva alla seconda guerra mondiale si sono susseguiti movimenti che hanno rimesso in discussione gli standard sociali e dato vita a scontri e lotte che hanno rivoluzionato ogni aspetto della musica, dell’arte, della politica e della società civile. Ma dopo che il punk è stato assorbito e plastificato nella moda e che l’hip hop ha perso il suo originale impeto radicato nella richiesta di cambiamento sociale, tutte le precedenti spinte subculturali si sono fuse assieme. Ora si sta affermando un nuovo stile, mutante, trasversale, transatlantico. Un melting pot di stili, gusti e comportamenti che va genericamente sotto il nome di stile ‘hipster’. Lo stile hipster ha operato un’appropriazione artificiale di stili differenti, provenienti da epoche differenti. L’hipsterismo è lo stile caratteristico della fine dell’occidente – una cultura persa nella riedizione superficiale del proprio passato, incapace di creare qualcosa di nuovo. Non è soltanto insostenibile, ma suicida. Mentre i precedenti movimenti giovanili hanno sfidato e criticato la disfunzione e la decadenza delle generazioni più vecchie, oggi abbiamo l’hipster, una subcultura giovanile che rispecchia la superficialità destinata alla morte della nostra società.
(…) Forse è solo una fase della cultura occidentale di inizio millennio e non esattamente la fine della civiltà occidentale, ma chi può dirlo?
In questa fase gli hipster sono riconosciuti come quelli che si attribuiscono il merito di aver scoperto una nuova tendenza culturale per primi. Sono gli early adopter della società dei consumi. L’orgoglio proviene dal saper decidere cosa è cool in anticipo sul resto della società, non più, come accadeva negli anni ‘50, dove l’orgoglio hipster risiedeva nell’adozione del be bop sperimentale come forma di resistenza al conformismo culturale dell’epoca. Eppure, dietro l’hipster contemporaneo, c’è la stessa voglia di riscatto sociale che animava l’hipster americano: entrambi sono outsider della società, che si costruiscono uno stile personale di consumo culturale per distinguersi dal resto della società e attribuirsi un nuovo ruolo sociale. In qualche modo, entrambi sono motore di ibridazioni culturali, solo che nel secondo caso, gli stili adottati dagli hipster sono stati subito intercettati dalla moda e dalla società dei consumi, impacchettati e brandizzati.
L’hipsterismo è il mezzo che i mass media hanno utilizzato per rendere desiderabili nuovi trend indirizzati alla cultura pop giovanile. Gli hipster sono generalmente studenti di college o laureati ma non appartengono a nessuna specifica classe economica. Negli Stati Uniti, hipster e hip hop sono le due culture dominanti alle quali aspirano tutti i giovani in preda ad angosce adolescenziali. Gli hipster sono nichilisti. Amano il kitsch, perché ammirando l’assurdo e le cose vecchie rinforzano la legittimità della loro eccentricità. Invece di fare delle cose ed avere delle passioni dettate dalla propria identità, al contrario è l’identità dell’hipster a costruirsi intorno a ciò che fa e a ciò che consuma. Questo comportamento è particolarmente importante per il marketing dei brand, perché quando un prodotto viene scelto dagli hipster acquisisce immediatamente maggior valore e desiderabilità nel resto della popolazione. L’hipster è la quintessenza del consumatore moderno.
L’anti-conformismo del bianco-negro americano, esistenzialista e nichilista, disilluso e borderline dell’hipster originale è stato completamente assorbito dalla società dei consumi e restituito slavato e senza vigore, sotto forma di filtro vintage Instagram. La storia si ripete sempre due volte, la seconda in forma di farsa. Il secondo hipster della Storia è una farsa, un fake, una versione annacquata dell’originale. Se l’hipster bianco guardava con nostalgia ai neri americani, l’hipster contemporaneo guarda con nostalgia a tutto quello che rappresenta il passato. Nonostante sia contornato dai gadget tecnologici più avanzati, l’hipster volge con malinconia lo sguardo al mondo analogico degli amplificatori in legno di una volta, alle radio a manopola, alle macchine fotografiche con il rullino scovate in qualche mercatino delle pulci di Berlino o più facilmente su Ebay. L’hipster è ossessionato dalla ricerca dell’autenticità: nella musica, nelle relazioni, negli oggetti di design, nel cibo. Nella musica questa ricerca dell’autenticità si traduce ad esempio in un ritorno del vinile e del suono analogico. Le vendite di dischi in vinile negli Stati Uniti sono passate da mezzo milione nel 1993 a un milione nel 2007, per poi subire un’accelerazione negli ultimi cinque anni, raggiungendo 6 milioni di vendite nel 2013. Il ritorno del vinile è decisamente un sottoprodotto della smania di autenticità neo-hipster. Anche la passione per i cibi organici e a chilometro zero ha la stessa radice: tutto quello che sembra autentico è apprezzato, ha valore, è ricercato. L’hipster, così fragilmente alla ricerca della propria autenticità e così in dubbio sulla propria autenticità, si rassicura acquistando e facendo sfoggio di prodotti autentici. L’hipster non a caso è la maggiore espressione culturale della generazione degli anni zero, perché questa generazione cresce in un’insicurezza mai provata prima dalle generazioni precedenti. Precaria nel lavoro, digitalizzata nelle relazioni sociali, questa generazione ha bisogno, anche solo simbolicamente, di ritrovare l’autenticità delle cose.
Il più lucido e attento studioso di questo ritorno dell’hipsteria, è il critico letterario americano Mark Greif, professore associato della New School University di New York. Greif, fondatore insieme a Keith Gessen (giovane scrittore americano autore di un brillante romanzo d’esordio, Tutti gli intellettuali giovani e tristi, 2010) della rivista letteraria «n+1», ha scritto nel 2010 un paio di articoli lunghi per il New York Times che lo fanno assomigliare al Norman Mailer di White Negro, The Hipster in the mirror e What was the hipster. E qui dovrò riportare un lungo estratto preso dagli articoli di Greif, perché è inutile tentare di scriverlo diversamente:
Gli hipster sono una subcultura di uomini e donne tipicamente ventitrentenni che danno molto valore al pensiero indipendente, alla controcultura, alla politica progressista, apprezzano l’arte e l’indie-rock, la creatività e l’intelligenza. Le più grandi concentrazioni di hipster le ritroviamo nei quartieri di Williamsburg (New York), Wicker Park (Chicago) e la Mission (San Francisco). Sebbene l’“hipsterismo” sia uno stato mentale, è facilmente distinguibile per la sua sensibilità verso la moda. Gli hipster rifiutano l’ignoranza culturale dei consumatori mainstream, e vestono abiti vintage raffinati, oppure jeans stretti e vecchie sneakers, occhiali con la montatura spessa. Sia gli uomini che le donne hanno tagli di capelli simili, un po’ androgini e dal taglio asimmetrico. Questi stili sono associati ai barbieri creativi dei centri urbani, di solito troppo estremi per il consumatore mainstream. Lo stile “cool” ma “senza alcuno sforzo” dell’hipster è rappresentato dagli spot e dalle pubblicità dei marchi Urban Outfitters, American Apparel, Woolrich, che hanno gli hipster come target. (…) Un mito dell’hipster è che non c’è definizione per l’hipster. Nell’agosto del 2010, dopo aver calcolato che il New York Times aveva usato la parola “hipster” in più di 250 occasioni nell’ultimo anno, Philip Corbett, il responsabile della grammatica del giornale, scrisse una lettera aperta alla redazione per chiedere di fare attenzione ad un uso eccessivo della parola, perché non se ne conosceva ancora il significato preciso. Eppure sappiamo benissimo cosa significhi. Più andiamo avanti senza definirlo e più rimarremo alla mercé della sua magia. (…) quando parliamo dell’hipster contemporaneo intendiamo una figura subculturale emersa nel 1999 e rimasta sottotraccia fino al 2003 per poi esplodere e guadagnare popolarità dal 2004 fino ad oggi. La matrice dalla quale è emerso l’hipster contemporaneo include la dimensione della cultura giovanile degli anni ‘90, spesso chiamata “alternativa” o “indie”, che si autodefiniva in funzione anti-consumista. (…) Tuttavia, in un’etnografia di Wicker Park negli anni ‘90 il sociologo Richard Lloyd documentò il modo in cui quella che lui chiamava “neo-bohemia” si era trasformata in qualcos’altro: il brodo culturale da cui nacque l’hipsterismo post 1999. Lloyd mostrò come la cultura di aspiranti artisti che avevano lavori precari come baristi e camerieri nei maggiori centri urbani del paese, potevano inintenzionalmente fornire la base per un nuovo stile di consumo tardo-capitalista. (…) I quartieri neo-bohémien confinanti con le zone più ricche dove vivevano i nuovi benestanti dei centri finanziari, si trasformarono presto in quartieri del divertimento e industrie del tempo libero per i nuovi giovani ricchi delle nuove classi creative legate al design, al web e al marketing. I bohémien indie (denigrati in “slackers”) incontrarono i proto miliardari delle dot.com (denigrati in “yuppies”) e da questo mix nacque qualcosa di imprevisto: il nuovo hipster. Il Lower East Side e Williamsburg a New York, Capitol Hill a Seattle, Silver Lake ad L.A., la Mission a San Francisco, è qui che i primi hipster hanno germogliato. Negli anni, in quei quartieri ha preso piede un vero e proprio stile hipster e un tipo d’arte che alla fine è diventato un vero e proprio stile e un modo di vita.
L’hipster contemporaneo quindi, sostiene Greif, è un ibrido nato da un incrocio culturale tra i bohémien imbevuti dell’indie-rock degli anni ‘90 (Nirvana e Pearl Jam i riferimenti più “mainstream”, The Neutral Milk Hotel e i Pavement quelli più colti) e le emergenti classi creative dell’economia digitale. L’hipster “è quella persona”, prosegue Greif, “a cavallo tra il neobohémien, il vegano, il ciclista militante o lo skater-punk, il vorrei-essereun-impiegato-in-una-start-up, il ventenne post-razziale, l’artista povero in canna o lo studente appena laureato che nei fatti si posiziona tra consumi subculturali alternativi e anticonformisti e la fascinazione per le classi dominanti e quindi conduce una vita velenosamente divisa tra i due poli, quello subculturale e quello dominante”.
Gli hipster sono tendenzialmente altamente scolarizzati, sia in carriere artistiche che in matematica e scienza, ovunque ci sia bisogno di un po’ di creatività. Secondo l’influente (e anche molto controverso) sociologo americano Richard Florida, il lavoro creativo ha a che fare con persone che lavorano nel design, nell’istruzione, nelle arti, nell’industria della musica e dell’intrattenimento, la cui funzione economica è quella di creare nuove idee, nuova tecnologia o nuovi contenuti creativi. Secondo Greif, la convergenza di classe creativa, bohémien indie e geek californiani ha dato vita alla nuova cultura hipster americana.
(…) Gli artisti di riferimento per questa subcultura in fragile equilibrio tra underground e mainstream, secondo Greif, sono i primi lavori dello scrittore Dave Eggers e Wes Anderson, regista di Rushmore (1998) e The Royal Tenenbaums (2001).
La serie televisiva che meglio descrive la cultura hipster si chiama Portlandia, è nata nel 2011, è scritta dalla coppia comica Armisen e Brownstein (ex chitarrista di un gruppo indie femminile) ed è girata a Portland, capitale dell’Oregon non lontana da Seattle. La serie è una parodia dello stile hipster, o, come l’ha definita la giornalista del Guardian Sian Rowe, “Portlandia è la capitale del muesli, un posto dove essere artigiani è una religione e cucinare a qualcuno un dolce vegano vale tanto quanto praticargli un cunnilingus”. I due autori hanno scelto Portland per la sua abbondanza di attivisti ecologisti estremisti, militanti femministe e artisti eccentrici, ma la serie poteva benissimo essere ambientata ad Austin in Texas, a Williamsburg, Brooklyn o a La mission, San Francisco o in qualsiasi altro posto dove band rock mai sentite sono trattate come divinità e dove se qualcosa non è organico allora è di sicuro spazzatura. Nella musica, oltre all’eredità dell’indie anni ‘90 si sono aggiunti i nuovi cantautori folk americani come Bright Eyes, Sufjan Stevens, Joanna Newsom, i Fleet Foxes e Bon Iver, tra i più recenti e popolari. La musica hipster non è un genere musicale, ma un insieme di generi che tiene insieme l’indie-rock con l’elettronica, il neo-folk, il revival dei synt anni ‘80 con il remix di musicisti blues maliani come Bombino da parte dei Black Keys e suonatori di matrimoni siriani come Suleyman da parte del compositore inglese di musica elettronica Four Tet. La musica indie sta all’hipster contemporaneo come il jazz stava all’hipster bianco degli anni ‘50. Il jazz rappresentava la vitalità della cultura nera, secondo Mailer. La passione del nuovo hipster per la musica indie è un’ulteriore manifestazione della sua paura di scomparire nella massa, di conformarsi. L’hipster è sempre stato un anticonformista, solo che ora è molto più difficile essere anticonformisti in una società complessa dove i brand trasformano ogni forma di ribellione in bene di consumo. L’hipster di Norman Mailer era un vero ribelle, psicopatico, cinico anticonformista. L’hipster di oggi vorrebbe essere un anticonformista ma non ci riesce, perché cresciuto negli anni ‘80, e sublima la sua ribellione attraverso il consumo di musica indipendente, film indipendenti, oggetti di design unici, riviste underground.
Il mezzo di comunicazione che ha contribuito più di tutti a diffondere il verbo hipster è il giornale di critica musicale online «Pitchfork». Vale la pena soffermarci sulla storia di questa rivista online, perché dimostra come oggi la circolazione di idee non passi più soltanto dai tradizionali canali broadcast: anche una piccola fanzine nata da un solo studente può diventare un medium di comunicazione di massa, fare la fortuna di un gruppo musicale e cambiare i gusti di milioni di persone.
«Pitchfork» fu creata a Minneapolis in Minnesota nel 1995 da Ryan Schreiber, quando aveva appena terminato la scuola superiore. Ryan non era un esperto in giornalismo ma era un fanatico della musica indipendente che leggeva nelle fanzines locali e ascoltava passare dalla radio universitaria KUOM. Il nome iniziale del sito era «Turntable» e veniva aggiornato mensilmente con interviste e recensioni. Nel maggio del 1996 il sito si trasferì sotto il dominio di PitchforkMedia.com e cominciò a essere quotidianamente aggiornato. Da lì in avanti, la sua popolarità iniziò a crescere costantemente fino a diventare un mezzo d’informazione globale nei primi anni duemila.
All’inizio del 1999 Ryan Schreiber sposta la sede principale da Minneapolis a Chicago nell’Illinois. Da allora il sito è stato ampliato fino a pubblicare quattro recensioni al giorno, insieme a interviste e altre funzionalità. Ha così cominciato a raccogliere seguito e consensi grazie agli approfondimenti sulla musica alternativa e allo stile di scrittura, libero dai canoni delle riviste cartacee. Oggi conta un milione e mezzo di lettori al mese da tutto il mondo.
«The Washington Post» ha considerato «Pitchfork» uno dei maggiori responsabili del successo di band come Arcade Fire, Broken Social Scene, Clap Your Hands Say Yeah, Vampire Weekend.
Gli Arcade Fire sono una delle band più citate per aver tratto beneficio da una recensione di «Pitchfork». Nel 2005 un impiegato dell’etichetta indipendente del gruppo la Merge Records ha affermato: “Dopo la recensione di «Pitchfork», Funeral fu stampato per un’intera settimana perché avevamo molti ordini per l’album”. Lee Sargent membro dei Clap Your Hands Say Yeah ha discusso sull’impatto che «Pitchfork» ha avuto sul loro album, dicendo: “Il fatto che una pubblicazione come «Pitchfork» possa decidere quando può accadere [il successo], sai cosa significa? Loro possono dire: ‘Abbiamo intenzione di velocizzare il processo e questo accadrà…Ora!’ E questo per noi è stato un calcio nel sedere, perché abbiamo perso il controllo di tutto”69. Anche il song writer e cantante americano Bon Iver è stato catapultato nel mainstream e notato dalla critica per la prima volta dopo la prima recensione uscita su «Pitchfork» nel 2007, per l’album For Emma, Forever Ago. «Pitchfork» fu l’unica rivista a includere questo disco nella top list di fine anno. Nel 2011 invece ha assegnato al nuovo disco di Bon Iver il titolo di miglior disco dell’anno. Molti hanno attribuito l’ascesa di Bon Iver alla popolarità guadagnata su «Pitchfork», che è culminata nella vittoria di un Grammy Award come miglior artista emergente e nella nomina a Persona dell’anno 2012 da parte di «Time».
La consacrazione dello stile hipster nella musica avviene il 10 gennaio 2010, quando il secondo album dei Vampire Weekend, Contra, raggiunge il primo posto nella classifica dei dischi venduti secondo la prestigiosa rivista americana «Billboard». È la prima volta in 19 anni che un album pubblicato da un’etichetta indipendente raggiunge la vetta di questa classifica. I Vampire Weekend sono il gruppo hipster perfetto: il suo leader, Ezra Koenig, e gli altri componenti del gruppo, sono appena usciti dalla Columbia, sono giovani, carini e disoccupati e si vestono come degli hipster. Fondano la band nel 2006 e hanno successo immediato e meritato. La loro musica mescola il punk dei Clash al tropicalismo, l’afro-beat degli anni settanta a quella barocca e da camera, mentre la voce e le melodie ricordano il pop di Paul Simon. È una musica fatta, come sostiene Reynolds, da musicisti/curatori, che più che produrre nuovi suoni producono un commento creativo alla musica del passato con la quale sono cresciuti.